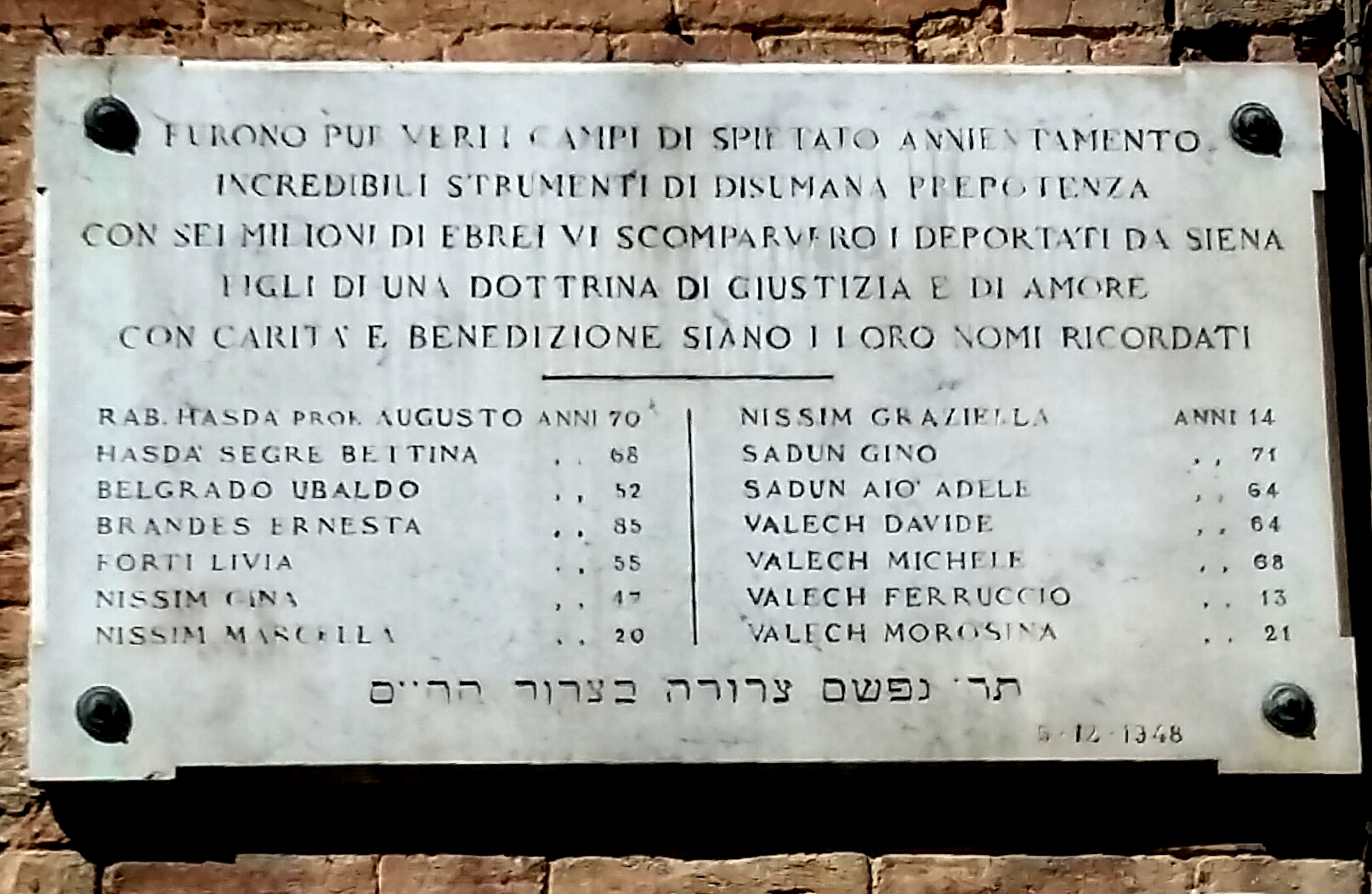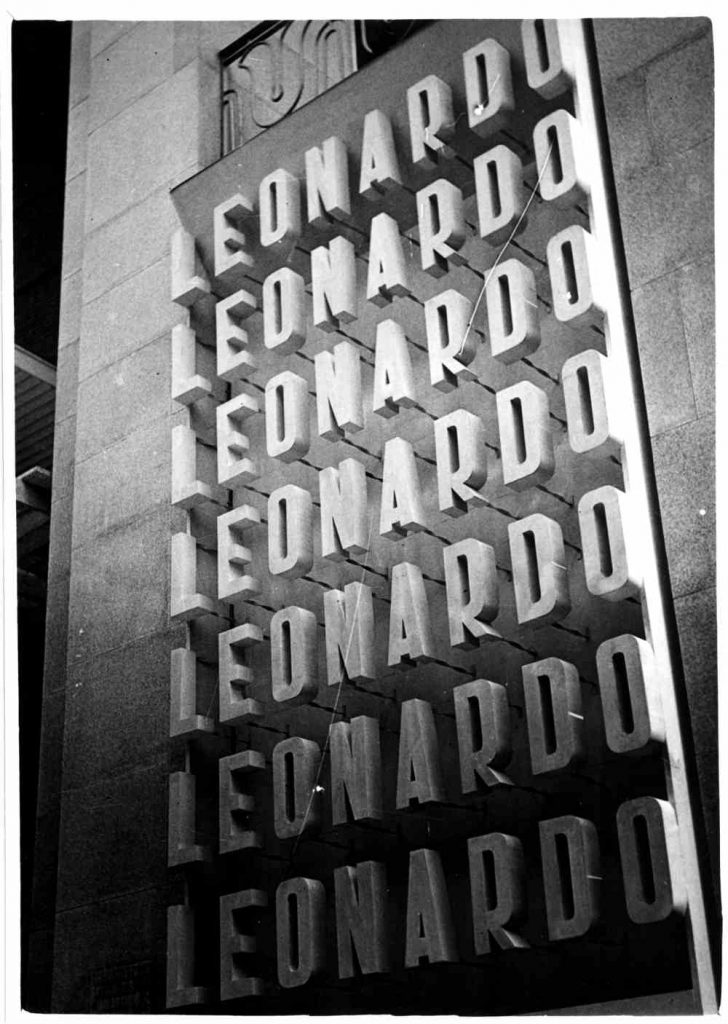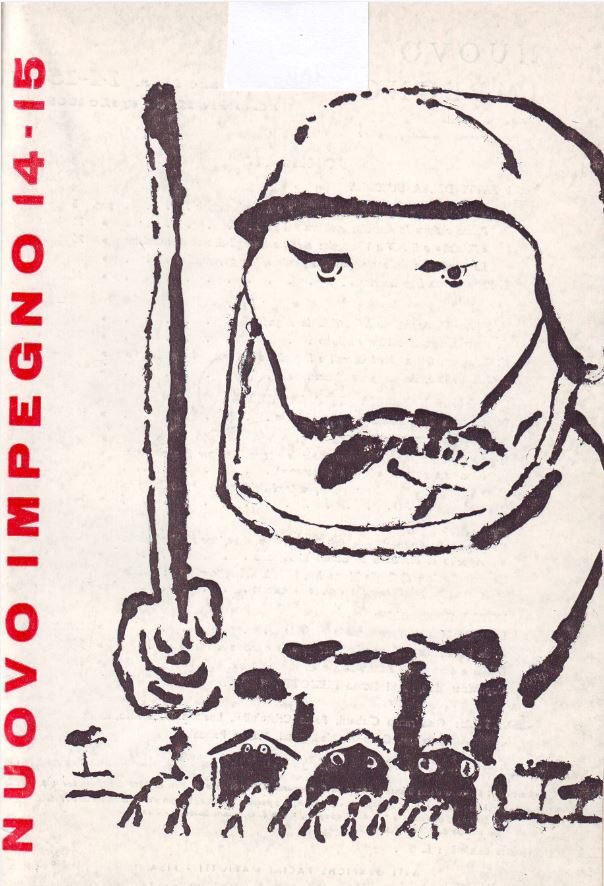Una Toscana fascistissima?

L’11 novembre 2019, presso l’Archivio di Stato di Prato, Alessandro Bicci e Marco Palla hanno presentato il volume di Andrea Giaconi intitolato La fascistissima. Il fascismo in Toscana dalla marcia alla notte di San Bartolomeo. In quell’occasione abbiamo rivolto alcune domande all’autore: proponiamo il testo dell’intervista ai lettori di ToscanaNovecento.
Ha senso parlare di un “fascismo toscano”? Il fascismo ebbe cioè nella regione dei tratti distintivi, in parte diversi da quelli che il movimento presentava a livello nazionale?
Parlare di “fascismo toscano” ha senso nella misura in cui si voglia da una parte sottolineare il ruolo primario svolto dalla Toscana nella conquista e nel mantenimento del potere da parte del fascismo; dall’altra esaltare alcuni tratti che indubbiamente furono comuni all’intera regione. La realtà fascista toscana si distinse sia per una nascita tarda del movimento ma anche per una sua tanto rapida quanto violenta ascesa che nel giro di pochi mesi (tra il dicembre 1920 e il marzo 1921) portò a raddoppiare i fasci e quintuplicare gli iscritti. Fu quello toscano un fascismo “insonne”, combattente, che si segnalò soprattutto come componente essenziale nella scalata al potere del biennio 1921-1922, carico di tutti i miti e i riti squadristi volti a fomentare la violenza contro le opposizioni e a rinsaldare la retorica poi divenuta componente essenziale nel consolidamento del regime. In tal contesto, la regione si allontana soprattutto da realtà (soprattutto nell’Italia meridionale) in cui il fascismo quale fenomeno di massa è un elemento successivo alla marcia dell’ottobre 1922. Eppure, a ben vedere, piuttosto che di “fascismo toscano” è forse più esatto parlare di “fascismo in Toscana”. Toscana che fu, infatti, contenitore di manifestazioni del fascismo tra loro tanto vicine quanto distinte. La non uniformità corografica, economica e sociale della regione si riflesse in una difformità politica che dette vita ad esperienze tra loro assai diverse. Così come la grande mezzadria conviveva con la piccola proprietà e le significative realtà industriali, egualmente la supremazia di ras come Renato Ricci (Carrara) e Carlo Scorza (Lucca) si affiancava ad aree in cui il PNF fu attraversato da vibranti lotte per la conquista della leadership locale (che molto spesso ponevano di fronte opposte visioni del movimento) dalle quali seppero avvantaggiarsi protagonisti (Ciano a Livorno, Sarrocchi a Siena) non immediatamente assimilabili al movimento della prima ora. Infine vi furono pure zone (Prato, Grosseto) in cui larga parte del fascismo fu riassorbita nell’orbita del servilismo agli agrari e all’imprenditoria industriale.
Gli industriali e gli agrari toscani appoggiarono senza riserve il movimento fascista durante il cosiddetto “biennio nero” (1921-22) o è necessario articolare meglio il discorso?
Sicuramente la quasi totalità di industriali e agrari appoggiò il movimento negli anni precedenti alla conquista del potere vedendolo come necessario strumento di repressione contro le richieste provenienti dalle organizzazioni operaie e mezzadrili e dalle organizzazioni tanto socialiste (e poi anche comuniste) quanto cattoliche. Tuttavia, la stessa retorica “rivoluzionaria” della “prima ora” mal si conciliava con le intenzioni di restaurazione dell’ordine (sociale prima ancora che politico) del notabilato e della grande imprenditoria. Ne conseguì un progressivo avvicinamento alle gerarchie di partito e l’istituzione di un sistema clientelare volto ad emarginare l’elemento più sincero del movimento fascista delle origini e delle forze che ne avevano appoggiato la carica radicale attraverso un connubio tra antiche classi dirigenti, le frange più corruttibili del partito e comunque caratterizzate da una pronunciata vena d’arrivismo e una cospicua componente criminale.
Quali furono i rapporti fra la massoneria toscana ed il fascismo locale, prima e dopo la marcia su Roma?
Pur distinguendo tra le due principali obbedienze, la massoneria tout court fu uno dei principali punti d’appoggio del fascismo antemarcia. Si può anzi sicuramente affermare che tanto Palazzo Giustiniani (salvo tanto isolate quanto eclatanti eccezioni, come il pratese Giuseppe Meoni, Gran Maestro Aggiunto) quanto Piazza del Gesù fiancheggiarono e finanziarono il fascismo nello stesso evento della Marcia. Di fatto, la visione delle massonerie fu offuscata dalle dinamiche successive al dopoguerra, quando dinanzi alle rivolte del “biennio rosso”, esse intravidero nel fascismo una forza radicale capace di riportare un ordine democratico comunque lontano dalle precedenti consorterie. Fu un tragico equivoco di cui si ravvidero solo dopo l’ottobre 1922 e ancor di più, dopo il febbraio 1923, con la dichiarazione d’incompatibilità tra fascismo e massoneria. Da allora le strade si divisero. Il fascismo tese ad emarginare e ad epurare le proprie componenti massoniche o le obbligò a ripudiare l’istituzione. Dinnanzi a ciò il Grande Oriente si pose progressivamente in opposizione al Partito fascista. La Gran Loggia, almeno nei suoi vertici, si attestò (pur non mancando isolati casi di resistenza) in un piatto ossequio al regime. Ma egualmente non si può ridurre il rapporto tra massoneria e fascismo ad uno scontro tra partito e istituzione. Di fatto, il vincolo massonico (almeno per il fascismo toscano) fu una delle corde sulle quali vibrarono più fortemente le tensioni interne al partito, per l’imposizione di una propria visione politica o anche per la più gretta conquista del potere. Sotto questa prospettiva potevano essere letti gli scontri tra Enrico Spinelli e Dino Philipson (Pistoia), tra Tullio Tamburini e Dino Perrone Compagni (Firenze), tra Bruno Santini e Filippo Morghen (Pisa), tra Dario Lupi e Alfredo Frilli (Arezzo). Le lotte tra obbedienze, la carica antimassonica del partito e la coerenza liberomuratoria, con i dettati della “prima ora”, furono forse i principali motori delle lotte intestine al PNF. Non a caso, la piena normalizzazione e acquiescenza alle direttive del partito si realizza con atti di violenza contro la massoneria, quali le spedizioni squadriste della “notte di San Bartolomeo” (ottobre 1925).
E quale fu l’atteggiamento della chiesa?
È ormai noto da tempo come il fascismo adoperasse una distinzione tra struttura ecclesiastica e movimento cattolico. Laddove l’associazionismo bianco era forte e ben radicato (Lucchesia, in alcune zone del Pistoiese e dell’Aretino…), il fascismo non esitò ad utilizzare qualsiasi mezzo per disarticolarne la struttura. Ben diverso era l’atteggiamento verso la gerarchia ecclesiastica, intesa come possibile punto d’appoggio e fattore di legittimazione del regime anche a livello locale. Eppure, non mancarono casi di vescovi toscani come il pistoiese Gabriele Vettori che denunciò le violenze squadriste. Non fu un fatto limitato alla gerarchia: molti parroci si schierarono contro le azioni squadriste e, per questo, ne furono bersagli. Basti pensare che, nei tre mesi precedenti alle elezioni politiche del 1924 quasi quaranta furono i parroci aggrediti tra la Lucchesia e il Pistoiese.
Antonio Gramsci ha individuato nella mobilitazione violenta della piccola borghesia contro il proletariato l’elemento caratterizzante del fascismo. Questa analisi è valida anche per la Toscana?
Questo può essere valido solo in parte. Basti pensare che quasi il 40% degli iscritti ai fasci di combattimento era costituito da lavoratori della terra e dell’industria e che un campione di marciatori toscani su Roma ricavato da pubblicazioni coeve abbassa tale percentuale non di molto. Vero è che le cifre si modificarono abbastanza rapidamente quando, una volta al potere, il fascismo si trovò a gestire la redistribuzione dei poteri anche a livello locale. Significativa è infatti la composizione dei primi sindaci fascisti, laddove circa la metà degli eletti (49%) era formata da possidenti e nobili. Si andava così assistendo quasi a un ritorno dei potentati terrieri in un negoziato tra antiche gerarchie e nuovi regimi. Ne riuscivano bilanciamenti dai quali vennero progressivamente escluse le forze riformiste e radicali che pure erano entrate nel “calderone” del primo fascismo (ed ovviamente le organizzazioni “rosse” e “bianche” che al fascismo si erano opposte). Emersero invece il grande interesse, l’opportunismo e, in parte, l’elemento criminogeno e criminale (quest’ultimo poi parzialmente estromesso a seguito della linea epurativa guidata da Augusto Turati successivamente alla “notte di San Bartolomeo”, dell’ottobre 1925).
Nella primavera del 1921 un foglio comunista fiorentino ravvisò nei fascisti del Carmignanese “tutta la delinquenza del vasto comune di campagna, assoldata dalla borghesia terriera locale” (L’azione comunista, 21 maggio 1921). Puoi dirci qualcosa a proposito del ruolo dell’elemento criminale all’interno del movimento fascista nella regione?
L’elemento criminale fu una componente che sempre caratterizzò lo squadrismo fascista, prima convivendo con gruppi formatisi in opposizione alle rivolte del cosiddetto “biennio rosso”, ma con sinceri intendimenti radicali e di ritorno all’ordine (ne fu un esempio l’ex-combattente Bruno Santini a Pisa), poi assumendo una rilevanza che fu alla base dei potentati dei ras, delle lotte interne al PNF per la conquista del potere locale, della seconda violenta ondata squadrista. Per comprenderne la consistenza che aveva assunto in alcune zone, basti citare un dato relativo all’adunata squadrista svoltasi nella violenza a Firenze nel dicembre 1924. Su 3.000 fascisti provenienti da Lucca, l’allora prefetto locale Enrico Cavalieri segnalava il coinvolgimento «in atti criminali anche comuni» per «almeno la buona metà» di essi.
Il fascismo fiorentino era diviso in due filoni, spesso in contrasto fra loro. Uno faceva capo a Dino Perrone Compagni, l’altro a Tullio Tamburini. Quali erano le principali differenze fra queste due correnti?
La divisione tra Perrone Compagni e Tamburini può essere in larga parte circoscritta a una lotta per la conquista del potere locale. Fascinazioni per le quali le rispettive iscrizioni alle obbedienze massoniche potevano dar adito a uno scontro tra ordini libero-muratori deve necessariamente rimanere sullo sfondo (tant’è che lo stesso Tamburini sarebbe divenuto tristemente famoso per le violenze utilizzate sui suoi stessi “fratelli”). Di fatto, i due schieramenti potevano essere assimilati alle “bande criminali” in lotta per il controllo di un territorio. Il fascismo fiorentino poteva segnalarsi per la propria inquietudine, per gli scontri e per le divisioni interne alle proprie file già nel biennio 1921-1922. Era questo un periodo che vide anche la compresenza di tre fasci fiorentini di cui uno ufficiale e due autonomi. Di questi ultimi due, uno poteva addirittura contare più iscritti del fascio ufficiale. Il prosieguo di tali divisioni doveva molto alla mancata rassegnazione alla sconfitta dei leaders fascisti perdenti. Sicuramente ciò vale per Perrone Compagni, il cui avvicinamento a gruppi dissidenti come la nota “Banda dello sgombero” o all’esperienza dei Fasci nazionali, deve necessariamente essere letta quale sostegno all’azione antitamburiniana in prospettiva di un ritorno al potere.
Tullio Tamburini era un pratese. Cominciò la sua carriera come squadrista e la concluse come capo della polizia della Repubblica di Salò. Vuoi parlarci brevemente di lui?
Di Tamburini, nato a Vaiano, allora frazione del comune di Prato, hanno scritto diffusamente molti storici del fascismo, eppure ancora oggi manca una biografia che ne inquadri il percorso. Già membro attivo dell’interventismo pratese al tempo della guerra di Libia, ex impiegato alla Forti, grande industria tessile della Valle del Bisenzio, si era ridotto a vivere d’espedienti. Nota è la sua attività di calligrafo, creando biglietti da visita o per eventi quali nozze e battesimi. Combattente decorato durante il primo conflitto mondiale, fu segnalato per furto e appropriazione indebita. Si evince sin da ora come Tamburini fosse un personaggio per lo meno contiguo all’elemento criminale dal quale il fascismo attinse una parte non trascurabile dei propri appartenenti. Iscrittosi al fascio di combattimento fiorentino già nel 1919, egli fu protagonista della scissione tra i due fasci fiorentini, divenendo uno dei più diretti responsabili delle violenze che imperversarono tra il 1921-1922. Espulso per indisciplina nel marzo 1922 dal PNF, non tardò a rientrarvi, guidando la piazza di Firenze nei giorni della Marcia e dirigendosi egli stesso a Roma a capo della prima legione fiorentina. Negli anni seguenti Tamburini fu, nonostante le frizioni con Perrone Compagni, a capo del fascismo fiorentino, gestendo le reti delle bische clandestine e di altre attività criminose nel capoluogo toscano. Lo fece attraverso la violenza e legami clientelari che gli permisero di uscire indenne dagli scontri interni al fascismo fino almeno al 1925. Di questi anni sono per lo meno da ricordare le violente spedizioni del dicembre 1924 e dell’ottobre 1925. Quest’ultima, di carattere ferocemente antimassonico, fu identificata come la “notte di San Bartolomeo” e chiuse di fatto il cerchio sugellando la formazione del regime. Fu proprio però per tali recrudescenze e per il ripetuto ricorso all’illegalità che Tamburini fu allontanato dalla Toscana e inviato in Libia. Da qui egli tornò prima come ufficiale della Milizia forestale di Trento e poi come prefetto del regno nelle sedi di Ancona, Avellino e Trieste. Aderì alla RSI, di cui fu capo della polizia. Coinvolto in un losco giro di appropriazioni indebite anche a danno di altri gerarchi, fu arrestato e inviato nel campo di concentramento di Dachau nel reparto riservato ai criminali comuni. Liberato dalle truppe alleate, fu processato e condannato a sei anni di carcere ma, in seguito, amnistiato. Espatriato in Argentina, dal paese sudamericano inviò finanziamenti al Movimento sociale italiano. Tornato in Italia nella seconda metà degli anni Cinquanta, Tamburini morì a Roma nel 1957. Di fatto può essere identificato come il volto del più brutale squadrismo e allo stesso tempo uno dei protagonisti non troppo secondari del consolidamento del regime.
Renzo De Felice distingue un “fascismo movimento”, che avrebbe avuto in sé una carica in qualche modo innovativa, da un “fascismo regime”, risultato di una serie di compromessi con i centri di potere tradizionali. Questa distinzione è valida anche per la Toscana?
La distinzione tra “fascismo movimento” e “fascismo regime” ha alcune sue basi anche in Toscana, a patto di non considerare una divisione netta tra le due parti. In realtà gli anni del “movimento” furono segnati da pesanti infiltrazioni ed importanti interessi da parte dei centri tradizionali del potere e, anche alla luce di tali vincoli tra fascismo e potentati locali, si può ben dire che la compresenza delle due componenti fosse all’origine delle lotte interne per il controllo del territorio e del partito. Lotte che, di fatto, si intensificarono in momenti apicali di scontro ma, paradossalmente, anche di coalizione tra le componenti del PNF, quali le fasi di campagna elettorale. A ben vedere, le svolte elettorali se da un lato amplificarono e inacerbirono gli scontri interni, dall’altro furono capaci di riassorbire i malumori e di catalizzarli verso gli avversari politici. In sintesi, in Toscana questi due tipi di fascismo coesistettero con svariate sfumature in base alla zona considerata e, proprio tale compresenza fu alla base delle lotte che caratterizzarono gli anni compresi tra il 1922 e il 1925.
Nel tuo lavoro si parla anche della tristemente nota “notte di San Bartolomeo” fiorentina. Siamo nell’ottobre del 1925. Che bilancio si può fare dei primi tre anni di dominazione fascista in Toscana?
La “notte di San Bartolomeo” (il 3 ottobre 1925) fu un punto di svolta dopo il quale non fu più possibile un’opposizione al fascismo da parte dei suoi avversari. Né tantomeno fu più possibile un dissenso interno al PNF. È da tale svolta violenta che, di fatto, giunge a maturazione il regime in Toscana. Prima di tale evento non è giusto parlare di “dominazione” quanto piuttosto, parafrasando l’ormai classico studio di Lyttelton, di conquista e di consolidamento del potere. Conquista che avvenne non solo con la violenza delle spedizioni squadriste ma con un ripetuto esercizio retorico ed evocativo di miti e ritualità volti da un lato a cementare le file interne del partito e dall’altro ad emarginare gli avversari esterni. Per cui, il computo finale di quei tre anni trascorsi tra la Marcia e la nascita del regime non può esimersi da notare che in Toscana si manifestarono per intero ed assai pronunciate le tensioni interne al PNF post-marcia. Esse non permisero di definire il fascismo come un dato definitivo quanto piuttosto come un oggetto politico in divenire, alla ricerca di una sua compiutezza, acquisita solo attraverso la totale eliminazione delle voci discordi. E questo lo si ebbe solo col 1925. Era in definitiva la nomalizzazione.
Intervista a cura di Alessandro Affortunati.