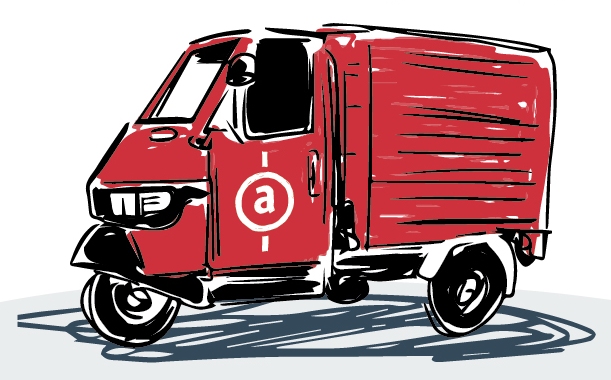L’8 settembre di Bettino Ricasoli

L’Armistizio, la dissoluzione dell’esercito, Roma occupata dai nazisti nel racconto di Bettino Ricasoli.
La tragedia dell’8 settembre 1943 ha segnato un’intera generazione di Italiani.
Dopo l’annuncio dell’Armistizio centinaia di migliaia tra soldati e ufficiali, sparsi sui vari fronti di guerra, si trovarono di colpo privi di ordini, senza saper che fare né dove andare, abbandonati alla mercé dei Tedeschi, non più alleati ma nemici.
Qualcuno riuscì a tornare a casa con mezzi di fortuna. Chi cercò di resistere, come i nostri soldati a Cefalonia e Corfù, venne massacrato senza pietà. Oltre 630.000 militari italiani, rastrellati o catturati con l’inganno, furono deportati in Germania.
Bettino Ricasoli aveva allora 21 anni. Richiamato alle armi nel gennaio del ‘43, alla fine di luglio era a Terracina per un periodo di addestramento prima di essere inviato al fronte. Qui lo colse l’8 settembre, quando non aveva ancora combattuto né sparato un solo colpo.
Il barone ha accettato di raccontare la sua personale avventura. Lucidità e chiarezza della narrazione, insieme all’eccezionalità delle circostanze di cui è stato testimone, rendono preziosa la sua testimonianza.
“C’era già stato lo sbarco a Salerno, Terracina e la ferrovia Roma-Napoli venivano spesso bombardate dall’aviazione alleata. Noi dovevamo sorvegliare la costa e agire se ci fossero stati degli sbarchi nel tratto fra il monte Circeo e Terracina. Lì ci prese l’8 settembre. Rimanemmo ai nostri posti, non sapendo esattamente cosa fare, tutte le comunicazioni con i comandi erano interrotte. Con i nostri ufficiali decidemmo di togliere gli otturatori ai cannoni per renderli inservibili, nel caso che i tedeschi si impossessassero di queste zone, e di andare a Sabaudia, dov’era il comando della divisione da cui dipendevamo. Vi arrivammo andando a piedi attraverso i campi durante la notte per non farci vedere. Eravamo convinti che i Tedeschi avrebbero opposto resistenza”.
Li attendono due sorprese. La prima è che a Sabaudia il comando di divisione non c’è più, dissolto come neve al sole. Increduli e confusi, i soldati decidono di tornare indietro e rioccupare le posizioni, per non rischiare di passare da traditori. Precauzione inutile, perché la postazione è deserta e dei comandanti non c’è traccia.
La seconda sorpresa è che i Tedeschi fuggono in maniera disordinata, con tutti i mezzi che riescono a trovare.
“Scappavano lungo la costa con chiatte, barche, barconi, soprattutto di notte. Andavano verso il nord. Vicino a noi c’era una postazione antiaerea tedesca. Una mattina un gruppo di soldati tedeschi che erano al servizio di questa postazione, armati fino ai denti, con collane di proiettili, vennero a dirci: “La guerra è finita, noi ci arrendiamo a voi”, proprio così. Noi non sapevamo cosa fare nemmeno di noi stessi, non avevamo più rifornimenti di cibo, non sapevamo più niente, eravamo abbandonati lì. Gli dicemmo: “Se volete restare con noi rimanete, ma non abbiamo nemmeno da darvi da mangiare”. Allora andarono via”.
Nei primi giorni dopo l’armistizio i Tedeschi che si trovano a sud di Roma attraversano una fase di smarrimento, con l’esercito alleato che incalza. Scappano verso il nord più velocemente che possono senza incontrare, purtroppo, nessuna resistenza. Ben presto si riorganizzano e riprendono il controllo della situazione.
“Per un certo numero di giorni anche i Tedeschi non sapevano cosa fare e si ritiravano. Secondo quello che potevamo giudicare noi dal nostro punto di vista, se a Roma ci fosse stata una volontà di combattere, se ci fosse stato un esercito organizzato e comandato in modo efficace, sarebbe stato possibile bloccarli. Dopo qualche giorno, a una settimana circa dall’armistizio, è arrivato nella nostra zona, fra il monte Circeo e Terracina, un ufficiale tedesco. Hanno emesso un proclama in cui si stabiliva che tutti i giovani in età militare dovevano consegnarsi alle autorità tedesche. A quel punto decidemmo di andar via”.
Rientrato in Toscana Bettino Ricasoli si ricongiunge ai familiari, che da Firenze si sono trasferiti nel loro castello a Brolio, presso Gaiole in Chianti. Dovrebbe essere una sistemazione abbastanza sicura, lontana dalle principali vie di comunicazione. Ma non è affatto sicura per il giovane, che a Gaiole è un personaggio molto in vista. Non avendo nessuna intenzione di arruolarsi nell’esercito di Salò, non gli rimane che nascondersi. Sceglie Roma, dove ha dei parenti che possono aiutarlo ed è più facile far perdere le proprie tracce.
Nella capitale occupata dai nazisti l’atmosfera è cupa. Repubblichini e tedeschi danno la caccia ai renitenti, gli scantinati sono pieni di sfollati, manca il cibo. Il Vaticano ricorre a un espediente per salvare un certo numero di giovani dai rastrellamenti: li arruola nella Guardia Palatina. Tra di loro c’è anche Bettino Ricasoli.
“A un certo momento il Vaticano ha voluto mettere più al sicuro molti di quei giovani che erano a Roma nelle mie condizioni e ottenne dal comando tedesco di aumentare l’arruolamento delle proprie guardie palatine, per proteggere gli immobili extraterritoriali, che appartengono allo stato del Vaticano ma sono nella città di Roma.
In quell’occasione anch’io riuscii a entrare al servizio della Città del Vaticano, con l’obbligo di fare un turno di guardia ogni 10 giorni. Fui assegnato alla Casa Generalizia dell’ordine dei Gesuiti, che è dietro il colonnato di San Pietro e domina la collina che guarda il Tevere. Ci sono ancora le vecchie mura di Roma, il servizio consisteva nel passeggiare avanti e indietro su queste mura. Facevo il turno di guardia e mi occupavo di assistenza. Roma si riempì di sfollati dalle campagne che venivano su, spinti dall’avanzare del fronte. Venivano dal napoletano, da Cassino. Stavano accampati in questi tunnel, erano state organizzate delle mense che ottenevano dal Vaticano piselli secchi che venivano cotti e distribuiti. Me ne alimentavo anch’io. Giravo per Roma con una tessera che avrebbe dovuto proteggermi se fossi incappato in quelle che chiamavano le retate: i repubblichini chiudevano un gruppo di strade e passavano al setaccio tutti quelli che erano dentro; se trovavano qualcuno in età da militare veniva preso e portato via su al nord, si diceva nei campi di concentramento in Germania. Ma con la carta del Vaticano si era quasi sicuri”.
Nonostante la fame e il clima di oppressione Ricasoli è convinto, come tutti, che gli Alleati non tarderanno ad arrivare. Nell’autunno del ‘43 nessuno immagina che il fronte rimarrà bloccato a Cassino per sei lunghi mesi. E l’occupazione nazista della Capitale si trasforma in un incubo che sembra non aver mai fine.
(Prima parte della testimonianza di Bettino Ricasoli raccolta il 4 marzo 2004)
La seconda parte dell’intervista in “L’incendio di Brolio”.