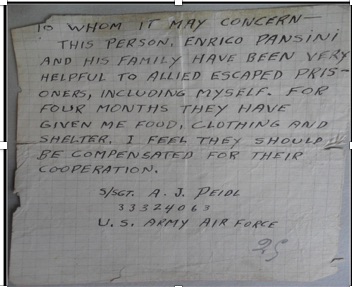Nel 10 di febbraio del 2020

È il sedicesimo anno di una data del calendario civile italiano, il 10 febbraio, non facile, come nulla è facile, nella costruzione della coscienza storica e civile, anche in presenza di leggi che fissano i giorni dell’obbligo di ricordare; rimane “passato che non passa” quello di cui non c’è solida conoscenza storica.
In Toscana si raccoglie l’eredità di un lungo e fertile impegno per la conoscenza e la disseminazione di sapere storico e la creazione di opportunità educative, partito già nel primo anno di istituzione del Giorno del Ricordo. Si sono susseguiti progetti importanti, che hanno incrociato le scelte culturali dell’ISGREC e della rete regionale di Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea con la volontà della Regione Toscana di applicare questa ed altre leggi nazionali o europee di memoria con interventi non occasionali.
La storia del confine alto-adriatico di cui parla la legge istitutiva del Giorno del ricordo era già stata scritta, non in piccola parte, ma non era ancora compiutamente patrimonio collettivo, prima del 2004. Se ne erano assunti il compito per primi storici appartenenti o originari dell’area giuliana. Sono lontane le opere di Ernesto Sestan, o gli studi di Teodoro Sala, per citarne alcune. È vero che nell’ultimo quindicennio si è fatta lunga la lista di opere pubblicate. Né era poca la memorialistica, specchio di sofferenze vissute dai sopravvissuti alle violenze degli anni della guerra o alle precedenti, di quando erano slavi e antifascisti ad esserne vittime.
Un piccolo libro, autore lo storico Guido Crainz, aggiunse nel 2005 uno strumento prezioso, per sua ammissione destinato a offrire proprio agli insegnanti un impianto concettuale alla difficile storia del confine “laboratorio della storia del Novecento”, italiana ed europea. Fu un contributo di metodo e merito, utilissimo a dare una dimensione europea alle storie di confine, dove le guerre del Novecento hanno lasciato ferite di violenze e, nell’Europa centrale, determinato spostamenti epocali di popolazione, milioni di profughi. Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa1 costituì un breviario per molti insegnanti di storia. È una storia che guarda di qua e di là dalla linea del “confine mobile”, fino all’ultimo, definitivo tratto di penna sulla carta geografica, tirato nel 1975 dalle diplomazie italiane ed europee. Queste parlavano un linguaggio diverso da quello delle memorie della gente di confine, che racconta storie di sofferenze e di abbandoni, di spaesamenti vissuti altrove, nell’esilio. Sono stati spesso i poeti e gli scrittori a dare voce ai loro sentimenti. Anche qui potremmo comporre una lunga lista, da toscani richiamare alla memoria il legame storico fra Trieste e Firenze, alleanze fra intellettuali, che sono state evocate in opere importanti. Allo straniamento di una lunga incertezza sul futuro, che per tanti precedette il dolore dell’abbandono e dell’esilio, dava forma poetica – solo un esempio scelto fra tanti – Giani Stuparich, nel 1948:
Erano i giorni più amari di Trieste e della Venezia Giulia, quando i potenti del mondo giocavano col ostro piccolo destino. Speranze e delusioni si alternavano, si passava dall’esasperazione all’abbattimento, dall’abbattimento alla rivolta. I cittadini camminavano per le strade smarriti, avviliti, o guardando da ogni parte, se non fosse per sopraggiungere qualche sorpresa che li scotesse, o li annientasse per sempre. I fuggiaschi di Pola e dell’Istria sbarcavano come storditi, si afflosciavano sulle rive, accanto alle loro misere masserizie.2
Una gran parte di quelle masserizie è ancora ammassata nelle stanze di Padriciano, uno dei centri profughi triestini. Una delle guide di Padriciano raccontò agli studenti toscani nel viaggio di studio del 2018 il senso dello sguardo sbigottito, che ci mostrò, nella foto di una donna che stringeva una sedia, fuori dall’edificio del campo. D’improvviso aveva riconosciuto qualcosa che le apparteneva, visitando quel luogo, e dopo aver urlato: “La mia sedia!” , l’aveva afferrata, stretta come per paura di perderla di nuovo e portata via.3
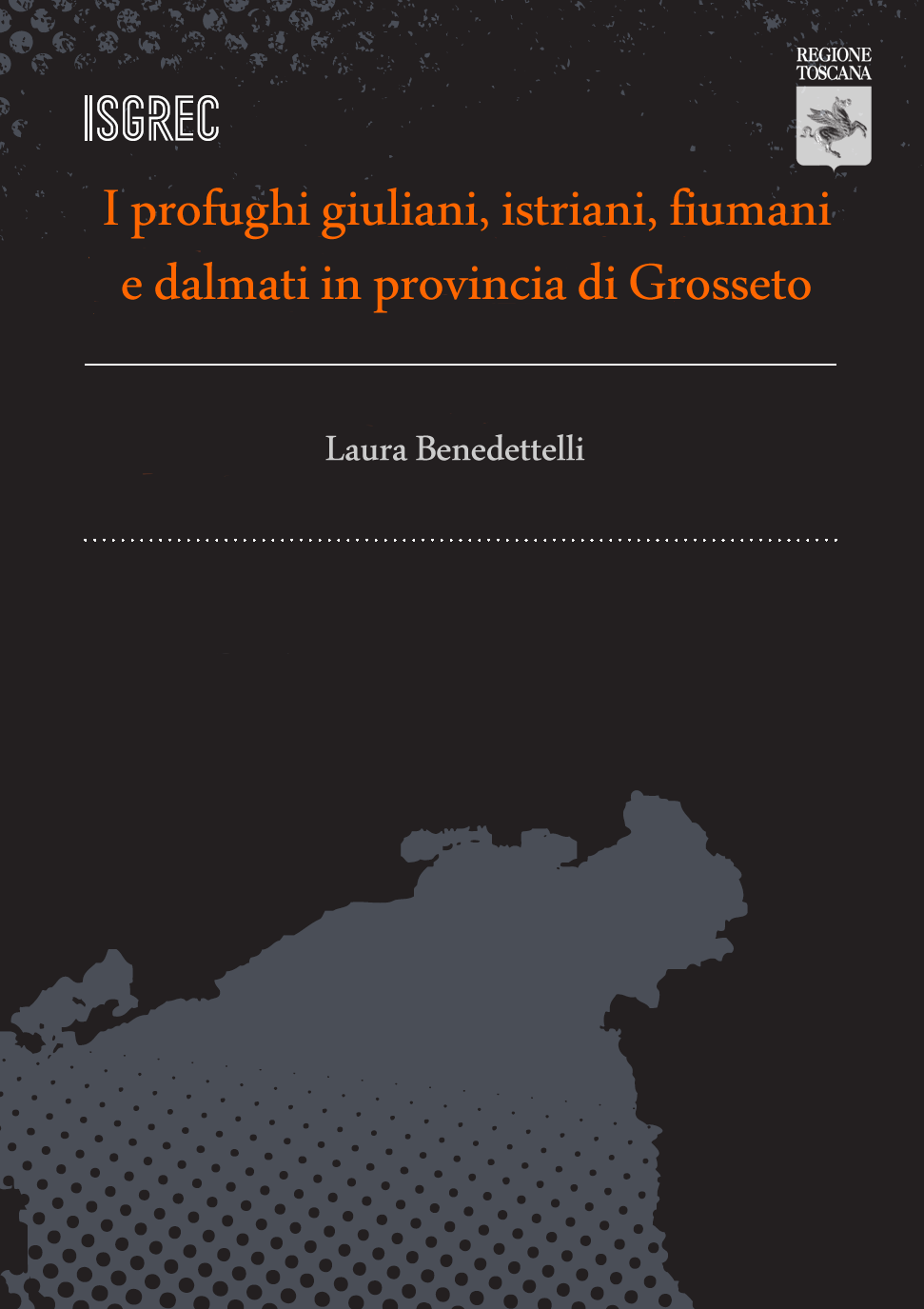 Quando alla progressiva crescita di conoscenza della storiografia si aggiunse la somma fra le suggestioni della letteratura, la scoperta delle testimonianze di gente comune, l’esperienza dei luoghi, per il lavoro dell’ISGREC e di altri istituti toscani, iniziò la stagione della produzione di strumenti utili non a coprire un vuoto, ma a farsi carico della scarsità di risorse per la scuola. In pochi anni: un primo viaggio di studio, un libro di strumenti didattici, una mostra e il primo fra i documentari4. Vale la pena di ricordare – lo abbiamo fatto poche settimane fa con Raoul Pupo – un convegno grossetano che risale al 1996 (Guerre civili nell’Europa del Novecento, i cui atti furono pubblicati a cura di due insegnanti5). Nel tempo a Grosseto è nata la curiosità per una storia che ci riguardava: quanto e come la storia di quell’esilio aveva toccato la comunità grossetana?
Quando alla progressiva crescita di conoscenza della storiografia si aggiunse la somma fra le suggestioni della letteratura, la scoperta delle testimonianze di gente comune, l’esperienza dei luoghi, per il lavoro dell’ISGREC e di altri istituti toscani, iniziò la stagione della produzione di strumenti utili non a coprire un vuoto, ma a farsi carico della scarsità di risorse per la scuola. In pochi anni: un primo viaggio di studio, un libro di strumenti didattici, una mostra e il primo fra i documentari4. Vale la pena di ricordare – lo abbiamo fatto poche settimane fa con Raoul Pupo – un convegno grossetano che risale al 1996 (Guerre civili nell’Europa del Novecento, i cui atti furono pubblicati a cura di due insegnanti5). Nel tempo a Grosseto è nata la curiosità per una storia che ci riguardava: quanto e come la storia di quell’esilio aveva toccato la comunità grossetana?
Così ha avuto inizio l’esplorazione di archivi locali e nazionali di Laura Benedettelli, insegnante-ricercatrice, che prima e più di altri frequentò letture importanti, appassionandosi in particolare alla scrittura femminile: Marisa Madieri, Nelida Milani, Anna Maria Mori…
Le carte dell’Ufficio affari di confine, a Roma, quelle dell’Archivio di Stato e della Prefettura, a Grosseto, la ricognizione sulla stampa locale andarono per anni di pari passo con lo studio. Non è stata impresa facile per la complessità che ognuno riconosce alle vicende del Novecento giuliano-dalmata e istriano. Abbiamo imparato da subito che era un terreno complicato, a ogni passo con il rischio di malintesi e contestazioni. È accaduto e accade, ora più che mai, con le ombre del Novecento, di cui sono una rappresentazione gli accadimenti affrontati dalla ricerca di Laura Benedettelli, impossibile da racchiudere nei limiti degli anni della seconda guerra mondiale.
Sono stati trovati numeri e nomi dei profughi arrivati a Grosseto, spesso dopo viaggi in più tappe, tra cui i campi profughi disseminati in tutto il territorio nazionale. Ogni storia personale e familiare ha similitudini e singolarità, rivelate dalle interviste. La ricerca ha riportato alla luce i dibattiti, sorti nelle sedi istituzionali e testimoniati dalle cronache della stampa locale. Fino alla definitiva accoglienza, alla costruzione del “palazzo dei profughi”, dove molti trovarono infine casa.
La prima edizione è stata un e-book6, che oggi si è deciso di stampare, anche se le risorse disponibili hanno consentito solo un piccolo numero di copie. Allegati all’e-book erano documenti sulla storia generale, dai trattati alle norme di legge, alle circolari applicative emanate nel corso degli anni, che rimangono consultabili on line, nel sito web dell’ISGREC Questi dati sono utili a comprendere il contesto di questo frammento di una storia che ha messo l’Italia, in analogia con il più vasto contesto europeo, di fronte a scelte politiche. I popoli, e dunque gli individui coinvolti, sono stati messi di fronte a scelte personali. Le guerre del Novecento hanno prodotto, anche se in forme diverse, il fenomeno della profuganza, dell’esilio, della migrazione, volontaria o forzata.

L’esodo da Pola, 1947
È una lezione per ogni tempo, anche se per i nuovi profughi del XXI secolo il distacco dalla patria ha una fenomenologia diversa e più estesa, da quando il mondo è diventato di fatto globale e le distanze si sono accorciate. Nella “letteratura di confine” del Novecento, che abbiamo letto insieme agli studenti, il viaggio sembra il sostrato di ogni vicenda narrata, in una accezione non certo turistica. Come ne L’infinito viaggiare di Claudio Magris7, dove si parla di spaesamenti per chi si allontana dal proprio luogo e anche di ritorni. Per lo scrittore triestino, che ha dedicato gran parte della sua scrittura al tempo della guerra e alle sue conseguenze, al tema del viaggio corrisponde l’idea di frontiera. Magris evoca, richiamando i ricordi della sua infanzia, il paesaggio che gli era stato familiare, guardato dal Carso. Quello stesso paesaggio era diventato la “Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due”, dietro alla quale c’era “…l’ignoto…il mondo dell’est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato”8 Col tempo, altri mutamenti hanno dato altri significati agli stessi luoghi, portando alla scoperta che si è sempre sia di qua che di là dalle frontiere.
Non è stato facile decifrare fino in fondo i ricordi degli esuli ascoltati da Laura Benedettelli, capire se hanno percepito la comunità grossetana come estranea e sentito una frontiera fra loro e “gli altri”. Gli atti concreti sembrano configurare una comunità accogliente, anche se non è scontato che non ci fosse traccia di indifferenza o diffidenza. Le nuove, attuali migrazioni hanno origini e motivazioni inedite, ma hanno una similitudine con quelle degli esuli istriano-fiumano-dalmati, perché esito di viaggi analogamente tortuosi, di attraversamenti di frontiere.
Fra i caratteri originali della Maremma c’è il suo essere terra di migrazioni, di inserimento nel lunghissimo periodo di nuclei di popolazioni, che sono state indispensabili e l’hanno resa migliore. Grosseto è diventata città solo grazie a migrazioni dalle provenienze più diverse; qui si ha la consapevolezza di avere origini “oscure”. Pensando a questo dato storico, probabilmente quell’accoglienza, dal secondo dopoguerra in poi, è stata reale.
Perché conviene ricostruire un itinerario noto, più volte documentato in queste stesse pagine? Ce lo suggerisce quel che era sperato e non è avvenuto: la presa d’atto di una uscita dal silenzio della storia del “confine difficile”, della disseminazione di sapere e coscienza critica nella scuola, di un impegno finalizzato a sottrarre a diatribe politiche vicende complesse e dolorose. Il 2020 sembra essere l’annus horribilis per i tentativi di annullare l’eredità di tanto lavoro. Il presente è fotografato da lapidi in memoria di crimini razzisti imbrattate, dalle stolpersteine (le pietre d’inciampo con cui l’artista tedesco Gunter Demnig sta riportando a casa, almeno con la memoria, i deportati europei nei lager nazisti) deturpate. I segni di antisemitismo crescono con un razzismo a tutto campo. Episodi di discriminazione e rifiuto, fino alle aggressioni fisiche ai diversi, per colore della pelle, culture e credo religioso sono quasi quotidiani.
In questo clima, il racconto del dolore delle vittime delle foibe o di altre forme di violenze e di perdite – l’abbandono di luoghi della propria vita e la profuganza, che vecchie e nuove memorie testimoniano, è scagliato come un proiettile, in un dibattito pubblico che ha come protagonista la politica. Rischia di entrare in crisi il dialogo avviato da tempo fra popoli e Stati del confine – Italia, Croazia e Slovenia – se si spingono le memorie personali verso il rancore. Quanto alla memoria collettiva, è ancora in corso la faticosa elaborazione del lutto per le vicende del confine alto-Adriatico, dopo troppo lunghi silenzi. Silenzi erano seguiti anche alla persecuzioni di ebrei e alla deportazione politica, da poco si sta recuperando quella degli internati militari italiani nei campi del III Reich. La legge istitutiva della Giornata della memoria precede solo di quattro anni la fissazione del 10 febbraio per ricordare foibe ed esodo.

Profughi si imbarcano a Pola, 1947
Le memorie, individuali e collettive, sono situate nel tempo, del mutare del clima sociale e politico. Sono verità mutevoli, fonti accanto ad altre. Ora che l’era del testimone sta finendo, a maggior ragione dovrebbe prevalere la voce della storia, lo sguardo al passato con il filtro di domande, che servono a superare il semplice racconto con la spiegazione. È devastante, rispetto al bisogno di verità storica, la confusione fra eventi e fenomeni diversi, la frammentazione di racconti che rimangono inspiegabili cronache, se rifiutano la stratificazione dei tempi lunghi e brevi, dei diversi livelli di responsabilità individuali e collettive. Non è per sminuire le violenze di confine, opera dei partigiani titini, che si pretende di interpretare foibe ed esodo nel tempo lungo del Novecento, o di fare luce sulle responsabilità italiane per le violenze taciute dei Balcani, o ricordare che non furono solo gli italiani ad essere infoibati.
Da un esule, Predrag Matvejevich, riceviamo una lezione di cogente attualità, seppure tratta da uno scritto datato 2005, all’indomani del primo giorno del ricordo:
…esiste il pericolo che si strumentalizzino e “il crimine e la condanna” e che vengano manipolati l’uno o l’altro. Ovviamente, nessun crimine può essere ridotto o giustificato con un altro. La terribile verità sulle foibe, su cui il poeta croato Ivan Goran Kovačić ha scritto uno dei poemi più commoventi del movimento antifascista europeo, ha la sua contestualità storica, che non dobbiamo trascurare se davvero desideriamo parlare della verità e se cerchiamo che quella verità confermi e nobiliti i nostri dispiaceri. Perché le falsificazioni e le omissioni umiliano e offendono9.
Quello scritto metteva in guardia da strumentalizzazioni e storie monche, generatrici di rivendicazioni rancorose, se fondate su fissazioni identitarie di tipo nazionalista e rigide ideologizzazioni. Se ne comprende meglio il senso pensando alla sua storia di vita. Padre ucraino, madre croata, eredità linguistiche plurime, che lo spingono a un destino di cosmopolita, a lui congeniale, ma duro da sostenere, “peccato originale” che, dice “non sarebbe piaciuto né ai nazionalisti né ai comunisti [e] ha avvelenato la [sua] infanzia”, fin quando ha scelto l’esilio10.
Scrive Walter Barberis a proposito della Shoàh che “l’abuso della memoria non è meno dannoso del cattivo uso della storia”11. Non è l’oblio la soluzione, ma l’uso critico delle memorie, un ripensamento alla luce del tempo presente degli appuntamenti con il passato, nei giorni stabiliti per legge. Il rumore di orazioni pubbliche celebrative, spesso retoriche, se non strumentali, non dovrebbe coprire i discorsi della storia, che procedono con lentezza e a voce più bassa.
Se sarà così, scrive in questi giorni lo storico Luca Bravi, non tutto sarà perduto.
____________________
NOTE:
1 G. Crainz, Il dolore e l’esilio. Le memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005.
2 G Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Grazanti, Milano 1948, cit. ivi, p. 78-79.
3 L’episodio è avvenuto a Padriciano, nel febbraio 2018, durante il viaggio di studio degli studenti toscani. È stato il primo dei due progetti educativi promossi dalla Regione Toscana (Storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento) ed attuati grazie agli Istituti storici toscani sopra citati, giunti come impegno sistematico, dopo numerosi progetti minori, sostenuti fin dal 2007. Il prossimo 11 febbraio partiranno nuovi studenti, accompagnati da nuovi insegnanti, resi esperti da una formazione intensiva sulla storia del confine nel Novecento, con la summer school di Rispescia (Grosseto, agosto 2019).
4 Al primo documentario del 2010 – La nostra storia e la storia degli altri – , è seguito La conoscenza scaccia la paura, ambedue produzione Regione Toscana-ISGREC, regia di Luigi Zannetti.
5 C. Albana, P. Carmignani (a cura di), Guerre civili nell’Europa del Novecento, Editrice Il mio amico, Roccastrada (GR), 1999. Contiene il saggio di Raoul Pupo: Guerra civile e conflitto etnico: italiani, croati e sloveni.
6 In www.isgrec.it
7 C. Magris, L’infinito viaggiare, Grazanti, Milano 2005.
8 Ivi, p. XIII.
9 P. Matvejevic, in “Novi list”, 14 febbraio 2005 (traduzione di L. Zanoni per “Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa”) in https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Predrag-Matvejevic-le-foibe-e-i-crimini-che-le-hanno-precedute
10 P. Matvejevic, Mondo “ex”. Confessioni, identità, nazioni nell’una e nell’altra Europa, Garzanti, Milano 1996, p. 24.
11 W. Barberis, Storia senza perdono, Einaudi, Torino 2019.