Viver qui è un purgatorio; ma è molto utile ch’io ci sia. Se no non ci resterebbe nessuno e tutto andrebbe perduto.
Il 12 luglio del 1944, Albano Milani Comparetti (1885-1947), padre del futuro don Lorenzo Milani, con queste parole risolute ma al contempo cariche d’inquietudine si rivolgeva in lettera alla moglie Alice Weiss (1895-1978). Si era allora a poche settimane dall’arrivo su Firenze del fronte di guerra, attestato in quei giorni a nord di Siena, e Albano dirigeva le sue parole alla consorte scrivendole da Gigliola, l’amata fattoria che i Milani possedevano dal 1914 nel comune di Montespertoli, pochi chilometri a sud-ovest del capoluogo regionale toscano.

La fattoria di Gigliola dei Milani Comparetti, nel comune di Montespertoli (gentile concessione di Valeria Milani Comparetti)
Luogo prediletto dalla famiglia e cornice cara all’infanzia e alla gioventù dei tre figli di Albano (Adriano, Lorenzo ed Elena), agli inizi degli anni Quaranta Gigliola era divenuta per necessità rifugio appartato dei Milani i quali, nel tentativo di sottrarsi alla minaccia dei bombardamenti e nella speranza di poter meglio proteggere Alice dai pericoli cui andava incontro in quanto appartenente a famiglia ebrea, lì si erano stabilmente trasferiti nel 1942. Nel loro buon ritiro immerso nella campagna fiorentina, i Milani avevano così cercato di blandire i disagi e ridurre i rischi di un conflitto allora lontano che però dopo l’8 settembre del 1943 e l’inizio dell’occupazione tedesca si era fatto sempre più presente. In particolare, a seguito della liberazione di Roma il 4 giugno del 1944 e della rapida avanzata del fronte di guerra in Toscana, la situazione era andata rapidamente mutando. Anche il comune di Montespertoli aveva assistito all’intensificarsi della presenza tedesca e Gigliola era divenuta base di diversi reparti intenti a fare la spola tra la prima linea e le retrovie e dediti per lo più al saccheggio. Ai primi di luglio, perciò, preoccupato per la sorte dei propri cari, Albano aveva disposto il loro allontanamento dalla fattoria di famiglia, oramai ritenuta non più sicura e prossima a essere fagocitata dall’arrivo del fronte in rapida marcia su Firenze.
Il 3 luglio, infatti, la moglie Alice partì da Gigliola alla volta di Firenze, seguita subito dopo da Lorenzo, allora giovane seminarista. Quest’ultimo, che il 19 giugno precedente aveva raggiunto i genitori a Gigliola a seguito della chiusura del Seminario fiorentino del Cestello, protetto dal suo abito talare il 4 luglio partì infatti alla volta di Firenze assieme alla sorella Elena, raggiungendo la madre a Bellosguardo, sulle colline circostanti Firenze, dove i Milani avevano in affitto una villa nella quale abitava già il primogenito Adriano, giovane studente di medicina allora inserito nella rete clandestina del Partito d’Azione. Rimasto solo a Gigliola in compagnia del fratello Giorgio, Albano Milani avrebbe assistito da quella posizione al devastante passaggio del fronte, facendone un dettagliato resoconto in una serie di lettere-diario che tra il 4 luglio e il 6 agosto 1944 egli scrisse alla moglie Alice.
A lungo rimaste inedite, queste ultime sono adesso pubblicate in un recente libro di Valeria Milani Comparetti – nipote di don Lorenzo – che con documentazione inedita e passione filologica per la prima volta ha ricostruito il rapporto che legava il futuro priore di Barbiana a suo padre Albano (si veda la locandina della presentazione del libro in “Materiali Correlati”). In precedenza trascurata dalla storiografia, la figura di Albano – come ci suggerisce il racconto della nipote – appare invece centrale nella formazione culturale di Lorenzo e persino per il suo cammino di conversione, considerato in tal senso l’interesse che Albano – nonostante il clima agnostico e “scientista” della famiglia – dimostrò per il tema religioso e che lo avvicinò persino allo studio di testi dogmatici e teologici. Personaggio sicuramente ricco di talenti, studioso eclettico di letteratura, poliglotta, nonché imprenditore e attento amministratore dei possessi familiari, Albano nelle sue lettere scritte alla moglie nell’estate del 1944 ci offre uno spaccato inedito sulla storia della famiglia Milani, presentandoci un affresco composito dal quale risaltano al contempo i fatti terribili della guerra, dell’occupazione tedesca e del passaggio del fronte, i legami d’affetto nonché soprattutto il ruolo di pater familias e di possidente illuminato che in quei tragici eventi porta Albano a farsi carico sia dell’incolumità dei propri cari che di quella del piccolo microcosmo contadino di Gigliola che su di lui faceva affidamento: Sento il dovere di star qui con i nostri dipendenti che guardano a me come al loro capo e al loro protettore nella grande burrasca, avrebbe scritto non per nulla alla moglie.

Alice Weiss in calesse davanti alla villa di Gigliola, 7 aprile 1920 (gentile concessione di Valeria Milani Comparetti)
Composta allora da più di venti poderi per cica 200 ettari di cui 150 di seminativo, la tenuta di Gigliola era stata acquistata nel giugno del 1914 dal padre di Albano, Luigi Adriano Milani, archeologo e numismatico di fama, il quale, rimasto vedovo l’anno precedente della moglie Laura Comparetti, figlia del filologo Domenico e della pedagogista russa Elena Raffalovich, aveva assegnato in via successoria quella produttiva azienda ai quattro figli (Albano, Giorgio, Piero ed Elisa) affidandone però la gestione al maggiore Albano. Quest’ultimo, in effetti, con la morte del padre avvenuta nell’ottobre del 1914 era divenuto amministratore e curatore dell’intero patrimonio familiare che all’epoca comprendeva diverse proprietà immobiliari, sia cittadine che rurali. Proprio attorno alla tenuta di Gigliola si sarebbero però concentrate le attenzioni di Albano.
Possidente del tipo paternalista, benché bonario, convinto dell’efficienza del sistema di fattoria e della bontà sociale della mezzadria – che non per nulla avrebbe difeso in un suo pamphlet del 1946 – a cavallo delle due guerre Albano si impegnò energicamente nell’ammodernamento della tenuta, sperimentando nuove varietà di colture e dedicandosi soprattutto alla viticoltura e alla produzione enologica, alla quale avrebbe applicato le conoscenze scientifiche che aveva acquisito nei suoi studi universitari di chimica, dedicandovi poi saggi e pubblicazioni.

Podere Ulivello. Albano Milani Comparetti al centro. Alla destra il fattore di Gigliola, Mattolini. 15 aprile 1922 (gentile concessione di Valeria Milani Comparetti)
La sua, in effetti, fu una gestione moderna dell’azienda che se pur guardava ancora con convinzione all’utilità dell’agricoltura mezzadrile, era però attenta al contempo alle nuove culture aziendali che si stavano affermando in Italia tra le due guerre, con particolare attenzione ai sistemi di organizzazione scientifica del lavoro di cui Albano diverrà peraltro sostenitore e promotore quando nel 1932 si trasferirà con la famiglia a Milano per impiegarsi nella Società Italiana Bedaux, un’azienda fondata nel 1927 da industriali del calibro di Agnelli e Pirelli allo scopo di diffondere l’omonimo metodo di organizzazione del lavoro.
D’altra parte, anche in quegli anni è sempre alla conduzione del possesso di Gigliola, caro alle gioie e agli affetti di tutta la famiglia, che Albano rimane particolarmente legato. Così, quando nella prima metà degli anni Trenta un’improvvisa crisi economica che colpisce i fratelli Milani e in modo particolare il secondogenito Giorgio sembrò mettere in dubbio la tenuta del patrimonio familiare e la conservazione della fattoria di Montespertoli, Albano si impegnò a preservarne l’integrità assumendosi il debito del fratello e facendo subentrare nella proprietà di Gigliola anche la moglie Alice Weiss. Arginato lo scompenso finanziario della famiglia, le quote proprietarie assunte da Alice sarebbero state poi recuperate da Albano nel 1939, quando cioè, a seguito della proclamazione delle leggi razziali, la situazione della consorte si fece molto delicata. Già in precedenza, i due coniugi, sposatisi nel 1919 con rito civile, avevano fatto di tutto per nascondere le origini ebraiche di Alice e salvaguardare la prole da possibili discriminazioni. Per prima cosa, nel 1934, proprio durante un soggiorno a Gigliola, avevano fatto battezzare i figli Adriano, Lorenzo ed Elena (nati rispettivamente nel 1920, 1923 e 1928) da don Viviani, pievano di S. Piero in Mercato e amico di famiglia, che ne aveva retrodatato i certificati al giorno della loro nascita. Nel 1938, poi, Alice, oltre a far domanda di recessione dalla Comunità Israelitica di Trieste, sua città natale, si era fatta battezzare in aprile dallo stesso don Viviani e il 30 novembre successivo aveva potuto celebrare con rito cattolico il matrimonio con Albano nella chiesa di S. Maria del Suffragio, a Milano. Proprio per sfuggire ai primi segnali di vessazioni antisemite, nel 1942 i coniugi Milani avevano lasciato il capoluogo lombardo, rifugiandosi a Gigliola.

Albano assieme a un contadino tra le spighe di grano. 13 giugno 1928 (gentile concessione di Valeria Milani Comparetti)
Anche qui, però, la minaccia di una possibile persecuzione si era presto ripresentata, lambendo la stessa rete familiare dei Milani. Il 30 dicembre del 1943, infatti, le autorità repubblichine di Montespertoli procedettero al sequestro dei beni della villa e fattoria di Trecento, di proprietà dell’ebreo triestino Giorgio Manni e di sua moglie Bianca Weiss sorella di Alice, che i due avevano acquistato nel 1933 proprio da Albano. Fortunatamente, l’arresto dei coniugi Manni fu scongiurato grazie a un anonimo benefattore che li preavvisò in tempo della minaccia, permettendo loro di mettersi al riparo. La tenuta di Gigliola non fu invece raggiunta da analogo provvedimento, perché a quella data Albano era già rientrato in possesso delle quote proprietarie di Alice che quindi non figurava più intestataria del bene. Quest’ultima poté così continuare a rimanere a Gigliola relativamente al sicuro, almeno sino a quando tra giugno e luglio del 1944 con l’avvicinarsi del fronte di guerra la presenza e il controllo dei reparti tedeschi aumentarono di numero e intensità. Fu allora, appunto, che fu deciso l’allontanamento di Alice e dei figli alla volta di Firenze.

Autunno 1928. La famiglia Milani di fronte ai locali di fattoria. A destra Alice con il piccolo Lorenzo sulle ginocchia. Alle loro spalle la finestra della stanza dove Albano e Giorgio vennero trattenuti dai tedeschi fra il 17 e il 23 luglio 1944 (gentile concessione di Valeria Milani Comparetti)
Rimasto a Gigliola, Albano, nelle settimane in cui si compì il passaggio del fronte nella zona, si dette anima e corpo a cercare di mediare i difficili rapporti tra forze occupanti e popolazione locale, puntando sulla sua autorità sociale e soprattutto sfruttando la sua ottima conoscenza del tedesco, che in alcuni casi gli consenti in effetti di stemperare l’aggressività degli occupanti: Oggi alle 15 sotto il solleone – scrive il 13 luglio alla moglie – sono dovuto andare una volta e mezzo a Sazzipoli per intervenire presso militari tedeschi che volevano portar via i tre buoi rimasti, dopoché un paio di settimane fa, come sai ne avevano portato via uno. Siamo riusciti a far desistere. Uno dei due soldati era un berlinese, un bravo ragazzo che si è commosso a sentirmi parlare così bene tedesco e di Berlino.
Tuttavia, man mano che la prima linea avanza e i combattimenti si fanno più intensi, i tedeschi inaspriscono il proprio atteggiamento e anche Albano è costretto a subirne in prima persona le conseguenze. Il 17 luglio infatti un nuovo reparto prende possesso della villa di Gigliola e rinchiude Albano e il fratello Giorgio nei locali di fattoria, nei quali di fatto i due rimangono segregati per alcuni giorni. La notizia del fermo giunge sino a Firenze, da dove Lorenzo il 18 luglio decide di partire in soccorso del padre, intraprendendo un rischioso e coraggioso viaggio in solitaria sino a Gigliola. Non ci è noto il momento esatto in cui Lorenzo giunge a Gigliola, solo sappiamo che poco dopo il rilascio di Albano e del fratello, avvenuto il 23 luglio, egli è presente e li coadiuva nel porre a riparo quel poco che si è salvato nei locali della villa, ripetutamente saccheggiata dagli occupanti. Oramai il fronte è a pochi chilometri e Gigliola è presa di mira dal fuoco incrociato dei due eserciti in lotta.
Il 24 luglio, un proiettile alleato centra il tetto della cameretta di Lorenzo, dove il seminarista era salito poco prima a mettere un po’ d’ordine: Se veniva un momento prima Lorenzo sarebbe morto, scrive Albano ad Alice lo stesso giorno. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, le ultime retroguardie tedesche si ritirano da Gigliola ma gli scontri con i reparti britannici e le truppe coloniali dell’VIII Divisione Indiana proseguono durissimi fino al 27, giorno in cui il capoluogo del comune viene liberato. Albano e Lorenzo, che hanno passato gli ultimi momenti al sicuro nelle cantine della fattoria, nei giorni seguenti la liberazione si danno un gran da fare per assistere la popolazione locale. Ad entrambi, che parlando inglese riescono perfettamente a farsi intendere dalle nuove autorità alleate, viene concessa una certa libertà nonché uno speciale lasciapassare che permette loro di muoversi in sicurezza. Lorenzo in particolare, nei giorni seguenti si recherà più volte ad assistere l’anziano don Viviani alla Pieve di S. Piero in Mercato che nei giorni del fronte ha accolto un gran numero di sfollati. Qui già il 27 luglio padre e figlio intervengono in appoggio a un gruppo di donne, impaurite dall’atteggiamento insubordinato di alcuni reparti indiani che avevano cercato di razziarle e usar loro violenza: abbiamo cercato di aiutare le profughe accompagnandole coi loro mezzi dal rifugio alla porta della Pieve e Lorenzo ed io abbiamo anche aiutato a trasportare le loro materasse fin fuori dove le donne si sentono più sicure, informava Albano il 28 luglio scrivendo ad Alice.

Montespertoli, 27 luglio 1944. Fanti inglesi del 5° Royal West Kent ispezionano le macerie del paese appena liberato (Library and Archives, Canada)
Nel frattempo, mentre il fronte prosegue il suo cammino in direzione di Firenze, a Montespertoli la macchina burocratica alleata si attiva per ripristinare un governo locale provvisorio. Come loro consuetudine, gli ufficiali alleati preposti agli affari civili si rivolgono ai maggiorenti del comune. Uno dei primi a essere interpellato è proprio Albano che per il suo alto profilo e la sua conoscenza dell’inglese viene preso subito in considerazione per un posto di responsabilità, che per la verità lo lascia alquanto dubbioso: Qui vorrebbero farmi sindaco – comunica ancora alla moglie il 31 luglio – cosa che mi seccherebbe molto in questo momento, perché ci sono elementi pericolosi e la baraonda è grande ed io mi intendo troppo poco di queste cose. In effetti, il clima che si respira in quei giorni non è dei più distesi. La formazione della prima giunta della Liberazione, infatti, registra un duro braccio di ferro tra il governatore alleato e i partiti antifascisti del locale Comitato di Liberazione Nazionale che contro il parere dei militari vogliono imporre all’esecutivo il principio di rappresentanza partitica. L’accordo si raggiunge solo il 4 agosto con la formazione di una giunta formalmente apolitica, ma presieduta dal bracciante comunista Angelo Verdiani. Albano per il momento non ne entra a far parte, benché per la verità a quella data gli siano già stati affidati alcuni incarichi. Il 1° agosto, infatti, è stato convocato dal governatore alleato il quale lo ha affiancato all’ufficiale responsabile della polizia militare, il capitano Robertson.
Nel settembre del 1944, però, a seguito di una crisi municipale innescata da un ulteriore attrito sorto tra il CLN e il nuovo governatore alleato, si assiste a un rimpasto della giunta che porta all’ingresso di Albano nell’esecutivo e che permette un certo appeasement tra Alleati e componenti politiche antifasciste. Nella nuova giunta del Verdiani – riconfermato alla carica di sindaco – Albano si interessa prevalentemente dell’istruzione scolastica del comune, compito questo che poi gli viene formalmente attribuito il 5 novembre. Il 13 ottobre 1944, inoltre, egli è nominato assieme alla moglie Alice Weiss membro della commissione comunale per la vigilanza e la tutela della pubblica istruzione, mentre nel febbraio del 1945 viene eletto anche presidente del consiglio di amministrazione del patronato scolastico. In questi mesi, nella sua veste di assessore alla pubblica istruzione, Albano si dedica soprattutto alla ricostituzione della Scuola secondaria di avviamento professionale di tipo agrario, un istituto comunale che aveva aperto a Montespertoli nell’anno scolastico 1942-43. Agli occhi di Albano per un municipio rurale quale quello di Montespertoli l’esistenza di una scuola che dopo le elementari consentisse ai figli del popolo un avviamento allo studio dell’agraria appariva un elemento di indubbia importanza per il miglioramento delle condizioni di vita locali. Non per nulla, l’esecutivo decise di porre l’affare nella propria agenda. A favore di questa realizzazione fu però Albano che più di tutti si diede da fare, intervenendo più volte nelle adunanze della giunta per sollecitare lo sblocco di quei fondi che sarebbero serviti all’impianto della scuola, nonché impegnandosi personalmente per dotarla di un corpo docenti idoneo e qualificato. Alla direzione dell’istituto, peraltro, fu insediata una cara amica di famiglia dei Milani, Clara Francese Foà, insegnante di matematica e laureata in Fisica all’Università di Firenze, che sarebbe rimasta alla guida dell’istituto sino alla fine del 1945. Nonostante le evidenti difficoltà finanziarie riscontrate dall’amministrazione comunale, grazie all’impegno di Albano e della moglie, la scuola di avviamento, nell’anno didattico 1944-1945 poté riscuotere un certo successo, registrando l’iscrizione di 57 tra alunni e alunne, ottenendo il riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione e licenziando a fine anno 16 su 18 iscritti dell’ultima classe.
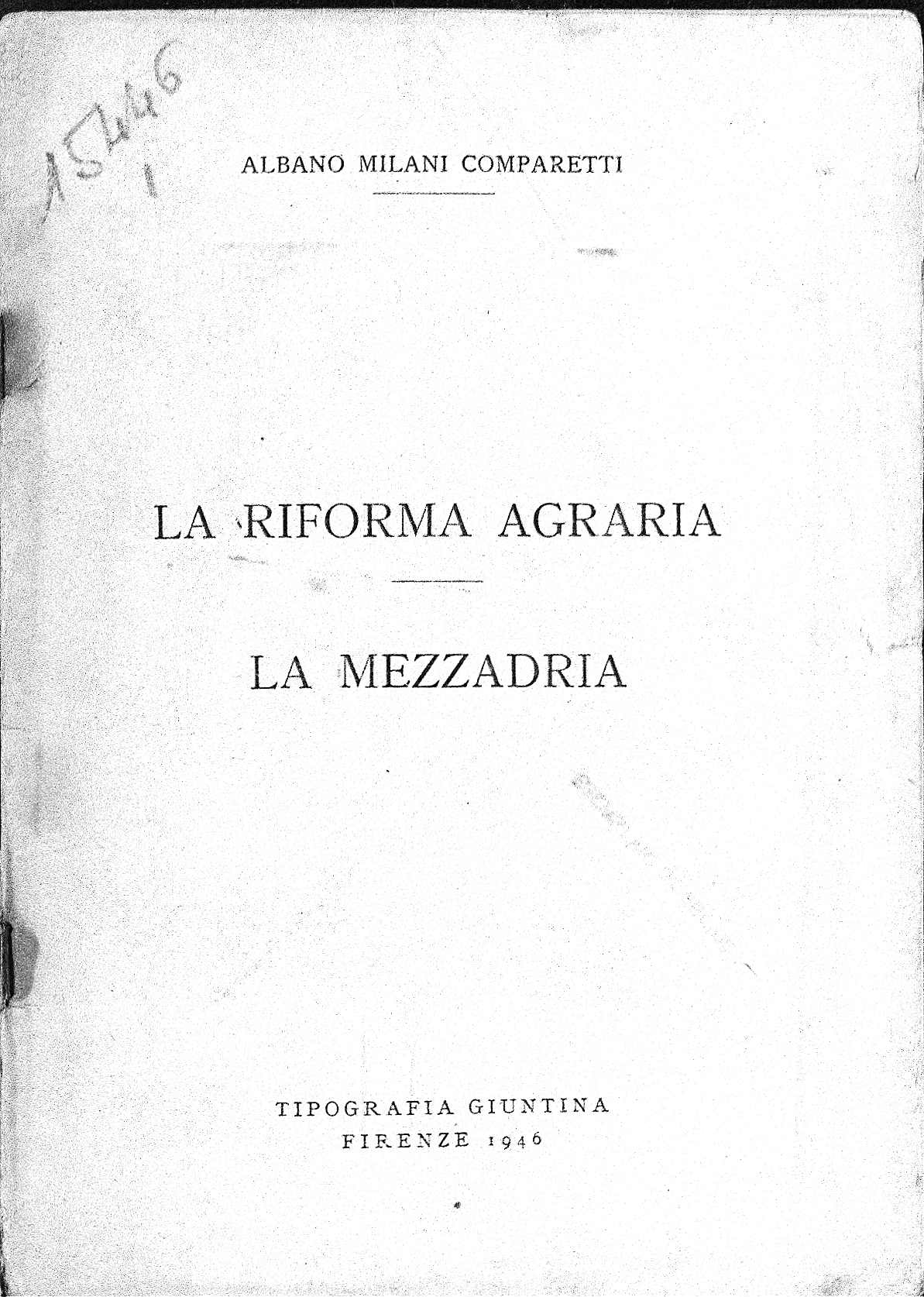
Lo studio che Albano Milani Comparetti dedica nel 1946 alla mezzadria e nel quale ne difende la conservazione (Tip. Giuntina, Firenze 1946)
L’esperienza di Albano Milani Comparetti nella giunta della liberazione di Montespertoli si sarebbe protratta sino alla fine del 1945, nonostante in questo lasso di tempo egli dovette subire una serie di accuse politiche che gli furono rivolte dal locale CLN. Quest’ultimo infatti, già nel dicembre del 1944 rese nota la precedente esperienza che Albano aveva avuto tra il 1924 e il 1927 nella giunta comunale fascista di Montespertoli e ne chiese per questo le dimissioni. Albano, in effetti, nel giugno del 1924 era stato eletto come assessore supplente nell’esecutivo di Montespertoli, anche se non vi aveva mai partecipato assiduamente. Il prefetto di Firenze, informato della cosa, il 6 marzo 1945 fece sapere d’aver già disposto per la sostituzione del Dr. Albano Milani in seno alla Giunta comunale di Montespertoli, a patto però che la notizia del suo incarico nell’amministrazione fascista venisse comprovata. Albano, in sua difesa redasse un breve memoriale, nel quale chiarì che allora la sua partecipazione alla giunta comunale non aveva avuto carattere politico, dato che vi era entrato come rappresentante degli interessi degli agricoltori, e che per di più nel 1924 non esisteva ancora la legge fascista Provinciale e Comunale ed il regime non era ancora intervenuto sul piano amministrativo. Inoltre, faceva notare Albano, la sua iscrizione formale al PNF era avvenuta solamente nel 1933, ed egli non aveva neppure mai aderito al Partito Fascista Repubblicano, rifiutandosi per di più di far parte dell’esercito della RSI e respingendo ogni offerta di collaborazione che gli era stata offerta durante l’occupazione. Considerati i legami che la famiglia Milani aveva intessuto da tempo con il milieu antifascista fiorentino e con gli ambienti azionisti soprattutto, nelle cui file militava peraltro il figlio primogenito Adriano, Albano parlava sicuramente in buona fede quando qualificava la sua adesione al potere locale fascista come una mera questione di adattamento. Egli era stato un agrario, forse un poco paternalista, in fin dei conti un conservatore, eppur convinto della necessità di trovare una via che portasse al miglioramento economico e sociale delle classi subalterne e al conseguimento del massimo beneficio alla collettività; obiettivi che egli nel dopoguerra, come iscritto al partito liberale, andava ancora ricercando nell’idea liberale e nei potenziali benefici che il progresso tecnico e la razionalizzazione economica avrebbero potuto apportare alla società. Alla fine, comunque, il procedimento di accertamento politico non gli comportò alcuna conseguenza ed egli continuò indisturbato a espletare le sue funzioni di assessore, intervenendo alle adunanze della giunta di Montespertoli sino a quella del 22 settembre 1945. Una settimana più tardi, il 29, mentre si trovava a Gigliola, Albano fu colto da una grave crisi cardiaca che ne segnò irrimediabilmente la salute. Egli riuscì a intervenire un’ultima volta all’adunanza della giunta municipale del 21 novembre, dopo la quale, tuttavia cessò ogni funzione nell’amministrazione comunale di Montespertoli. Ritiratosi in famiglia, Albano si sarebbe spento a Firenze il 2 marzo del 1947.
L’articolo ripropone una sintesi del saggio di F. Fusi, “Albano Milani Comparetti: un notabile a Montespertoli tra guerra e Liberazione” contenuto nel libro di Valeria Milani Comparetti “Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi di famiglia” Edizioni Conoscenza, Roma 2017. Si ringrazia Valeria Milani Comparetti per averne consentito la pubblicazione su ToscanaNovecento.





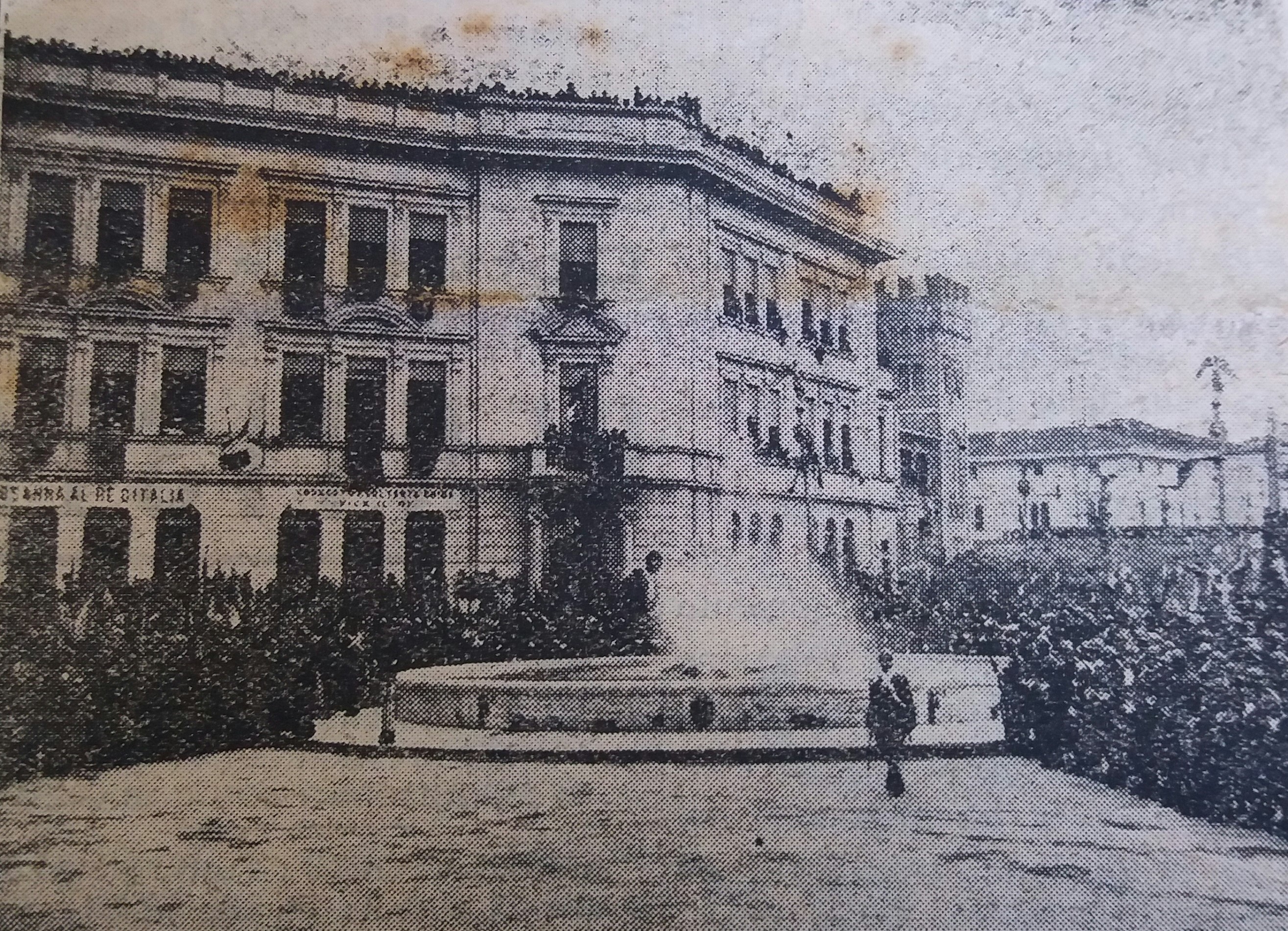


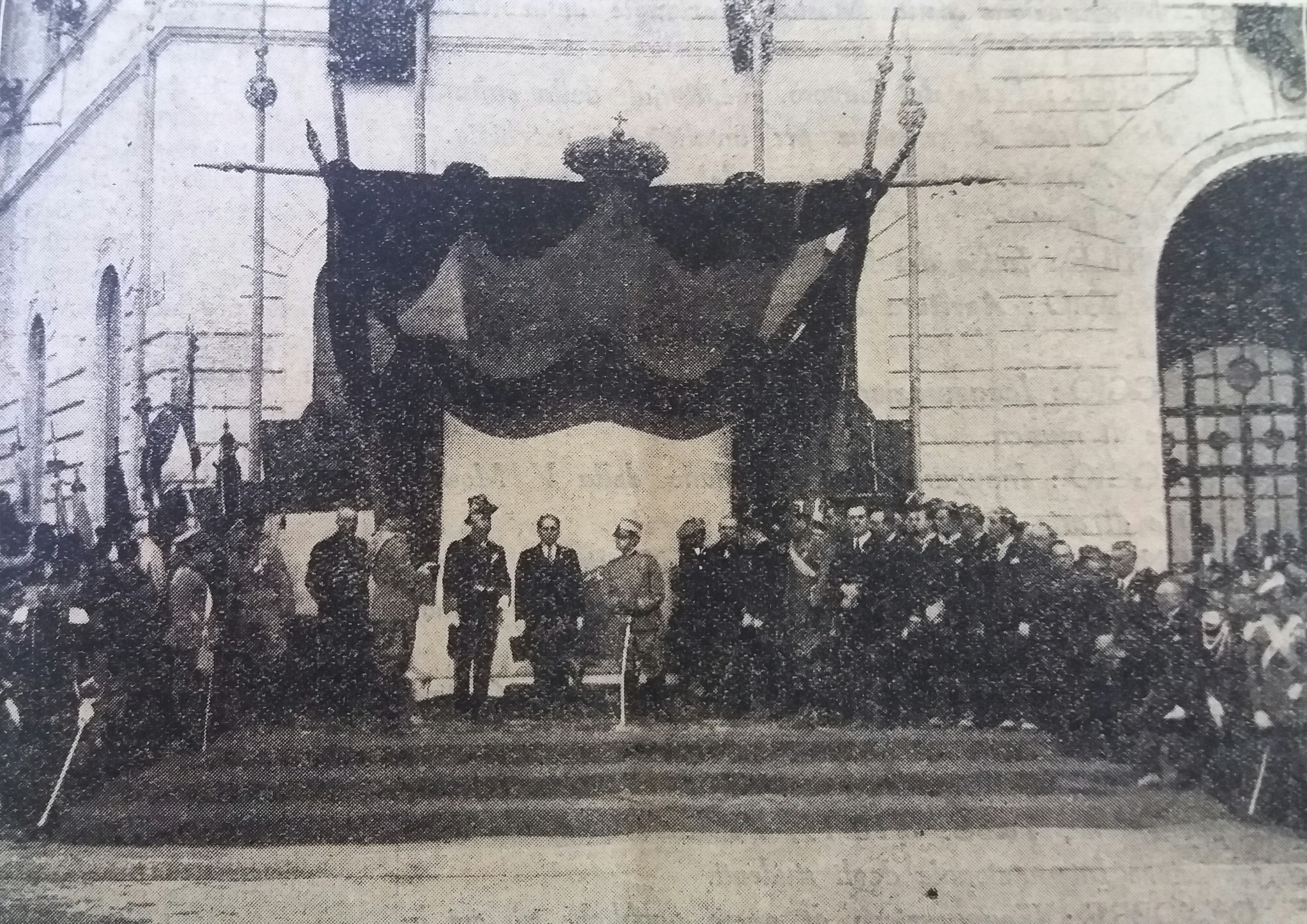















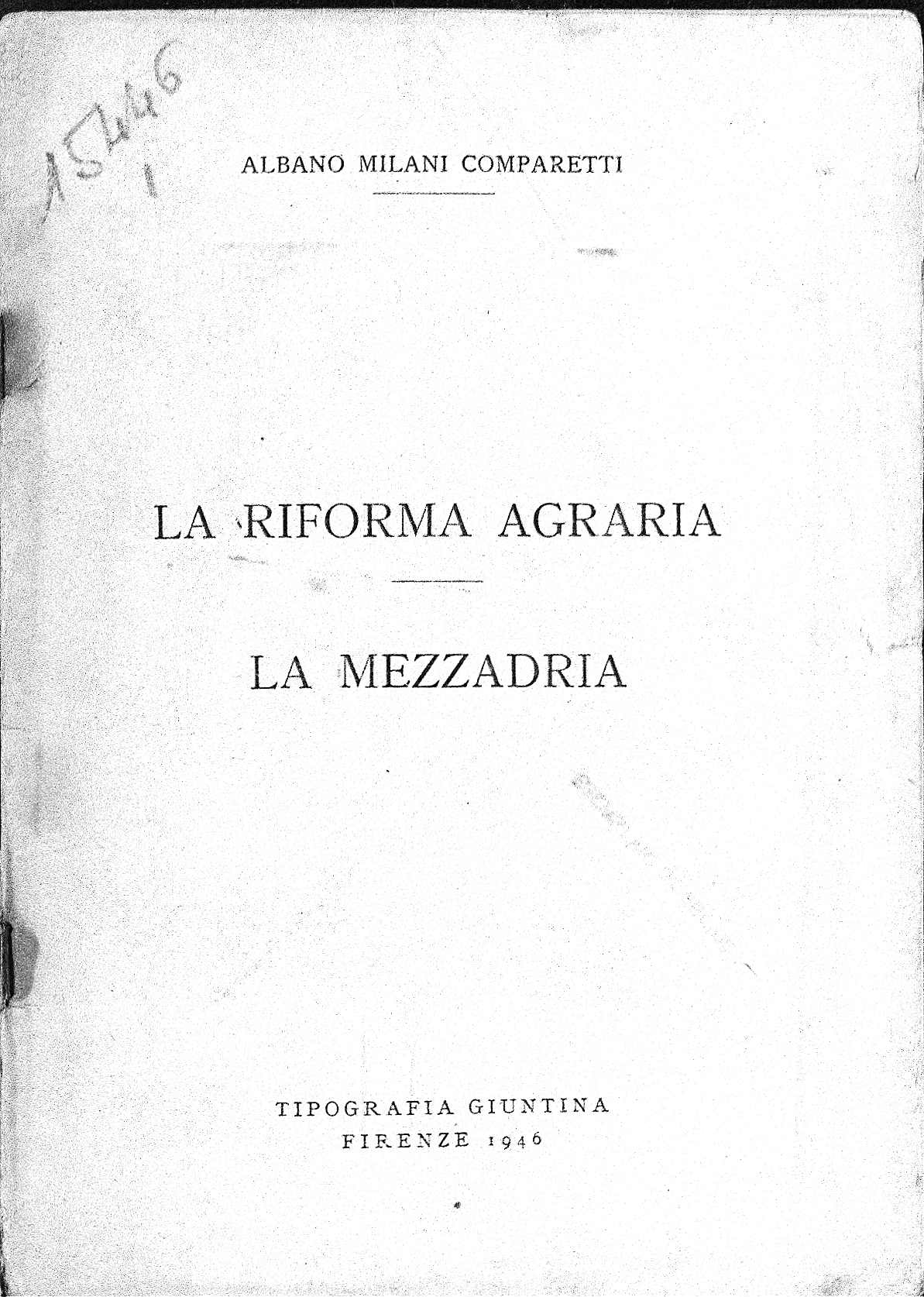



!["In questi giorni i battaglioni squadristi sono inviati in altri teatri operativi. Hanno avuto numerosi scontri con le bande partigiane e bolsceviche nei Balcani. Ecco un reparto di camicie nere in un angolo dei Balcani, durante una purga [Sipho] 8.VI.1943".](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2017/02/Foto-copertina.jpg)
