La Grande Guerra lontano dal fronte. Mobilitazione e assistenza civile in una provincia toscana

Per tutto il periodo della neutralità italiana la provincia di Pisa era stata attraversata da numerose proteste e sia nel capoluogo che nelle campagne non erano mancate manifestazioni di segno antimilitarista, sfociate non di rado in episodi di violenza verso gli interventisti. A una decina di giorni dall’ingresso ufficiale in guerra, il prefetto di Pisa, scrivendo a Antonio Salandra, descriveva tuttavia in termini rassicuranti la realtà di un territorio guardato ancora con preoccupazione. Alla fine di maggio del 1915 la partenza delle truppe era stata infatti salutata ovunque da cortei e da dimostrazioni di giubilo e, stando alle sue stesse parole, «la mobilitazione non fu turbata da alcun incidente» e le «manifestazioni contrarie alla guerra […] furono tutte anteriori alla dichiarazione di guerra e non si rinnovarono dopo».
Ma accanto a queste espressioni simboliche di solidarietà verso l’esercito combattente, si infittirono fin da subito anche una serie di attività ben più tangibili. Nel processo di mobilitazione a sostegno dello sforzo bellico un ruolo di primo piano fu giocato da un tessuto di comitati e organizzazioni in parte riconvertiti alle esigenze imposte dagli eventi ma in larga parte costituitisi ad hoc. Fra le iniziative di nuovo conio, alcune avevano in realtà già preso campo fin dalle settimane precedenti alla rottura della neutralità. In linea con quanto accaduto in diversi centri della penisola, ciò vale soprattutto per la formazione di appositi Comitati di preparazione e mobilitazione civile destinati a svolgere un ruolo di spicco in relazione a diversi ambiti di intervento.

Francobolli del Comitato di Assistenza Civile di Volterra in Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, b. 36.
Tali organismi furono chiamati a svolgere un’azione integratrice dei compiti del governo e degli enti locali, acquisendo un grande peso nel tessuto sociale delle città durante il conflitto. La spinta iniziale alla loro costituzione fu quella di preparare e organizzare i cittadini non soggetti a obblighi militari a garantire la continuazione di tutta una serie di attività nei pubblici servizi e nel campo dell’assistenza in caso di eventuali vuoti da colmare per effetto dello stato di guerra. I Comitati furono poi chiamati a un compito unificante per cercare di raccogliere attorno a sé, con propositi di coordinamento, le altre realtà assistenziali già operanti, prevenendo eventuali dissidi ed evitando gli effetti negativi della dispersione di mezzi ed energie negli aiuti propagandando allo stesso tempo un’immagine di profonda unità e compattezza della nazione impegnata nel sostenere i suoi soldati. L’unanimismo politico, da cui risultano attraversati i loro messaggi e appelli, divenne in effetti uno dei motivi più qualificanti della loro retorica.
Con una tempistica rapida rispetto alla dinamica generale del paese, il primo Comitato di preparazione e mobilitazione civile della provincia sorse a Pisa il 22 marzo 1915 nella sala del Consiglio comunale; la riunione istitutiva fu tuttavia solo il punto di arrivo di un percorso avviato da settimane da un apposito gruppo di cittadini promosso dal professore di chimica agraria Italo Giglioli, sostenitore nei suoi studi di una politica estera fortemente colonialista e fautore di posizioni accesamente nazionaliste, nonché dall’attivismo dell’industriale Giacomo Pontecorvo che, attraverso alcune conferenze, cercò di propagandare le ragioni del movimento a favore della mobilitazione civile raccogliendo al contempo i primi fondi a sostegno dell’iniziativa che il 26 marzo fu presentata alla cittadinanza con un grande manifesto pubblicato.
Nato come un’associazione di privati, il Comitato ricevette fin dagli esordi un occhio di riguardo da parte delle istituzioni locali, esemplificato dalla presidenza onoraria al sindaco Vittorio Frascani e dalla fissazione della sua sede nel palazzo municipale. A infondergli poi una maggiore ufficialità sarebbe venuta in agosto la decisione di trasformarsi in ente morale, al pari di quanto fatto in seguito da altri comitati del territorio, avvalendosi della facoltà del riconoscimento giuridico ammesso da una specifica legge del 25 luglio. Se un po’ ovunque la mobilitazione civile fu una delle principali forme di manifestazione dell’interventismo delle classi dirigenti, che nella gestione dello stato di guerra videro pure un’occasione inaspettata di controllo di mezzi e risorse utile a ribadirne il ruolo di egemonia sociale messo in dubbio dalle crescenti spinte dal basso, ciò che parve connotare il caso del capoluogo fu però la funzione direttiva riconosciuta in essa al mondo universitario, con la larga presenza tanto delle autorità accademiche quanto degli studenti più accesamente interventisti. Un protagonismo che tendeva a rispecchiare la mobilitazione del periodo della neutralità, localmente imperniata su un Ateneo che, in virtù delle sue benemerenze risorgimentali, aveva costituito il nerbo cittadino della campagna per l’intervento. Agli universitari si affiancarono le autorità cittadine, e, ancor più che le casate di origine nobiliare, l’élite borghese locale (ossia agiati appartenenti alle professioni liberali e al mondo degli affari e dell’industria), in cui un ruolo di spicco fu rivestito dalle famiglie della comunità ebraica pisana (i Pontecorvo, i Supino, i Nissim, i Pardo Rooques, i Di Nola), il cui impegno fattivo per il Comitato ne certificò l’intensa partecipazione allo sforzo patriottico.
Nelle aree della provincia il profilo sociale dei comitati assunse invece un tratto più notabilare, e a egemonizzarlo furono effettivamente gli uomini e le famiglie tradizionalmente più illustri dei ceti dirigenti locali. A testimoniare infatti un livello di penetrazione diffuso, e a certificare il grado di coinvolgimento dell’intero paese entro le maglie dello sforzo bellico, il movimento a favore della mobilitazione civile giunse in maniera capillare fin nelle aree più remote dello stesso territorio pisano. Secondo una dinamica in cui a modalità in prevalenza spontanee si unirono rilevanti spinte dall’alto, come quella venuta a inizio giugno da una specifica adunanza di numerosi sindaci della provincia, fra aprile e la fine del mese sia i comuni maggiori, come Volterra o Pontedera, che le realtà meno popolose del vasto contado pisano, come la piccola Orciano Pisano, non mancarono di un proprio attivo comitato.
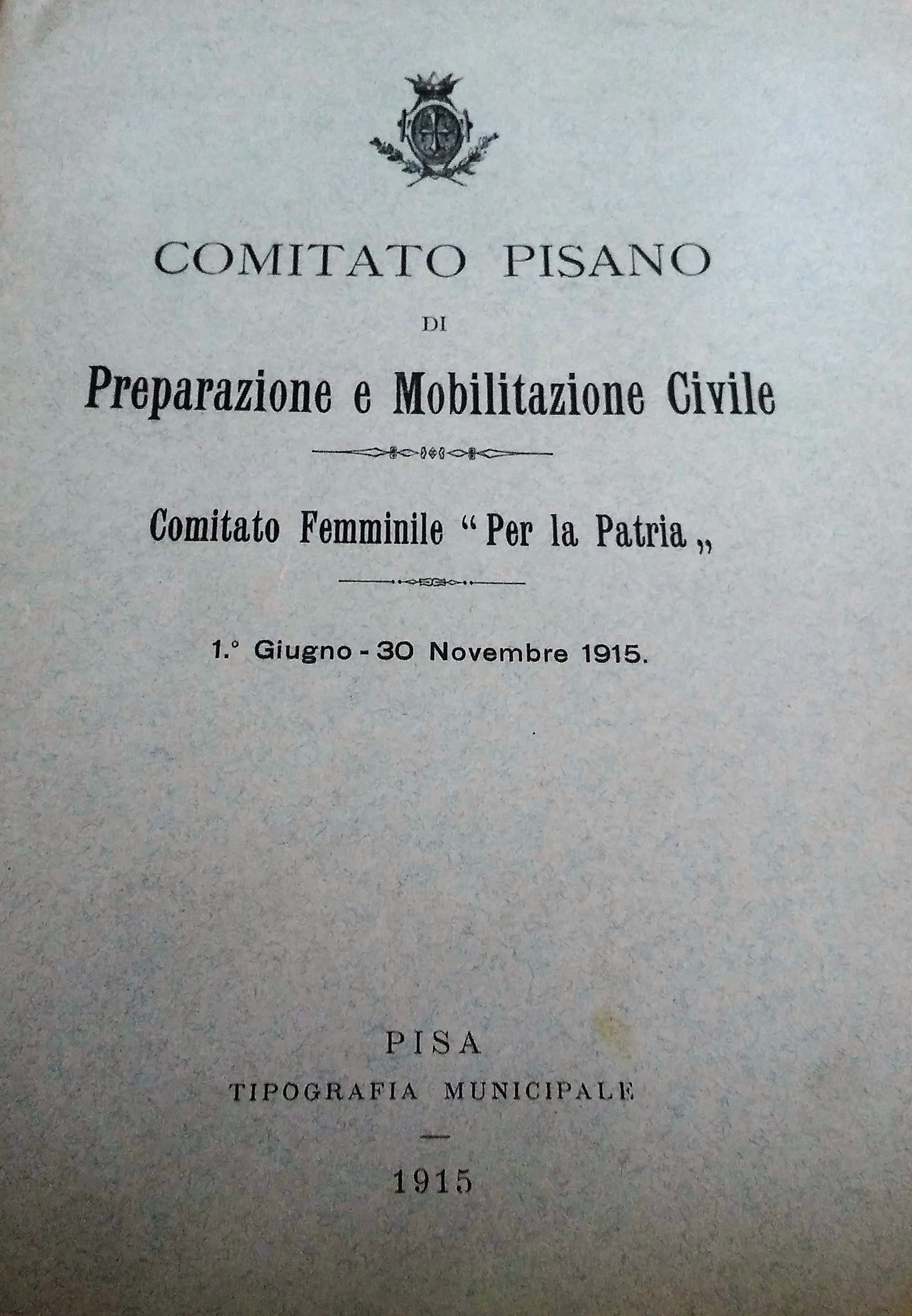
Frontespizio dell’opuscolo Comitato Pisano di preparazione e mobilitazione civile. Comitato femminile per la patria, Pisa, Tip. Municipale, 1915.
La gran parte dei loro fondi vennero da fonti diverse, in varia misura legate alla solidarietà; della somma di 73.842,21 lire raccolta ad esempio nei primi mesi di guerra dal Comitato pisano più della metà giunse da sottoscrizioni occasionali, un restante 40% da contributi regolari mensili e 4.880,55 da soldi provenienti da varie iniziative. Per quanto minoritaria quest’ultima forma di finanziamento ebbe una sua notevole valenza perché raccolta tramite una serie di iniziative che consentivano di abbinare all’attività assistenziale anche quella di propaganda, offrendo all’opera di mobilitazione una visibilità esterna in chiave di forte intonazione patriottica attraverso serate pubbliche in teatri e cinematografi cittadini o con la vendita di oggetti di consumo di larga circolazione (medagliette, distintivi o cartoline). Se passiamo dal piano delle entrate a quello delle uscite, le attività da essi svolte finirono per concentrarsi in primo luogo nella concessione di sussidi in denaro a favore delle famiglie più bisognose dei richiamati, destinata peraltro a crescere esponenzialmente fino a occupare stabilmente i due terzi della spesa complessiva. Le famiglie sovvenzionate, a dispetto di oltre tremila richieste, si attestarono nella sola Pisa a un migliaio, per un esborso di oltre 9.000 lire mensili e con un’obbligata riduzione degli importi. In tale quadro non restavano molte risorse da destinare ad altri ambiti dell’«assistenza civile». Fra i campi di intervento che meritano di essere segnalati vi è tuttavia quello assai importante, per la necessità di attivarsi in sostituzione della dimensione famigliare, dell’assistenza ai figli minori dei richiamati e in cui l’azione principale divenne la gestione dei servizi ricreativi, con la realizzazione di molti ricreatori divenuti un po’ ovunque la seconda voce di uscita dei comitati dopo i sussidi. Altri compiti non irrilevanti furono infine la gestione degli uffici notizie, la confezione degli indumenti militari e, perlomeno nei principali centri, quello dell’assistenza ai soldati degenti negli ospedali e ai profughi.
Ma la citata esplosione dei sussidi e la crescita di di tali compiti resero sempre più evidente col trascorrere dei mesi l’insufficienza delle energie locali, e soprattutto, a dispetto delle attese e delle retoriche solidaristiche che la accompagnavano, della beneficenza privata. Ciò costrinse sempre più tanti comitati a rivolgersi alle istituzioni, e soprattutto al governo, anche perché l’aumento costante del numero dei richiamati produceva un paradosso: se le iniziative assistenziali venivano private delle oblazioni occasionali e in particolare di quelle mensili di molti partenti, le nuove chiamate sotto le armi accrescevano le richieste di intervento di famiglie private del rispettivo capofamiglia. Nel 1917, l’anno più nero della guerra europea, nel quadro dello scambio continuo fra spontaneismo di base e sollecitazioni governative realizzatosi in precedenza, le attività di sostegno al fronte interno dovettero confidare sempre più nell’aiuto di un soggetto erogante come lo Stato, che peraltro già gestiva una propria onerosa politica di sussidi ai richiamati.

Il varco aperto nelle mura su piazza Duomo per facilitare il trasporto dei feriti dal fronte all’ospedale Santa Chiara (Collezione privata)
La quantità di uomini al fronte, le molteplici necessità di una guerra moderna e la natura di molti dei compiti affidati ai comitati, che rimandavano a tradizionali lavori di cura, fecero infine dell’elemento femminile un altro soggetto decisivo del fenomeno della mobilitazione civile. Diverse donne legate alle classi dirigenti e ai notabilati locali, al pari dei rispettivi mariti, ebbero parte attiva nelle vicende della patria in armi, giocando un ruolo rilevante nelle iniziative di sostegno al fronte interno. Appositi comitati femminili sorsero in diverse realtà, come nel caso del comitato Pro-Patria sorto già alla metà di febbraio del 1915 a Pisa per impulso di 23 promotrici quale emanazione del Consiglio nazionale delle donne, espressione di un associazionismo liberale mobilitatosi con grande anticipo all’immediato scoppio della guerra europea. Esso agì in strettissima collaborazione operativa e finanziaria con il Comitato pisano fungendo in sostanza da sua sezione femminile, mentre in alcune realtà figure di donne notabili giunsero persino a presiedere il locale Comitato, come avvenne ad esempio nel caso della piccola comunità di Lajatico per la nobildonna Enrichetta Brenno Gotti Lega.
* Marco Manfredi ha conseguito nel 2005 il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Pisa. Dal 2007 al 2009 è stato borsista postodottorato al Dipartimento di Scienze della Politica dell’Università di Pisa, mentre dall’anno accademico 2009-2010 è Professore a contratto di Storia Contemporanea. Attualmente è collaboratore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella provincia di Livorno.
















