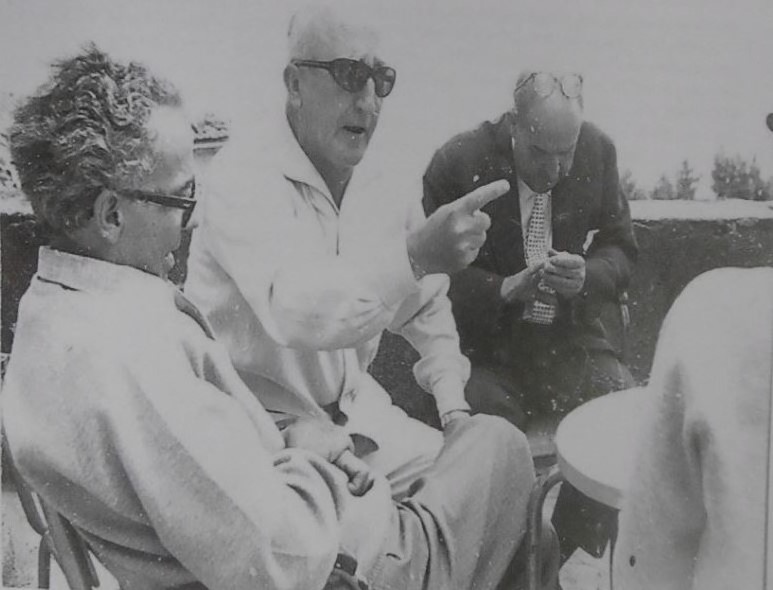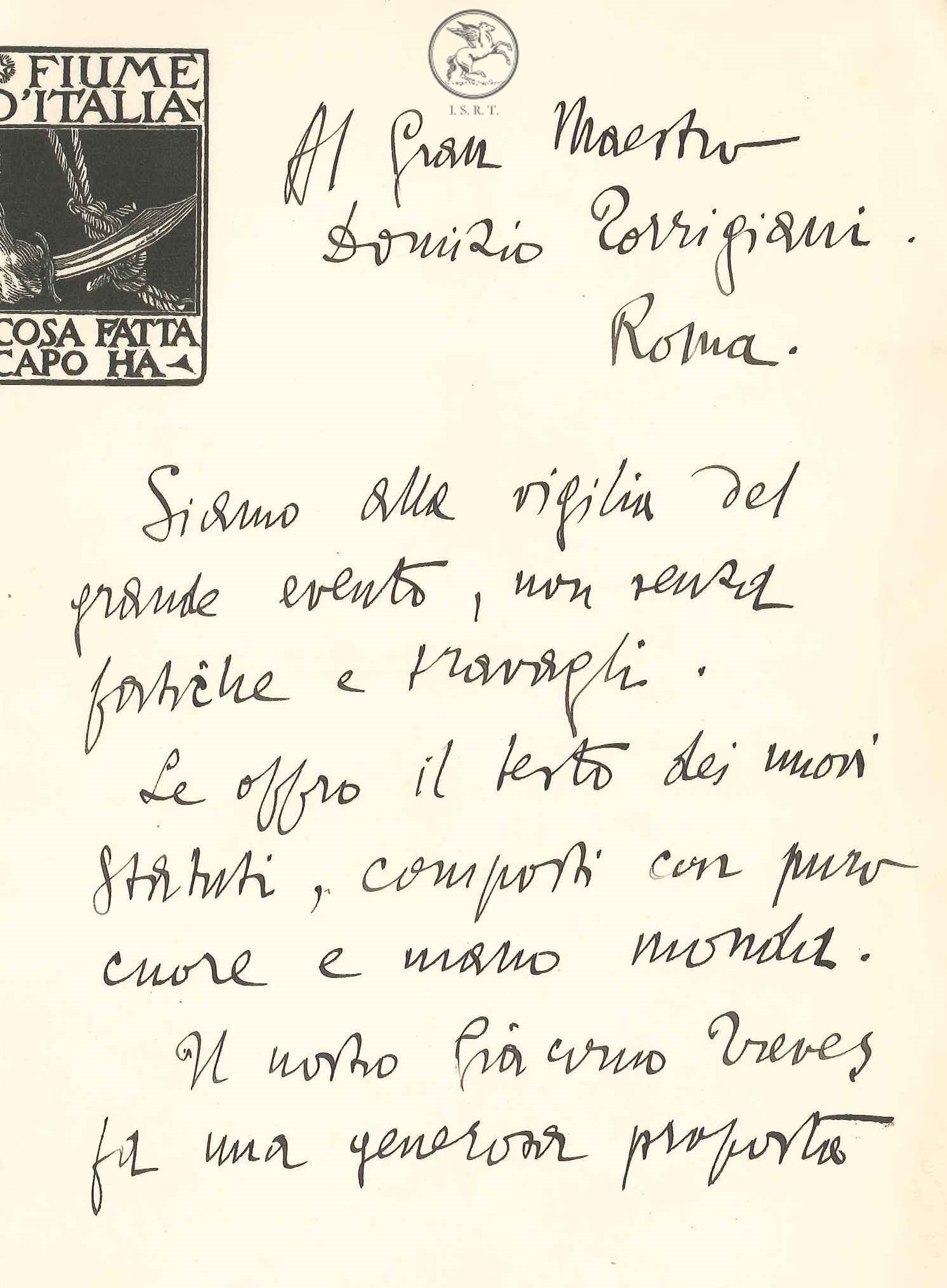Le falegnamerie nell’Alta Val d’Elsa del Secondo Dopoguerra

La zona nord del territorio senese uscì duramente provata dal Secondo Conflitto Mondiale: pesanti bombardamenti raseso quasi a zero la città di Poggibonsi danneggiando gravemente le infrastrutture e buona parte delle attività produttive [1]. Proprio su quelle rovine, tuttavia, nascerà in tempi rapidissimi una vivace economia, per molti aspetti con caratteristiche del tutto nuove a quella prebellica che spesso, almeno nella zona, era in gran parte legata al mondo agricolo circostante.
È ipotizzabile che il vigoroso sviluppo della produzione del mobile in Valdelsa sia avvenuto grazie ad una serie di fattori già presenti che andarono a legarsi alla particolarissima congiuntura storica. Innanzitutto la diffusione di botteghe artigiane dedite alla lavorazione del legno (mobili, infissi e attrezzi prodotti per il comparto agricolo e viti-vinicolo) era piuttosto sviluppata nell’area, ma costituiva una realtà che operava su piccola scala, a causa della modestia delle commesse, e soddisfaceva soltanto la domanda locale. Tale presenza era stata favorita dalla facilità di reperire la materia prima a prezzi modesti (il pregiato legno di castagno proveniente dal Monte Amiata e il legname più scadente ricavato dai boschi delle colline circostanti) e dall’essenzialità degli strumenti di produzione che richiedeva investimenti molto modesti.
Un tale tessuto produttivo dovette, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, misurarsi con il fenomeno dell’abbandono di massa delle campagne che stavolse le strutture sociali ed economiche tradizionali. Per chiarire l’entità dell’esodo si tenga presente il caso della città di Poggibonsi, realtà che, nel 1951, contava 14.387 abitanti (di cui 2278 lavoravano all’industria contro 3396 del comparto agricoltura e 1185 in altre attività); appena dieci anni dopo vivevano nel borgo valdelsano 18.634 persone di cui 8475 lavoratori (ben 4762 erano nel comparto industriale). Il decennio successivo vide un ulteriore incremento di questa tendenza con il definitivo crollo del settore produttivo agricolo (in cui rimasero soltanto 988 addetti su un totale di 10.137 lavoratori) ed il decollo dell’industria (con 6404 addetti) all’interno della quale il settore del mobile faceva la parte del leone (con circa tremila addetti più quelli dell’indotto): nel 1971 Poggibonsi era ormai divenuta una città di dimensioni rispettabili con 25386 abitanti.
 L’incremento delle attività produttive e demografico della cittadina valdelsana è unico in tutta il territorio senese: la vicina Colle Val d’Elsa, una volta volano industriale dell’area, pur avendo un rilevante incremento demografico nel Secondo Dopoguerra (dai 12063 abitanti del 1951 si passò ai 14812 del 1971) rimase ben lontana dai numeri di Poggibonsi ed il suo sviluppo industriale rimase legato a filo doppio alle attività preesistenti come quella del vetro, del cristallo e dei relativi indotti[2].
L’incremento delle attività produttive e demografico della cittadina valdelsana è unico in tutta il territorio senese: la vicina Colle Val d’Elsa, una volta volano industriale dell’area, pur avendo un rilevante incremento demografico nel Secondo Dopoguerra (dai 12063 abitanti del 1951 si passò ai 14812 del 1971) rimase ben lontana dai numeri di Poggibonsi ed il suo sviluppo industriale rimase legato a filo doppio alle attività preesistenti come quella del vetro, del cristallo e dei relativi indotti[2].
Il successo del settore del legno era legato ad una forte domanda ma anche ai buoni profitti legati a vari fattori come le basse retribuzioni delle maestranze di cui una parte rilevante lavorava per ditte artigiane con meno di undici addetti. Nel 1950 un operaio specializzato guadagnava 63,95 lire all’ora, un operaio qualificato 49,75, un manovale specializzato 43,15 lire e un manovale comune 35,45 lire. La manodopera femminile aveva delle retribuzioni più basse mediamente del 20-25% (la parità salariale uomo-donna verrà raggiunta soltanto nel 1962)[3]; facendo un raffronto con i nostri giorni, tenuto conto della contingenza, è possibile calcore che mediamente un operaio valdelsano del comparto legno guadagnava meno degli attuali 500 euro al mese[4].
La contrattazione con gli imprenditori, a partire dagli anni Cinquanta, fu sempre più agguerrita e ben presto, tra le recriminazioni dei lavoratori fece la sua comparsa la richiesta di operare in ambienti più salubri e con idonei dispositivi di sicurezza. Ancora a metà degli anni Ottanta, quando ormai il settore era in piena ristrutturazione, l’83% delle aziende non aveva locali adatti per separare le parti verniciate sottoposte ad essiccazione dagli ambienti di lavoro; disastroso per lo stesso periodo il dato relativo allo smaltimento degli scarti della verniciatura (ritenuti generalmente tossici e nocivi in base al DPR 915 del 1982) in quanto ben l’86% avveniva in modo incongruo[5]. Le malattie professionali più comuni tra i lavoratori del comparto erano quelle dell’apparato repiratorio e olfattivo (causate dalle polveri del taglio e dell’incisione del legno e dai vapori delle vernici) nonché uditivo (sordità da rumore), mentre gli infortuni (ben 244 nel 1983![6]) erano nella maggior parte dei casi ferite agli arti superiori causate dalla sega circolare e dal toupie[7].
Il numero di aziende e di addetti salì in modo costante fino ai primi anni Settanta (rispetto a dieci anni prima si era avuto nella sola Poggibonsi un incremento di addetti alle industrie manifatturiere del 9,7% dato superato soltanto da Monteriggioni – 10,7% – a cui si avvicinava Colle di Val d’Elsa con l’8,5%)[8], per iniziare poi lentamente a calare in seguito allo shock petrolifero del 1973.
La crisi degli anni Settanta mise a nudo le fragilità del comparto del mobile che subì nel primo trimestre del 1975 un calo della produzione del 10,20%, rispetto al periodo precedente, e del 12,80% rispetto allo stesso periodo del 1974. L’analista Giuseppe Tammaro individuava come ragioni della crisi una serie di fattori esterni come le politiche deflattive del biennio ’66-’67, la fine della domanda internazionale e la contrazione della domanda interna a cui il comparto non aveva saputo rispondere efficacemente per una serie di motivi endogeni; in primo luogo, come unico fattore distintivo del prodotto, era stato conservato il carattere artigianale e questo aveva tenuto alti i prezzi; non erano stati fatti studi di marketing per analizzare i gusti della clientela e per cercare nuovi mercati oltre a quelli tradizionali; inoltre il ricorso sempre più massiccio da parte delle (poche) medie industrie al decentramento per contenere i costi della manodopoera e della produzione aveva causato un abbassamento della qualificazione delle maestranze e nessun rinnovo dei macchinari[9].
Ormai il distretto aveva fatto il suo tempo: nel primo semestre del 1986 le industrie del mobile a Poggibonsi erano 36 e davano lavoro a 800 addetti, gli artigiani 280 con mille addetti; rispetto ai tempi d’oro della metà degli anni Sessanta si erano persi più di mille posti di lavoro senza contare l’indotto. La produzione si contrasse progressivamente a laboratori artigiani che producevano mobili e infissi su misura o piccole manifatture che realizzavano componentistica. Una boccata d’ossigeno al settore, ma solo alle industrie, arrivò a fine anni Ottanta con l’esplosione della camperistica, comparto per il quale un pool di aziende, dopo una serie di studi di mercato, iniziò a produrre mobili componibili per poi mettersi in proprio e creare il distretto del camper della Valdelsa[10].
Riccardo Bardotti è insegnante distaccato presso l’Istituto storico della Resistenza senese e dell’età contemporanea.
[1]ANTICHI COSTANTINO, Poggibonsi, Poggibonsi, Tipografia Artigiana, 1965, p.139.
[2]ISTAT, Consistenza della popolazione residente e popolazione attiva distinta per settore di attività economica nei comuni della Provincia di Siena, in Toscana e in Italia al 1951, 1961 e 1971.
[3]AMOC, FILLEA a1, paghe in vigore nelle PAS del 01-11-1950.
[4]www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/14/se-potessi-avere-calcola-il-potere-dacquisto-in-lire-ed-euro-con-la-macchina-del-tempo/
[5]CUCINI EMANUELA, Indagine sulle condizioni di lavoro e di salute nelle aziende del legno della Val d’Elsa senese, Tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di medicina e Choirurgia, a.a. 1987-88, pp.13-14.
[6]AMOC, Zona Valdelsa, VII b1, Unità Sanitaria Locale Alta Val d’Elsa.
[7]CUCINI E., Idem, p.31.
[8]Elaborazione Ufficio Studi dell’Amministrazione Provinciale di Siena su dati ISTAT realizzata nel 1976.
[9]TAMMARO GIUSEPPE, Alcune considerazioni su settore del mobile in Val d’Elsa, lineamenti per un programma di intervento di formazione professionale, Convegno del 28 maggio 1976 organizzato da CGIL CISL UIL.
[10]AISRSEC, Banca delle Memorie, 2017.