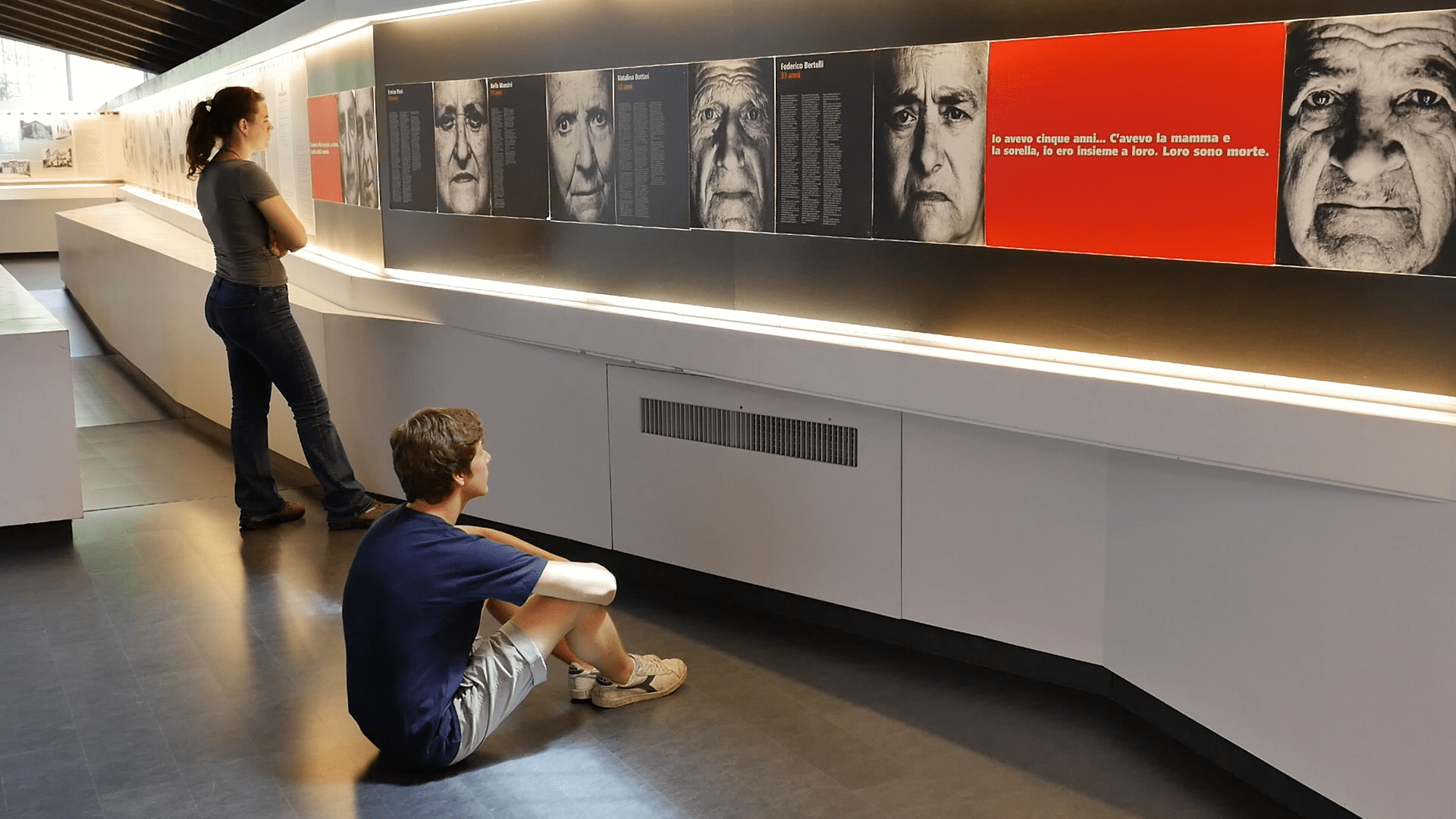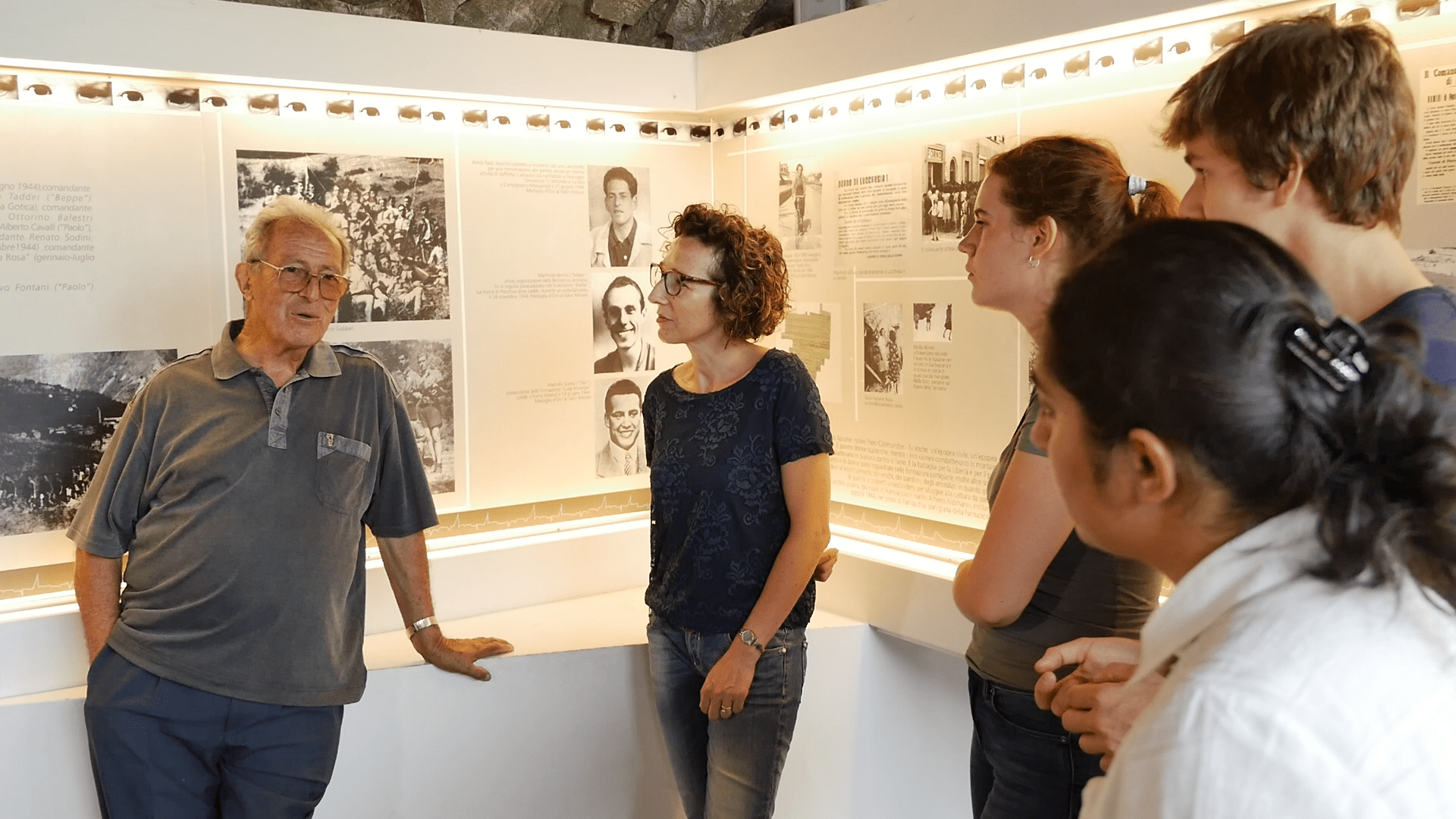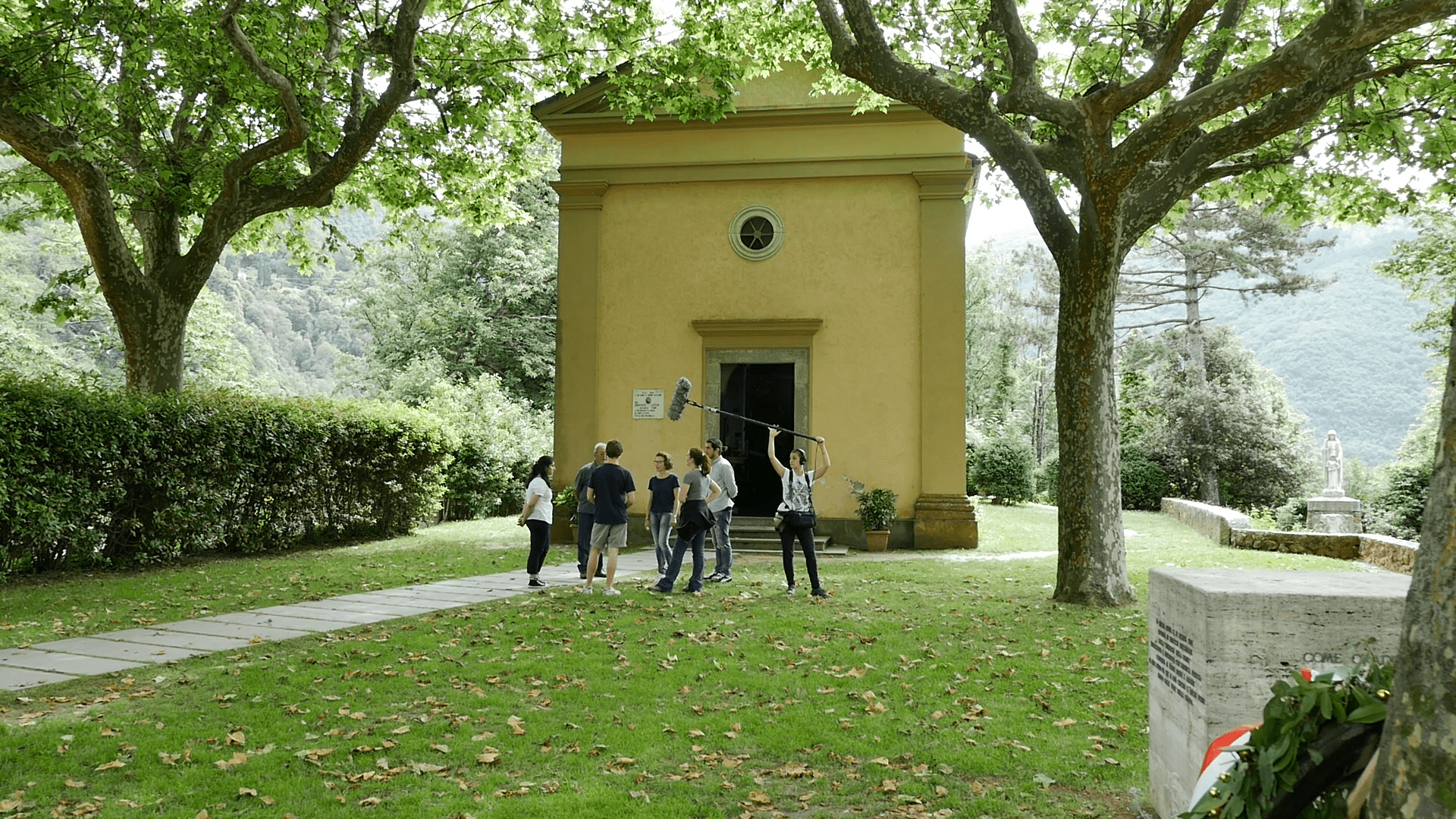Quella “storia ottocentesca” di un figlio di N.N.

Si ringrazia Franco Bertolucci della Biblioteca “Franco Seratini”1 per il tempo messo a disposizione e l’intervista concessa all’autore.
Chiunque abbia vissuto – o anche solo frequentato – per qualche tempo in una città universitaria ricorda certamente, pur senza esservisi soffermato attentamente, il ricco campionario di affissioni, scritte e adesivi che ne coprono i muri: autentica testimonianza di quel caratteristico underground di associazioni, circoli, collettivi e centri sociali vicini all’estrema sinistra e al movimento anarchico, questi veri e propri archivi murali sono particolarmente ricchi nei pressi dei dipartimenti universitari, e la città di Pisa non fa eccezione. In quella che fu una delle capitali italiane del ’68 non c’è angolo dove non ci si imbatta in qualcuno di questi “reperti”: in via Padre Bruno Fedi, dietro al polo universitario Porta Nuova, “A” stilizzate, simbolo dell’anarchia, disegnate con una bomboletta spray a coprire croci celtiche fasciste; scritte nere contro i “ricercatori di morte” e la pratica della sperimentazione animale; adesivi contro la TAV e a sostegno del Rojava, del movimento “Non una di meno” e del recente sciopero mondiale per il clima tenutosi il 15 marzo; in piazza San Frediano, la cui chiesa un tempo ospitava messe in suffragio di Mussolini, svetta una grande falce e martello nera; infine, in via Pietro Toselli, non lontano da Palazzo Gambacorti, sede dell’amministrazione comunale, il volto in bianco e nero di un giovane con i capelli ricci, che ricorda un poco – salvo l’assenza di barba – la celebre fotografia di Che Guevara scattata da Alberto Korda a L’Avana nel 1960. È lo stesso volto la cui fototessera correda una scheda dell’AVIS, che sorride con il pugno alzato sulla prima pagina del settimanale anarchico Umanità Nova – “la polizia ha assassinato un altro nostro compagno”, recita il titolo – e che campeggia sulla copertina della prima edizione del libro di Corrado Stajano “Il sovversivo”, edita da Einaudi nel 1975, a tre anni dalla morte di quel giovane dai capelli ricci che ne era il protagonista.
Cantava il Canzoniere Pisano che “Era il sette di maggio, giorno delle elezioni | e i primi risultati giungan dalle prigioni | c’era un compagno crepato là | era vent’anni la sua età”: le prigioni sono quelle del carcere “Don Bosco” di Pisa, dove il “compagno” ventenne, il giovane anarchico Franco Serantini – questo il nome del giovane “sovversivo”, protagonista dell’omonima ballata del Canzoniere e di molte altre – muore alle 9.45 del 7 maggio 1972, a seguito delle violente percosse subite per mano dei reparti della celere, che hanno caricato il corteo di protesta organizzato da Lotta Continua contro il comizio del parlamentare Giuseppe Niccolai del Movimento Sociale Italiano. Corteo al quale Serantini non aveva partecipato se non nelle sue fasi finali, senza mai unirsi al resto dei manifestanti, dopo aver passato il pomeriggio alla sede del circolo AVIS del quale era socio, vicino alla piazzetta dove Niccolai sta tenendo il proprio comizio: il ragazzo, poco più che uno spettatore isolato, è facile preda dei poliziotti, le cui manganellate provocheranno una emorragia cerebrale fatale per il giovane, nato a Cagliari il 16 luglio 1951 da genitori ignoti (“figlio di nn”), un’infanzia passata fra il brefotrofio, due famiglie adottive e tre diversi istituti: l’ultimo di questi è il riformatorio “Pietro Thouar” di Pisa, dove il giovane viene mandato nel 1968, dopo una breve permanenza presso l’Istituto per l’osservazione dei minori di Firenze. La sua è una “storia ottocentesca”, ha scritto Stajano “ai limiti dell’invenzione settaria”, quella di un giovane “alla ricerca di qualcosa che lo compensi di ciò che non ha mai avuto” e finisce per trovarlo – come molti suoi coetanei – nel gusto dell’attivismo politico, avvicinandosi inizialmente alle organizzazioni giovanili di PCI e PSI, poi a Lotta Continua e infine aderendo al gruppo anarchico “Pinelli” di Pisa alla fine del 1971. Soltanto pochi mesi dopo Franco avrebbe trovato la morte, vittima di una intera catena che va ben oltre i poliziotti che l’hanno massacrato in Lungarno Gambacorti, e passa per le guardie e il personale medico del carcere fino al procuratore generale Mario Calamari, che cerca di ostacolare le indagini sull’accaduto: Serantini entra suo malgrado in quella genealogia di vittime delle forze dell’ordine – e di uno Stato venuto meno al proprio ruolo, sancito dalla Costituzione – che arriva fino ai giorni nostri: la Scuola Diaz, Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi.
Fin dai giorni immediatamente successivi alla sua morte, quella del giovane anarchico figlio di nn – fa notare Franco Bertolucci, ideatore della biblioteca “Franco Serantini” e fondatore della BFS edizioni – è una memoria che divide profondamente la città: una parte di essa, la Pisa conservatrice della borghesia e dei baroni universitari, già ostile alle istanze studentesche e operaie di fine anni ’60 – bollate in toto come “violente”, nonostante la violenza sia soprattutto quella delle forze dell’ordine – “non ha voluto condividere la memoria di Serantini per una scelta di classe, di opposizione a quelle rivendicazioni giudicate “moralmente nefaste”, che mettevano in discussione poteri e privilegi acquisiti a cui non si voleva rinunciare”. Contro questa damnatio memoriae si erge però tutta quella parte della società che vuole invece conservare e tenere vivo il ricordo di Franco: una memoria, sottolinea ancora Franco Bertolucci, nella quale si possono riconoscere tre livelli: uno intimo e personale; uno collettivo e laico; infine uno di natura politica. “Il caso Serantini”, afferma Bertolucci, “coinvolge persone, amici e conoscenti di Franco, fortemente colpiti da questa tragedia e che negli anni, individualmente, hanno cercato di mantenere vivo questo ricordo attraverso gesti “anonimi” che testimoniano questo affetto: […] i mazzi di fiori, i bigliettini e le poesie lasciati sulla tomba o nei pressi del monumento, ma anche alcune lettere inviate nel tempo alla nostra stessa biblioteca e/o a riviste”.
Su questo primo livello se ne innesta un secondo “laico e civile, di quella parte della città che ha adottato Serantini post mortem, perché resasi conto della grave ingiustizia da egli subita, e facendo sì che la sua memoria non restasse nel libro dei ricordi di una comunità ristretta”: è l’opera di tutta quella parte della società civile che si impegna per la verità giuridica (nel 1974 gli avvocati Massei e Sorbi promuovono la costituzione di un “Comitato giustizia per Franco Serantini”) e per valorizzare gli ideali e le utopie di Franco, tramite la ricchissima produzione intellettuale di scrittori, artisti e musicisti nel corso degli anni, da Franco Fortini a Costantino Nivola fino allo stesso Stajano, il cui libro permette di far conoscere la vicenda in Italia e all’estero. La stessa Biblioteca Serantini, fondata nel 1979, è un importante tassello di questo mosaico, che negli anni ha promosso tante iniziative nel ricordo di Franco, contribuendo all’inaugurazione del monumento che ancora oggi si trova in piazza San Silvestro (o, come la chiamano ancora oggi i militanti anarchici e della sinistra radicale, “piazza Serantini).
Da ultimo si situa il livello politico della memoria del Serantini militante rivoluzionario, anarchico e antifascista: una memoria entrata fin da subito nel patrimonio dei circoli libertari e dell’estrema sinistra, della quale il nostro piccolo adesivo seminascosto in via Toselli non è che una testimonianza. Ancora oggi le organizzazioni che popolano l’underground della sinistra pisana rivendicano questa memoria, ciascuno secondo le sfumature della propria formazione politico-culturale. Un esercizio della memoria che dura tuttora, e che, ricorda ancora Bertolucci, è parte di una più vasta battaglia: non più giuridica – in quasi cinquant’anni nessun rappresentante istituzionale ha mai riconosciuto l’ingiustizia inflitta a Serantini – ma storica, nel momento in cui questa battaglia assume, oggi più che mai, una valenza che è anche politica.
1La Biblioteca “Franco Serantini” ha lanciato una campagna nazionale di sottoscrizione per l’acquisto di una nuova sede: tutte le informazioni a questo link.