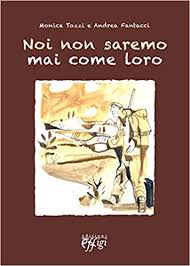Mercoledì 24 febbraio si è tenuto sulla piattaforma zoom un seminario dal titolo “Il Giorno del Ricordo: la complessa vicenda del confine orientale”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’USR Toscana, rappresentato dalla Dottoressa Milva Segato -che ha introdotto l’argomento partendo dal testo di legge e citando due discorsi, quello del 2019 e quello del 2021 del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella,- dall’Università di Firenze, ed in particolare il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, rappresentato della Professoressa Silvia Guetta, Professore associato di Pedagogia generale e sociale, e dalla rete toscana degli Istituti Storici della Resistenza e dell’età contemporanea. Sono intervenuti la Professoressa Chiara Nencioni, il Direttore dell’Istituto della Resistenza Toscano Matteo Mazzoni e il Vivepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca, Armando Sestani.
Si riporta di seguiti l’art. 1 della Legge 30 marzo 2004 n. 92, da cui il seminario ha preso titolo:
«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».
La prima relatrice ha tracciato la storia del nostro “confine orientale” dalla Terza Guerra di Indipendenza all’invasione dei Balcani da parte italiana.
Nel 1866 in seguito alla guerra che vide confrontarsi la Monarchia Asburgica con il Regno di Prussia e il Regno d’Italia, venne a configurarsi un nuovo confine tra Austria e Italia. Il confine tra Italia e Austria fu stabilito con la Pace di Vienna del 3 ottobre 1866.
Tale confine risultò dall’annessione all’Italia delle province del Veneto; in particolare la provincia italiana a ridosso della linea confinaria era quella di Udine, mentre il territorio austriaco immediatamente confinante comprendeva due Länder: la Carinzia a nord, con capoluogo Klagenfurt, e il Litorale ad est, con capoluogo Trieste.
Nell’impero austro-ungarico le varie etnie presenti sul territorio avevano mantenuto una certa autonomia: vi era libertà di associazione ed era possibile frequentare scuole in cui le lezioni erano impartite nella propria lingua, anche se esse non erano sempre ben distribuite sul territorio, mentre gli istituti con lingua di insegnamento tedesca erano presenti ovunque.
Come si evince dal censimento del 1910 nella Venezia Giulia vivevano allora circa 400.000 sloveni, 100.000 croati, poco meno di 500.000 italiani.
Nel 1915 con il Patto di Londra, accordo segreto d’alleanza fra Italia, Gran Bretagna, Francia, Russia, l’Italia aderiva all’Intesa e si impegnava a entrare in guerra contro gli imperi centrali.
Gli accordi prevedevano come compensi territoriali a favore dell’Italia il Trentino, il Tirolo del Sud (Alto Adige), Trieste, Gorizia, l’Istria e la Dalmazia, ma escludevano Fiume, non riuscendo a immaginare un disfacimento totale dell’Austria-Ungheria.
Il patto prevedeva inoltre una partecipazione italiana alla spartizione dell’Albania e all’eventuale spartizione della Turchia e delle colonie tedesche in Africa.
Nel novembre 1918, alla conclusione della prima guerra mondiale, la Monarchia Asburgica cessò di esistere e al suo posto si formarono nuovi Stati, tra cui l’Ungheria e la Jugoslavia (che allora assunse la denominazione di Regno dei Serbi, Croati e Sloveni).
La definizione dei nuovi confini tra Austria e Italia fu definita alla Conferenza della Pace di Parigi, con il trattato di St. Germain (10.9.1919).
Dopo la prima guerra mondiale con il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 ci fu l’annessione al Regno d’Italia di territori ampiamente popolati da sloveni e croati. La vittoria del regno sabaudo nel conflitto del ‘15-‘18 non poté non portare nella Venezia Giulia “redenta” alla rottura dell’equilibrio tra le diverse etnie costruito nei secoli precedenti.
Le difficoltà derivavano dall’inconciliabilità delle richieste italiane, basate sul Patto di Londra del 1915, con quelle del nuovo stato balcanico, fondate sulla presenza di popolazioni slovene e croate nell’ambito dei territori ex-asburgici rivendicati dall’Italia.
Le difficoltà non furono superate nemmeno dalla proposta del presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, di una linea di confine a carattere prevalentemente etnico.
Durante il dibattito parlamentare sul Trattato di Rapallo (24-27 novembre 1920) il governo italiano promise la tutela della minoranza slava ed il ministro degli Esteri, il conte Sforza, confermò tale intenzione, presentandola come una “questione d’onore e di ragionevolezza politica”. Di fatto, però, non si prese nessun impegno concreto nei confronti delle minoranze nazionali e anche per questo molti sloveni decisero di emigrare nel nascente regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni (poi Jugoslavia), che era sorto oltre frontiera nei Balcani.
Una variazione rilevante nel tracciato dei confini nella zona dell’Alto Adriatico riguardò il territorio di Fiume, che fu annesso all’Italia, in base all’Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, tra Regno d’Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In base ad esso, parte del territorio settentrionale dello Stato Libero di Fiume e Porto Baross vennero ceduti alla Jugoslavia, mentre la città e una ridotta striscia costiera passarono all’Italia. Venne così costituita nel 1924 la Provincia di Fiume, costituita dal territorio fiumano annesso e da alcuni comuni già appartenenti alla provincia di Pola.
L’avvento del fascismo in questi territori segnò un momento di ulteriore impoverimento dei diritti nazionali sloveni e croati. Fu messa in atto un’italianizzazione forzata, accompagnata da persecuzioni e umiliazioni, in vista dell’assimilazione. A Trieste il 13 luglio 1920, fu incendiato il Narodni dom (La casa nazionale), edificio simbolo della presenza slava a Trieste, centro polivalente dotato di albergo, ristorante, caffè, teatro, banca, uffici, appartamenti. Successivamente la catena di eventi persecutori da parte di squadre fasciste nei confronti della popolazione slovena e croata della Venezia Giulia si intensificò: dopo l’incendio del Narodni dom di Trieste fu la volta di quello di Pola e di altri 134 edifici dell’intera Venezia Giulia distrutti entro il 1920. Le aggressioni e le spedizioni squadristiche ripresero dopo le elezioni del 1921, che videro a Trieste e in Istria il successo del Blocco Nazionale capeggiato dai fascisti. Tali violenze furono l’inizio di una dura politica di oppressione etnica che il fascismo e nazionalismo triestini e giuliani perseguirono per tutto il ventennio nei confronti della minoranza slava. Fu messa in atto un’opera di snazionalizzazione violenta e capillare, di italianizzazione e fascistizzazione della Venezia Giulia. Nel giro di qualche anno l’italiano divenne l’unica lingua ufficiale in tutta la Venezia Giulia. Il divieto di comunicare in sloveno e croato si estese dai pubblici uffici ad altri luoghi di lavoro (fabbriche, ditte private, trattorie, negozi) pena il licenziamento, ammonimento o ritiro dell’autorizzazione all’esercizio. Si imposero il divieto di pubblicare testate periodiche e lo scioglimento di circoli sportivi e culturali, istituti bancari, casse di credito e cooperative. Le autorità fasciste cercarono di proibire scritte slovene e croate anche sulle pietre tombali e sui nastri delle corone di fiori che accompagnavano il feretro. Con il Regio Decreto n. 800 del 29 marzo 1923 venne dato compimento all’opera di italianizzazione dei toponimi iniziata dalle autorità militari italiane subito dopo la fine della guerra: i nomi di paesi, città, località geografiche vennero italianizzati arbitrariamente, senza alcun criterio scientifico. La Riforma Gentile (1923) prevedeva l’introduzione obbligatoria dell’italiano in tutte le scuole del Regno. Come conseguenza fu gradatamente imposta la chiusura coatta delle scuole di tutti i gradi con lingua d’insegnamento slovena o croata. La scuola, pertanto, da ambiente multiculturale quale era stato sotto l’impero austro-ungarico, divenne un luogo chiuso e selettivo. Di circa un migliaio di insegnanti slavi ne rimasero solo una cinquantina e di questi solamente cinque nella Venezia Giulia. La proibizione dell’uso delle lingue “locali” fu affiancata dall’italianizzazione forzata dei cognomi. Il R.D. del 7 aprile 1927, estendendo alla Venezia Giulia il decreto emanato per l’Alto Adige il 10 gennaio 1926, imponeva la “restituzione in forma italiana dei cognomi originariamente italiani snazionalizzati”. Gli elenchi dei cognomi da italianizzare vennero completati fra il 1928 e il 1931.
Anche preti sloveni e croati furono vittime di aggressioni e violenze da parte di squadre fasciste.
Degli atti repressivi perpetrati dal regime fascista negli anni venti e trenta manca una statistica precisa: non si conosce il numero esatto di insegnanti, impiegati statali, sacerdoti trasferiti d’ufficio dalla Venezia Giulia nelle diverse regioni della penisola, oppure costretti al prepensionamento o alla scelta dell’esilio nel vicino Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni (poi Jugoslavia).
Saranno proprio l’élite slovena espulsa o emigrata nel Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni durante il ventennio, nonché gli strati più politicizzati della popolazione slovena rimasti nell’Italia fascista, a dare un ampio sostegno al movimento di liberazione e al progetto di annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia di Tito, in quanto spinti da sentimenti di rivalsa.
L’apice dell’attività terroristica della rete clandestina triestina, la Borba, ovvero “Lotta”, fu rappresentato dagli attentati al Faro della Vittoria e alla tipografia di “Il Popolo di Trieste”, l’organo del Pnf locale, avvenuti nel febbraio del 1930.
Il 10 febbraio 1930 fu fatta esplodere una bomba alle 22.30, in un momento in cui si riteneva che la sede dovesse essere vuota. L’esplosione provocò una vittima, il redattore Guido Neri, che morì qualche giorno dopo, e tre feriti, membri del partito.
Nel settembre 1930 il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato si trasferì a Trieste, con lo scopo di giudicare in un maxiprocesso i responsabili degli attentati e di stroncare definitivamente il movimento ribellistico nel triestino.
Dopo un breve dibattimento, durato meno di una settimana dall’1 al 5 settembre, alle 5.44 del 6 settembre 1930, quattro giovani di età compresa tra i 24 ed i 34 anni, 2 sloveni, 1 croato e 1 di madre italiana e di padre sloveno, ritenuti i principali colpevoli delle attività della Borba, furono portati al poligono di tiro di Basovizza e fucilati alle spalle da un plotone di esecuzione della 58° Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Dopo la liberazione dal nazi-fascismo, il 9 settembre 1945 fu inaugurato un monumento in memoria dei quattro “eroi di Basovizza”, divenuti un simbolo di libertà e di lotta, non solo per gli sloveni, ma anche per l’antifascismo italiano. Il confine del 1924 durò invariato fino al 1941, ma gli stati confinari mutarono denominazione e anche caratterizzazione ideologica: il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni divenne tra il 1929 e il 1931 Regno di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria nel 1938 venne annessa al Terzo Reich, con il nome di Ostmark.
Riprende qui la complessa storia del confine orientale Matteo Mazzoni, che si concentra sull’argomento delle violenze nel periodo della seconda guerra, con un particolare approfondimento sulle foibe.
L’aggressione al Regno di Jugoslavia, iniziata il 6 aprile 1941 da parte dell’Italia, assieme alla Germania, all’Ungheria e alla Bulgaria segnò il legame più stretto delle responsabilità italiane con quelle del nazismo hitleriano. L’occupazione militare italiana di territori jugoslavi segnò la massima espansione del Regno d’Italia verso oriente; in particolare venne unito all’Italia un ampio territorio della Slovenia e della Dalmazia.
Le città di Lubiana, Novo Mesto e Kocevje, e il loro territorio, vennero a costituire la Provincia “italiana” di Lubiana. Anche la Provincia di Fiume venne ampliata con il territorio; più a sud lungo la costa Dalmata vennero annesse all’Italia con le stesse modalità le città di Spalato, di Cattaro e un’ampia porzione attorno alla città italiana di Zara; tale territorio venne denominato Governatorato di Dalmazia (comprendente tre province). Altre occupazioni italiane interessarono la parte più meridionale della Dalmazia, con l’ampliamento dell’Albania e con l’invasione del Montenegro.
Il Terzo Reich e l’Ungheria occuparono nel 1941 la parte settentrionale della Slovenia e altre regioni jugoslave. Nella parte centrale dei Balcani (Croazia e Bosnia) venne costituito un vasto stato collaborazionista, denominato Stato Indipendente Croato, affidato al capo ustaša Ante Pavelić.
Nelle zone occupate in cui era attivo il movimento partigiano, gli Italiani adottarono pratiche repressive estreme, compiendo crimini di guerra. Gli ordini impartiti, fra cui la circolare 3C del generale Roatta del marzo 1942, configuravano una vera e propria «guerra ai civili». Le azioni antiguerriglia prevedevano arresti, prese di ostaggi, fucilazione degli ostaggi medesimi, distruzione dei paesi, uccisione degli uomini e deportazione di donne e bambini. In particolare, nelle zone in cui l’esercito italiano non riusciva a venire a capo della ribellione, provvide a svuotare il territorio con la deportazione in massa della popolazione. I deportati furono alcune decine di migliaia, reclusi in un gran numero di campi di concentramento collocati sulle isole dalmate e nella penisola italiana. I più famigerati furono quelli di Gonars in Friuli e dell’isola di Arbe. ll campo di concentramento di Arbe fu creato nel luglio del 1942 nell’odierna isola di Rab ed ospitò complessivamente tra i 10.000 e 15.000 internati tra sloveni, croati ed ebrei diventando il più esteso e popolato campo di concentramento italiano per slavi raggiungendo i 21.000 internati nel dicembre 1942. Con l’arrivo della stagione autunnale la situazione nel campo divenne più difficile: le piogge provocarono più volte il riversamento del liquame delle latrine e la notte del 29 ottobre 1942 una violenta tempesta distrusse quattrocento tende e provocò l’annegamento di alcuni bambini. Il campo si caratterizzò per la durezza del trattamento riservato agli internati, dei quali un gran numero perì di stenti e malattie.
Qui la mortalità fu assai elevata per le pessime condizioni igieniche ed abitative e la sistematica denutrizione. Questi i cinici commenti del generale Gambara: «Campo di concentramento non significa campo di ingrassamento. Individuo malato = individuo che sta tranquillo».
Dal novembre 1942 il numero di internati diminuì per la partenza per altri campi di concentramento, soprattutto di donne e bambini destinati al campo di Gonars.
ll campo di concentramento di Gonars, realizzato dal regime fascista nell’autunno del 1941 in provincia di Udine in previsione dell’arrivo dii prigionieri di guerra russi, fu utilizzato dalla primavera del 1942 per l’internamento dei civili all’interno della “Provincia occupata di Lubiana”, rastrellati dall’esercito italiano e ritenuti potenziali oppositori. Il campo si si riempì nell’autunno inverno 42-43 di nuovo tipo di internati: uomini, donne, vecchi e bambini rastrellati dai paesi vicino fiume e prima deportati nell’isola di Rab. Nel campo di Gonars sono state internate circa 6000 persone di cui oltre 500 morirono di fame e di malattie. Come tutti gli altri campi italiani per internati jugoslavi, il campo di Gonars funzionò fino al settembre del 1943.
A partire dal 1942 anche nelle province giuliane di Fiume, Trieste e Gorizia le autorità italiane adottarono pratiche repressive. Va segnalata ad esempio la strage compiuta nel luglio 1942 nel paese di Podhum, nei pressi di Fiume, in cui vennero uccise una novantina di persone, cioè tutti i maschi adulti del villaggio. Sempre nel 1942 venne costituito l’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, specificatamente dedicato alla lotta antipartigiana mediante l’infiltrazione e la tortura. Dal settembre del 1943 l’Italia non fu più un paese occupante, ma occupato a sua volta dai Tedeschi nel corso dell’estate-autunno; nella parte nord orientale d’Italia l’occupazione tedesca ebbe conseguenze diverse rispetto ad altre regioni d’Italia, in quanto il territorio delle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubiana venne escluso dal controllo politico e militare delle autorità italiane, cioè della Repubblica Sociale Italiana, lo stato collaborazionista costituito da Benito Mussolini. Mentre nelle altre zone di Italia, specialmente al centro-sud, si festeggiava l’armistizio e si nutriva la speranza di una liberazione, sul “confine orientale” l’8 settembre significò passare sotto il Reich, quindi orrore su orrore: oltre a quello della guerra, quello della feroce occupazione nazista.
Le del nord-est province, con il nome di “Zona di Operazione Litorale Adriatico”, vennero amministrate direttamente dalle autorità tedesche: Friedrich Rainer fu nominato Commissario Supremo. Una situazione analoga coinvolse le province di Bolzano, Trento e Belluno, denominate “Zona di Operazione Prealpi” e affidate al Commissario Supremo Franz Hofer. Proprio in corrispondenza del cedimento militare italiano, tra settembre e ottobre del 1943, nella parte mediana dell’Istria fu attuata un’insurrezione popolare (molto composita riguardo alle motivazioni), che ebbe come conseguenza l’uccisione di circa 500 abitanti, per lo più italiani (evento noto come “foibe istriane”); all’insurrezione popolare fece seguito una feroce rappresaglia delle truppe tedesche che provocò circa 2.500 vittime nel mese di ottobre.
Che cosa è una foiba? Dal latino fovea, sloveno e croato jama, vuol dire “inghiottitoio”. Geologicamente è tipica dei terreni carsici. L’imboccatura può essere larga da alcuni centimetri ad alcuni metri e il pozzo può sprofondare per molte decine di metri, anche con più salti. Nel solo Carso triestino ed in quello goriziano si trovano alcune migliaia di cavità di vario tipo ed il medesimo terreno è diffuso in Slovenia e Croazia.
Storicamente, le foibe sono state utilizzate episodicamente come depositi di materiali di scarto. Durante la seconda guerra mondiale ed il dopoguerra, sono state intensivamente adoperate per far sparire i cadaveri di caduti in combattimento e/o vittime di eccidi, data la difficoltà di scavare fosse comuni nel terreno roccioso. Tale uso in Croazia è attestato fin dal 1941. Nella Venezia Giulia sono state adoperate allo stesso modo nell’autunno del 1943 (particolarmente nota la foiba di Vines, in Istria) e nella primavera/estate del 1945 (note la foiba Plutone, vicino Trieste; le foibe di Gargaro e Zavni in provincia di Gorizia; la foiba di Costrena nei pressi di Fiume). Il termine foiba è correntemente usato per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria e del maggio 1945 in tutta la Venezia Giulia per opera del movimento di liberazione jugoslavo (autunno 1943) e dello stato jugoslavo (primavera 1945), occasioni nelle quali i corpi delle vittime vennero spesso gettati nelle foibe, di solito dopo fucilazione collettiva. Va precisato che l’infoibamento non era una modalità di uccisione, ma di occultamento delle salme, legato in genere alla difficoltà nello scavo di fosse comuni. Risultano pochissimi casi in cui nell’abisso furono gettate persone ancora vive, specie per errori nella fucilazione. In secondo luogo, non tutte le vittime delle stragi conclusero la loro vita nelle foibe. Molti, forse la maggior parte, trovarono la morte in prigionia. La prima ondata di infoibamenti sono le cosiddette foibe istriane, definizione correntemente usata per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria. Dopo la capitolazione italiana dell’8 settembre, per poco più di un mese la penisola istriana cadde per la maggior parte sotto il controllo del movimento di liberazione croato (jugoslavo), che vi applicò le pratiche di lotta che prevedevano nelle zone anche solo temporaneamente liberate, l’immediata eliminazione dei «nemici del popolo». Questa era una categoria che nel caso dell’Istria riguardava alcuni segmenti di classe dirigente italiana particolarmente invisi ai partigiani, per il loro ruolo svolto nel regime fascista (gerarchi, squadristi), nelle istituzioni (podestà, segretari comunali) e nella società locale (possidenti terrieri, commercianti ed artigiani accusati di strozzinaggio) o comunque ritenuti pericolosi per il nuovo potere.
Le nuove autorità organizzarono gli arresti, la concentrazione dei prigionieri in alcune località specifiche, come Pisino, i processi sommari e le conseguenti fucilazioni collettive, seguite dall’occultamento dei cadaveri nelle foibe o in cavità minerarie. Si trattò quindi di una violenza dall’alto, programmata e gestita dai quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo). Peraltro, essa fu gestita in un clima di grande confusione, segnato da forme di ribellismo dei contadini croati in una sorta di jacquerie -come afferma Mazzoni-, nel quale trovarono spazio estremismo nazionale, conflitti d’interesse locali, motivazioni personali e criminali, come nel caso di alcuni stupri seguiti da uccisioni, fra i quali assai noto quello di Norma Cossetto. Per le stragi del 1943 l’ordine di grandezza è delle centinaia (le stime variano da 500 a 700).
La durezza dell’occupazione tedesca nel Litorale Adriatico emerse dall’uso repressivo di una struttura industriale, già esistente, con la funzione di Polizeihaftlager (Campo di Detenzione di Polizia): si tratta della Risiera di San Sabba -l’unico campo di concentramento con un forno crematorio sul territorio italiano- al cui interno funzionò un forno crematorio per l’eliminazione dei cadaveri dei prigionieri uccisi (in gran parte politici e partigiani sloveni, croati, italiani). La Risiera fu usata anche come campo di transito per gli ebrei, da qui deportati verso i lager in territorio tedesco e polacco.
La fase conclusiva della seconda guerra mondiale aprile-maggio 1945 si presentò nell’area del Litorale Adriatico con due eserciti in movimento verso nord e in parte convergenti verso i centri urbani principali: dai Balcani la IV Armata jugoslava puntò decisamente su Trieste e su Gorizia, mentre dalla linea gotica partì l’offensiva anglo americana, con obiettivi strategici non limitati al nord Italia o alla Venezia Giulia, ma estesi anche all’Austria e alla Germania.
Accompagnato o preceduto da insurrezioni partigiane locali contro le forze naziste, il ritiro tedesco fu determinato dall’arrivo il 1° maggio 1945 dei militari della IV Armata jugoslava, che occuparono Trieste, Gorizia e la valle dell’Isonzo, e dalle truppe neozelandesi dell’esercito britannico giunte nello stesso territorio il 2 maggio. Il controllo delle città di Gorizia e di Trieste venne lasciato all’esercito jugoslavo, giunto per primo, ma senza determinare inizialmente una precisa linea di separazione delle zone di competenza dei due eserciti alleati. E’ in questo periodo che si verifica la seconda ondata di infoibamenti, le cosiddette foibe giuliane, definizione correntemente usata per indicare le stragi del maggio 1945 nella Venezia Giulia. Le truppe jugoslave che occuparono la regione il 1maggio vi rimasero fino al 9 giugno, data dopo la quale si ritirarono ad est della linea Morgan, mentre ad ovest della linea medesima fu instaurata un’amministrazione militare angloamericana. Durante l’occupazione si verificò l’estensione alla Venezia Giulia delle pratiche repressive tipiche della presa del potere in Jugoslavia da parte del fronte di liberazione a guida comunista, accompagnata da una grande ondata di violenza politica, che nell’arco di poche centinaia di chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia fece circa 9.000 morti fra gli sloveni domobranzi, almeno 60.000 fra i croati ustascia ed alcune migliaia fra gli italiani. Nei territori adriatici quindi lo stragismo aveva finalità punitive nei confronti di chi era accusato di crimini contro i popoli sloveno e croato (quadri fascisti, uomini degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane, ex squadristi, collaboratori dei tedeschi); aveva sia finalità epurative dei soggetti ritenuti pericolosi, come ad esempio gli antifascisti italiani contrari all’annessione alla Jugoslavia, sia finalità intimidatorie nei confronti della popolazione locale, per dissuaderla dall’opporsi al nuovo ordine. Per le stragi del 1945 l’ordine di grandezza è delle migliaia. Gli arrestati nelle province di Trieste e Gorizia furono circa 10.000, ma la maggior parte di essi fu liberata nel corso di alcuni anni. Secondo una ricerca condotta a fine anni ’50 dall’Istituto centrale di statistica, le vittime civili (infoibati e scomparsi) nel 1945 dalle province di Trieste, Gorizia ed Udine furono 2.627. Probabilmente la cifra è leggermente sovrastimata. D’altra parte, a tale stima vanno aggiunte le circa 500 vittime accertate per Fiume e qualche centinaio dalla provincia di Pola. Una stima complessiva delle vittime si aggira fra le 3.000 e le 4.000 secondo il Rapporto finale della Commissione storico-culturale italo-slovena, redatto nel 2000. Simbolo di tutte le foibe della miniera di è divenuto Basovizza, che costituisce la sede privilegiata di cerimonie commemorative e patriottiche. In realtà non si tratta di una foiba (abisso carsico), bensì di una cavità mineraria (pozzo della miniera), di grandi dimensioni (larga una decina di metri, profonda più di 250). Nella prima decade di maggio del 1945 venne probabilmente utilizzata per gettarvi le salme di diverse centinaia di prigionieri italiani fucilati nei pressi. Testimonianze concordi parlano dei processi sommari tenuti nell’arco di un paio di giornate a carico di alcune centinaia di uomini arrestati a Trieste, pare in massima parte membri della Questura. Ai processi seguirono le fucilazioni collettive e l’occultamento dei cadaveri nel pozzo e forse anche in alcune altre foibe vicine. Nell’abisso vennero gettati anche i resti della battaglia svoltasi pochi giorni prima nel vicino paese di Basovizza, alle porte di Trieste, fra truppe tedesche e jugoslave, nonché altri materiali. Utilizzata negli anni ’50 come discarica di materiali inerti, è stata successivamente chiusa con una lastra di pietra, proclamata nel 1992 monumento nazionale e nel 2007 oggetto di un nuovo intervento di monumentalizzazione, che ha comportato anche la realizzazione di un centro visite.
Un primo accordo provvisorio per la spartizione del territorio tra gli eserciti vincitori portò alla divisione della Venezia Giulia in due parti delimitate dalla “linea Morgan”: la parte occidentale fu assegnata all’amministrazione dell’esercito anglo-americano (Zona A); la parte orientale assegnata all’amministrazione militare dell’esercito jugoslavo (Zona B). Alla Zona A fu assegnata anche la città di Pola, in Istria, con una limitata porzione territoriale. Zone A e B della Venezia Giulia furono amministrate dall’autorità militare occupante: Governo Militare Alleato (AMG) e Governo Militare Jugoslavo (VUJA). Tale demarcazione venne stabilita durante un incontro tenuto a Belgrado il 9 giugno 1945 tra i rappresentanti della Gran Bretagna e degli Stati Uniti con il Ministro degli Esteri jugoslavo. L’accordo di Belgrado prevedeva il controllo anglo-americano delle ferrovie e delle strade che si dirigevano da Trieste all’Austria, comprese le città di Gorizia, Caporetto e Tarvisio; divenne esecutivo il 12 giugno 1945, data in cui le truppe jugoslave si allontanarono da Pola, da Trieste, da Gorizia e, più a nord, ripiegarono sulla riva sinistra dell’Isonzo. La “linea Morgan” rispondeva principalmente alle esigenze militari anglo-americane, poiché il controllo delle vie di comunicazioni verso l’Austria era considerato di rilievo strategico per i rifornimenti delle truppe presenti in quel settore. La demarcazione attuata dalla “linea Morgan” cessò il 10 febbraio 1947, con la conclusione delle trattative di pace di Parigi e fu abbandonata definitivamente dal 15 settembre 1947, quando il nuovo confine fu segnato. Le discussioni durante le trattative si concentrarono su linee di confine sfavorevoli all’Italia, stato aggressore e sconfitto nella guerra appena conclusa, e si differenziarono per l’ampiezza del territorio destinato alla Jugoslavia. Le indicazioni più penalizzanti per l’Italia provennero dalla Jugoslavia e dall’Unione Sovietica in quanto prevedevano la cessione di Trieste, Gorizia, Tarvisio, Cividale, Grado e tutta l’Istria; le indicazioni meno punitive furono quelle inglese e statunitense, che seguivano nella parte settentrionale il confine che divideva fino al 1914 la provincia di Udine dal litorale austriaco, ma nella parte meridionale lasciavano all’Italia Trieste, Gorizia, Gradisca e l’Istria occidentale da Capodistria fino a Pola; alla Jugoslavia venivano cedute Fiume e Pisino. La proposta francese nella parte settentrionale seguiva le indicazioni degli alleati, ma riduceva il territorio istriano da mantenere all’Italia, che si fermava a Cittanova e al fiume Quieto. Il Governo italiano indicò una linea di confine che rinunciava alle città di Fiume e di Zara. Nessuna variazione fu introdotta al confine tra Italia e Austria. Il 10 febbraio 1947 venne firmato a Parigi il Trattato di Pace che stabiliva il nuovo confine tra la Repubblica Italiana, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria.
Il Territorio Libero di Trieste venne istituito il 15 settembre 1947 e prevedeva un Governatore nominato da Italia e Jugoslavia. Il territorio Libero di Trieste rimase, dunque, diviso in due parti, mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avrebbe garantito la sua integrità territoriale e la sua indipendenza. Questa situazione iniziò a cambiare l’anno successivo. Tra le condizioni che hanno determinato la scomparsa del Territorio Libero di Trieste, un ruolo determinante si deve attribuire ai mutati rapporti all’interno degli stati comunisti dell’est europeo: in particolare nell’anno 1948 si produsse una frattura di forte impatto politico, ideologico ed emotivo tra la Jugoslavia e l’Unione Sovietica. Se nel marzo 1948 Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia si dichiarano favorevoli al ritorno di tutto il Territorio Libero di Trieste all’Italia, dopo il giugno 1948 (data della rottura tra Stalin e Tito) nella Zona B vennero abolite le barriere doganali con la Jugoslavia e fu estesa la legislazione jugoslava, evidenziando l’intento di annessione dell’area. Solo nel 1953, a seguito di una tensione crescente, con pressioni militari lungo i confini e soprattutto con la dichiarazione comune di Stati Uniti e Gran Bretagna sull’intenzione di ritirare le proprie truppe dalla Zona A del Territorio Libero di Trieste, furono avviati contatti determinanti per giungere ad una soluzione.
La cessione dell’Istria, di parte della Dalmazia e di parte del Friuli Venezia Giulia, prevista dal trattato di Trieste, comportò l’esodo di massa da quei territori in cui la popolazione italiana si ritrovò sotto la Repubblica di Jugoslavia.
Dell’esodo parla Armando Sestani, in qualità non solo di storico, ma anche e soprattutto di esule di seconda generazione, cioè nato in territorio italiano, a Taranto dove era stata collocata la sua famiglia dopo la scelta forzata di lasciare Pola.
Per esodo si intendono “quei casi in cui un gruppo di abitanti fu indotto a fuoriuscire dai confini politici del territorio in cui viveva a causa di pressioni esercitate dal governo che lo controllava, sia in termini di violenza diretta sia in termini di privazione di diritti, soprattutto in corrispondenza di un radicale mutamento politico che investe le relazioni tra stati (conflitti bellici, crolli e costruzioni di stati)”. L’esodo quindi è un particolare tipo di spostamento forzato di popolazione, diverso nelle modalità di attuazione rispetto alla deportazione ovvero all’espulsione, ma che giunge al medesimo risultato. Molti degli Italiani di Fiume e dell’Istria optarono per la cittadinanza italiana (come previsto dal Trattato di pace) trasferendosi nella Penisola. Tale scelta ebbe molteplici motivazioni: lo “spettro” delle foibe faceva sentire la popolazione italiana poco protetta mentre si verificavano una serie di abusi, prevaricazioni e violenze. Le politiche jugoslave di confische (abitazioni, botteghe, officine, proprietà agricole, strumenti di produzione, tecnologie anche minime) delle collettivizzazioni, dei rifornimenti di beni di prima necessità, delle politiche culturali, scolastiche e religiose, della formazione dei giovani, del lavoro volontario e coatto senza dubbio contribuirono a scegliere di lasciare la propria terra e di andare in Italia. Le autorità jugoslave tentarono a loro modo di frenare l’esodo, in base a diversi presupposti: il timore di uno svuotamento dell’Istria e il conseguente smacco politico che ne sarebbe derivato; la convinzione che la maggior parte dell’italianità istriana fosse fittizia, frutto di processi di snazionalizzazione che andavano corretti; la necessità di mantenere le piccole e grandi professionalità possedute dagli Italiani ; l’utilità di trattenere «italiani onesti», che sostanziassero le parole d’ordine della fratellanza italo-slava. L’esodo non fu un evento unico ma un processo di abbandono lungo l’arco cronologico 1943-1956. I distacchi furono diversificati per motivazioni e tempistiche. L’esodo da Zara fu il primo in ordine cronologico: iniziato già nel 1941 con una prima ondata di 10.000 partenze, proseguì nel 1942, al ritmo delle devastanti incursioni aeree alleate; si intensificò con l’ingresso delle truppe jugoslave nell’ottobre 1944, per concludersi nei primi anni ’50: nell’intero periodo la città perse il 70% della popolazione residente nel 1942, circa 43.670 persone (vittime incluse). A Fiume l’esodo per più di 20.000 italiani iniziò nel maggio 1945 ed entro il gennaio 1946 si raggiunsero circa 36.000 abbandoni.
Armando Sestani si concentra sull’esodo da Pola, città da cui proveniva la sua famiglia. Egli arricchisce il suo racconto con la presentazione di preziosi documenti di famiglia, quali l’elenco delle masserizie da trasportare, la scelta (scritta in italiano, croato e inglese, di suo padre di abbandonare l’Istria, le carte di identità dei genitori in 4 lingue).
A Pola, nel luglio 1946, su 31.700 residenti, 28.058 dichiararono di voler lasciare la città in caso di definitiva cessione alla Jugoslavia. La strage di Vergarolla del 18 agosto (l’esplosione dolosa di una ventina di bombe posizionate sulla spiaggia fece 65 vittime e una quarantina di feriti) fu vissuta dalla popolazione come strategia terroristica jugoslava per mettere in fuga gli italiani e per convincere coloro che già avevano optato per l’abbandono della loro terra di aver fatto la scelta giusta. A dicembre si aprì un movimento di massa che coinvolse circa 30.000 persone. Così migliaia di istriani presero posto sui piroscafi -celeberrimo il Toscana, in spola fra Pola ed Ancona, su cui salirono anche i genitori di Armando Sestani, che ne mostra una foto- messi a disposizione dal Comitato esodo dal Governo italiano. Le immagini dell’imbarco sul piroscafo Toscana sarebbero divenute icona di tutto il movimento dell’esodo.
Tra gennaio e aprile 1951, la riapertura dei termini per opzioni consentì l’espatrio 6.580 persone. La prima e principale ondata di esuli, quella relativa all’esercizio del diritto di opzione dopo il Trattato di pace del 1947, non ebbe per meta principale Trieste (dove comunque alla vigilia del Memorandum gli esuli erano già oltre 30.000) ma la penisola italiana.
Concentrandosi sulla città di Pola: Già nel marzo 1946 a Pola la popolazione italiana organizza una manifestazione spontanea per ribadire il netto rifiuto nei confronti di ogni ipotesi annessionistica della città alla Jugoslavia di Tito. Nel luglio 1946 a Trieste il CLN dell’Istria propone di indire tra la popolazione istriana un plebiscito. Contemporaneamente inizia a Pola la raccolta delle dichiarazioni di esodo in caso di cessione della città alla Jugoslavia: i dati annunciano come, su un totale di 31.700 abitanti, almeno 9.496 capifamiglia avrebbero intrapreso la via dell’esilio. Nel dicembre 1946 a Pola il locale CLN dichiara ufficialmente aperto l’esodo e nel febbraio 1947 la motonave Toscana, messa a disposizione degli esuli dal governo italiano, intraprende il suo primo viaggio. Ne farà altri 12 tra Pola e Venezia e Pola e Ancona fino al 20 marzo, data dell’ultimo trasporto.
In Italia, l’accoglienza pubblica ai giuliano dalmati avvenne nel quadro di altre categorie di profughi, entro 92 strutture, dislocate in 43 città italiane, che giunsero a essere 109, nel corso degli anni ’50. La loro gestione era dipendente dal Ministero dell’Interno e dall’ Assistenza Post-Bellica, che cooperavano con le autorità comunali. Altri aiuti giunsero dall’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Sorti per fornire asilo temporaneo, molti campi divennero la residenza dei giuliano dalmati per periodi anche lunghi, nonostante le dure condizioni di vita: temperature proibitive, mancanza di igiene, epidemie, promiscuità, frantumazione delle famiglie. Alcune migliaia di esuli non ressero un tale esperienza e presero la via dell’emigrazione in America ed Oceania. Quanto all’accoglienza da parte della società italiana, si intrecciarono gare di solidarietà ed atti di rifiuto. Questi ultimi ebbero spesso matrice politica, dal momento che la propaganda comunista dipinse gli esuli come fascisti in fuga da un paradiso socialista. Superata la prima emergenza, autorità pubbliche e soggetti privati avviarono un’ampia gamma di iniziative a favore dei profughi. Interventi legislativi e provvedimenti in materia di ricovero dei minori, occupazione, assegnazione di alloggi, funzionarono da acceleratore ai processi di inserimento. A partire dal 1952 era stato varato il piano di edilizia nazionale per la nascita di «borghi» giuliani in 42 città italiane, mentre a Trieste entrava in una fase operativa la costruzione di abitazioni nella cintura periferica cittadina e sul Carso. Infatti, avere una casa era il sogno più grande degli esuli, costretti a trascorrere molti anni in campi -ad esempio nel Villaggio San Marco, all’interno del campo di concentramento di Fossoli, dove i profughi rimasero fino al 1970-, alloggi di fortuna o edifici dismessi, come il Reale Collegio di Lucca, citato da Sestani.
La permanenza degli Italiani nei territori ceduti fu poco visibile. I «rimasti» erano due volte minoranza: rispetto alla scelta maggioritaria dell’esodo e di fatto minoranza nazionale nella Jugoslavia di Tito. Dal primo censimento ufficiale jugoslavo (1948) che definiva la cifra provvisoria di 79.575 italiani nella zona attribuita alla Jugoslavia dal Trattato di Parigi, la popolazione italiana fu in continuo decremento: nel 1981 si censivano solo circa 15.000 presenze. Le comunità italiane si adattarono, impararono a vivere nei ter- mini di normalità la scomparsa dei compaesani, la desertificazione dei luoghi, l’innesto di altre etnie, l’anomalia del passaggio da una condizione egemonica a quella di minoranza, lottarono per non scomparire come identità nazionale. Grave e protratto fu l’isolamento rispetto alla nazione madre; per una rete strutturata di scambi con l’Italia si dovette attendere la metà degli anni Sessanta.
Il 5 ottobre 1954 venne firmato a Londra il Memorandum tra Italia e Jugoslavia in base al quale si stabilì l’assegnazione della Zona A all’amministrazione italiana e della Zona B a quella jugoslava. Con il Memorandum di Londra iniziò il “grande esodo dalla zona B” che si concluse ufficialmente nella primavera 1956, con circa 40.000 partenze, pari ai 2\3 della popolazione. Le stime attuali indicano un flusso complessivo di 280.000- 300.000 persone.
Il superamento del Territorio Libero di Trieste venne definitivamente confermato dal Trattato di Osimo (10.11.1975), che pose fine alle incertezze. La formazione di nuovi Stati sul territorio della Jugoslavia dopo il 1991 non modificò i precedenti confini con la Repubblica italiana o con la Repubblica austriaca, ma determinò la comparsa di nuove formazioni statali, in particolare della Slovenia e della Croazia. La Repubblica di Slovenia a seguito di un referendum (23.12.1990) dichiarò la propria indipendenza dalla Jugoslavia e approvò una nuova costituzione il 25 giugno 1991. L’intervento dell’esercito federale jugoslavo diede avvio ad un conflitto con le forze armate slovene che si protrasse dal 26 giugno all’8 luglio 1991 e si concluse con il ritiro dal territorio della Slovenia di tutte le forze armate federali nel successivo mese di ottobre. La Repubblica di Croazia organizzò un referendum (19.5.1991) e proclamò la propria indipendenza il 25 giugno 1991.
Significativi cambiamenti nei rapporti tra gli stati dell’Alto Adriatico sono legati all’Unione Europea, di cui fanno parte con l’Italia (membro costituente fin dal 1958 della Comunità Economica Europea) anche l’Austria (dal 1° gennaio 1995) e la Slovenia (dal 1° maggio 2004).
Dal 20 dicembre 2007 il confine tra Italia e Slovenia ha perduto ogni carattere di filtro burocratico, con la eliminazione delle strutture di controllo doganale e l’abbattimento di gran parte degli arredi presenti sui valichi di confine (sbarre, guardiole, ecc.).
 Corso di aggiornamento per insegnanti ma aperto anche ai non insegnanti
Corso di aggiornamento per insegnanti ma aperto anche ai non insegnanti