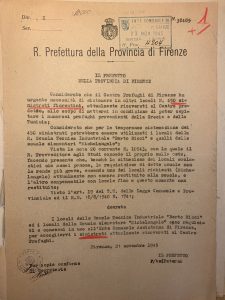Beatrice Giglioli, una donna sulla linea del fronte

1. I Giglioli di Pisa
Beatrice Elena Giglioli nasce a Portici (NA) il 5 febbraio 1892 da Italo[1] e Costanza Stocker[2]. I suoi due nomi richiamano due persone della storia della famiglia, uno per quella materna e uno per quella paterna. Grazie al Book IV. 1 dei Family Memorials of the Giglioli-Casella, scritte ad uso della famiglia da Maria Elena Casella (1888-1959), si apprende che Beatrice aveva una zia materna con lo stesso nome, Beatrice Alicia Ramsay Stocker[3], che nell’anno della nascita della nipote si imbarca per gli Stati Uniti per unirsi alle tribù dei Sioux come missionaria presbiteriana. Il secondo nome ricorre con continuità nel succedersi delle generazioni e si riferisce alla nonna paterna, Ellen Hillyer, per la devozione nei suoi confronti da parte di Italo, padre di Beatrice Elena[4].
La famiglia discende da Giuseppe Giglioli (1804-1865), figlio di Domenico (1775-1848) e Maria Luigia Palmerini (?-1862), patriota, membro della Giovine Italia e amico personale di G. Mazzini. Esule in Inghilterra, G. Giglioli aveva sposato Ellen Hillyer (1819-1894) e dalla loro unione erano nati cinque figli: Enrico (1845-1909), Augusto (1846-1901), Alfredo (1847-1897), Italo (1852-1920) e Elena (1858-1941).
Agli inizi della guerra, avendone conseguito il diploma il 6 aprile 1915, presta la propria opera di aiuto-infermiera della Croce Rossa Italiana. Il suo nome è anche nel 1° elenco dei soci del Club Alpino Italiano chiamati alle armi e il suo servizio sui treni ospedali inizia il 10 agosto 1915. Le infermiere volontarie e le aiuto-infermiere della CRI di Pisa svolgono servizio anche presso l’Ospedale militare di riserva, nel Palazzo Arcivescovile, nell’Ospedale succursale Pisa e negli istituti di rieducazione per soldati mutilati. In questo periodo Beatrice intrattiene corrispondenza con ufficiali e sottufficiali al fronte, quasi tutti studenti dell’Università di Pisa. Tra questi c’è Piero Pieri, in seguito tra i maggiori storici italiani della Prima guerra mondiale.
Nel giugno 1917 si laurea in lettere a pieni voti con una tesi su Il problema della decadenza dell’Impero romano negli storici moderni. Il relatore è Vincenzo Costanzi (1863-1929), ordinario di storia antica. Per nomina ministeriale, Beatrice viene incaricata dell’insegnamento di storia, geografia e diritti e doveri per l’anno scolastico 1917-18 nella Scuola tecnica Nicola Pisano di Pisa. Nel maggio 1918, presso l’Università di Pisa, supera l’esame di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per gli istituti d’istruzione media di 2° grado.
Nell’agosto 1918 si trasferisce a Londra, dove, il 26 dello stesso mese, ottiene per esame il posto di traduttrice al War Office (Ministero della guerra), con il compito di tradurre in inglese documenti e opuscoli italiani e francesi concernenti la guerra europea. Poche settimane dopo, il 21 settembre 1918, si dimette dall’incarico in seguito alla nomina ad assistente presso la Facoltà di Italiano dell’Università di Cambridge. Durante la sua permanenza in Inghilterra segue corsi di perfezionamento di filologia e letteratura inglese, tiene conferenze a Londra e a Edimburgo sulla storia e la letteratura italiana. Nel gennaio 1919 e per i due trimestri successivi assume l’incarico di insegnare lingua e letteratura italiana presso la stessa Università di Cambridge, impegno che prosegue fino al luglio successivo, quando è costretta a rientrare in Italia per l’aggravamento delle condizioni di salute del padre.
Nel frattempo, le profonde trasformazioni geo-politiche legate al riassetto seguito alla Prima guerra mondiale, generano tensioni politiche in tutta Europa. Il legame della famiglia Giglioli con la tradizione risorgimentale mazziniana e con il tema dell’autodeterminazione politica delle nazionalità, si manifesta nel sostegno alla spedizione fiumana di D’Annunzio, alle rivendicazioni dell’italianità della Dalmazia e all’indipendenza ceco-slovacca.
Nell’autunno del 1920 Beatrice diviene insegnante supplente di lingua inglese all’Istituto tecnico Antonio Pacinotti di Pisa, dove rimane negli anni scolastici 1920-21 e 1921-22. Vince il concorso generale a cattedre di lingua inglese per gli istituti tecnici e si trasferisce per un anno a Sassari, dove insegna all’Istituto tecnico Alberto Lamarmora. Dall’a.s. 1923-24 e 1924-25 insegna presso l’Istituto tecnico Germano Sommeiller di Torino, nel corso superiore della Sezione commercio e ragioneria. A Torino, nel 1925, per l’editore Paravia traduce dall’inglese la guida pratica di J.E. Russell, Lezioni intorno al terreno. A partire dall’a.s. 1925-26 torna a Pisa, al Liceo ginnasiale G. Galilei dove lei stessa aveva studiato e dove diventerà titolare di lingua e letteratura inglese dall’a.s. 1935-36. Dall’a.a. 1925-1926 è incaricata del lettorato di lingua inglese della Scuola Normale Superiore, incarico riconfermato fino al 1959. Presso la SNS sono conservati i registri delle sue lezioni a partire dall’anno 1932 e tra i testi da lei più utilizzati nei corsi compare Oliver Twist di C. Dickens.
Oltre che sul piano professionale, Beatrice è attiva anche su quello civile: quando il 13 febbraio 1926 viene fondata la Sezione di Pisa del CAI, risulta – insieme ai fratelli Irene e Giorgio, oltre che a Piero Zerboglio – tra i promotori e fondatori[5].
Il 25 febbraio 1933 firma il giuramento di “fedeltà” al Re e al regime fascista. Il verbale del giuramento riporta i nomi dei testimoni, Giovanni Gentile, direttore della SNS, e i docenti Francesco Arnaldi e Giovanni Ricci[6]. Quella di Beatrice al fascismo non è un’adesione ideologico-politica, è invece un’adesione solo formale, dovuta alla necessità di rimanere come insegnante alla SNS, per poter continuare a provvedere a sé stessa e all’anziana madre. La sua precedente attività di volontaria della CRI nella Prima guerra mondiale e la partecipazione, insieme al padre, alla campagna a favore dell’indipendenza ceco-slovacca nel 1920, sono impegni pubblici di tipo “patriottico” nel segno della tradizione mazziniana, ma negli anni che vanno dal 1922 al 1933 non c’è nessuna sua presa di posizione in senso nazionalista. Del resto, nel libro sulla storia dei Giglioli scritto dalla madre di Beatrice e pubblicato nel 1935, benché l’argomento riguardi la tradizione risorgimentale della famiglia, non vi è traccia di alcun accenno al fascismo e al suo leader, in cui evidentemente l’autrice non riconosceva alcuna continuità con la storia del mazzinianesimo[7].
Dall’anno scolastico 1935-1936, oltre che al Liceo ginnasio G. Galilei, è nominata titolare di lingua e letteratura inglese anche alla scuola media R. Fucini di Pisa. Nel 1935 pubblica per R. Pironti di Napoli la traduzione di Much ado about nothing di W. Shakspeare.
2. Sulla linea del fronte: 31 agosto 1943-1° gennaio 1945
Durante gli anni di guerra con meticolosa puntualità Beatrice Giglioli annota su piccole agendine gli avvenimenti familiari e locali. Con la sorella Irene, Beatrice ha vissuto a Cisanello, sobborgo di Pisa, per gran parte del Novecento. Oltre alle notizie sugli eventi quotidiani, nelle sue agendine registra alcune dinamiche relazionali e sociali, che vengono alla luce, paradossalmente, per effetto dei bombardamenti su Pisa, che iniziano il 31 agosto 1943 e proseguono a lungo. Alla dimensione verticale delle bombe che cadono dall’alto e che producono morte e distruzione, subentra quella orizzontale degli effetti generati dalle esplosioni, a partire dai comportamenti di chi, sopravvissuto, si trova ad agire in una realtà fisica (edifici, ponti, strade) e umana (morti, feriti) drammaticamente colpita e dove la vita, per continuare, deve affrontare difficoltà inedite in una situazione che è mutata profondamente. Nella vita civile niente è più come prima: provvedere alle cure mediche per i malati e ora anche per i feriti, spostarsi da un luogo all’altro della città, a piedi, in bicicletta o con qualche altro mezzo, procurarsi cibo e rifornirsi di provviste, dare e avere notizie sulle persone care o conosciute, poter continuare o meno a svolgere il proprio lavoro, poter contare o meno sul funzionamento delle istituzioni, dei servizi postali, dei trasporti ferroviari e delle infrastrutture in genere, ecc. Le bombe, inoltre, producono anche un elevato numero di sfollati, le cui sorti sono esposte a grave rischio, costretti come sono a cercare ospitalità, un alloggio o almeno un riparo.
Di tutto ciò si trova ampia traccia nei diari di Beatrice[8]. Quella che si raccoglieva nella villa di Cisanello prima dei bombardamenti era una fitta rete di rapporti fatta di legami parentali, amicali, professionali e culturali, sostenuta da una rete altrettanto fitta di vicini di casa, affittuari, conoscenti e persone provenienti per lo più dal territorio circostante per le collaborazioni domestiche (cucina, pulizie e lavori di casa) e per la fornitura di servizi (materie prime, cibo, servizi di manutenzione della casa, ecc.). A questi va aggiunta la cura dei numerosi animali (cani, gatti, galline, conigli, capre, api), e il conforto rappresentato dal giardino, con l’attenzione esperta ai fiori, alle verdure e alle piante da frutto, esito evidente delle competenze di Italo Giglioli trasmesse alle figlie. Dopo il bombardamento di Pisa, le sorelle Giglioli vogliono subito vederne gli effetti per valutarne la portata e si attivano per far fronte a tutto, a partire dal fatto che accorrono subito presso le macerie della casa degli amici Zerboglio, colpita in pieno da una bomba sul Lungarno Regio (odierno Lungarno Pacinotti), per mettere in salvo la maggior quantità possibile dell’archivio e dei numerosissimi libri che vi erano raccolti. La rete dei rapporti d’amicizia è un bene prezioso, che va tenuta attiva nei momenti difficili, come si vede quando il 23 settembre 1943, dopo aver saputo che l’amico Aldo Visalberghi (1919-2007) era stato ferito nella difesa di Roma, Beatrice Giglioli si affretta a informarne gli amici comuni della famiglia Barletta. La rete di solidarietà si manifesta accogliendo in casa sfollati, curando gli esseri umani e gli animali, continuando ad avere la stessa attenzione di prima anche per il giardino e ospitando amici e parenti a pranzo, a cena, per la notte o anche solo per il tè, cercando, procurando e distribuendo risorse alimentari e facendo di necessità virtù con quelle disponibili. Le sorelle Giglioli intendono in ogni momento ricostituire una comunità di fraternità e integrazione civile, il che rappresenta, per i loro interlocutori, una risorsa preziosa su cui contare. Fra gli amici ospitati più frequentemente a casa Giglioli ci sono persone di differente appartenenza religiosa, come anglicani e valdesi (il pastore Attilio Arias o l’insegnante e collega Laura Revel), o ebrei (alcuni esponenti della famiglia De Cori, Giulia Letizia Aghib, l’insegnante e collega Maria Sacerdotti), nonostante fossero in vigore le leggi razziali fasciste emanate nel 1938 e la persecuzione anti-ebraica si fosse inasprita dopo la nascita della RSI. È la storia stessa della famiglia Giglioli, con il suo ramo protestante inglese degli Hillyer e degli Stocker, a fornire esempio vissuto di costruzione comunitaria. Le Giglioli, del resto, non si fanno intimidire nemmeno dall’arrivo delle truppe tedesche nella loro casa, una prima volta ad aprile 1944 e poi altre due volte tra luglio e agosto.
Gli interlocutori delle sorelle Giglioli sono soprattutto insegnanti, colleghi di Irene e di Beatrice, la quale, insegnando sia nelle scuole secondarie che alla SNS, si trova a contatto con molti dei più noti intellettuali e scienziati attivi a Pisa (G. Gentile, L. Tonelli, L. Russo, S. Timpanaro sr. ecc.). Tra questi ci sono anche alcuni medici molto noti in città, come Francesco Niosi o Silvio Luschi, che prestano cure alle sorelle, amici e vicini. Nelle pagine di Beatrice si coglie bene anche il pesante impatto della guerra sulla vita della scuola. Il lavoro di Beatrice presso la SNS l’ha portata a essere insegnante di molti studenti poi noti nell’ambito delle professioni e che, come nel caso di Visalberghi, sono diventati anche amici. Alla costruzione di questa parte dei rapporti delle sorelle Giglioli con il mondo universitario ha anche contribuito la precedente attività di docente a Pisa del padre Italo, la cui amicizia con Adolfo Zerboglio, per esempio, ha portato all’amicizia fraterna tra le figlie di Giglioli e il figlio di Zerboglio, Piero, importante figura dell’antifascismo azionista toscano, il cui nome ricorre molto frequentemente nelle pagine del Diario. In effetti, dal Diario traspare la posizione antifascista delle Giglioli, tanto che la loro casa, oltre che un riferimento sicuro per Zerboglio, lo è anche per un altro esponente azionista, Carlo Ricci, frequente ospite a Cisanello, così come accadeva anche per altri antifascisti. Non sono solo le numerose presenze di persone e cose a caratterizzare il Diario, ma anche alcune assenze. Può sembrare strano che in quelle pagine, così attente ad annotare tutto ciò che va dalla minuta vita quotidiana ai grandi avvenimenti politici e militari, manchino due fatti di grande rilievo. In effetti, non c’è alcuna citazione dell’uccisione di Giovanni Gentile, avvenuta a Firenze il 15 aprile 1944, e nemmeno dell’eccidio per mano nazista avvenuto a Pisa il 1° agosto 1944 in casa di Giuseppe Pardo Roques, presidente della comunità ebraica pisana, che era stato amico di Italo Giglioli. È probabilmente la gravità dei due fatti a indurre in Beatrice un’evidente auto-censura a scopo precauzionale. È nella corrispondenza con la sorella Lilia, svolta attraverso scambi realizzati fuori dal circuito postale grazie a mani amiche, che i due fatti vengono citati e commentati.
Negli anni della guerra Beatrice Giglioli continua a lavorare come insegnante al Liceo G. Galilei e come lettrice alla SNS, dove la conferma del suo incarico giunge anche per l’a.a. 1943-44 da parte del nuovo direttore, Leonida Tonelli, rinnovato anche da Luigi Russo[9]. Dall’anno accademico 1942-1943 fino al 1948-1949 è docente incaricata di lingua e letteratura inglese all’Università di Pisa. A causa delle vicende belliche nell’a.a. 1943-44 inizia le lezioni il 1° febbraio 1944 e può tenere solo lezioni saltuarie fino ad aprile.
Dopo la fase dell’occupazione tedesca della città e i mesi di guerra dell’estate del 1944, riprenderà l’insegnamento alla SNS il 25 gennaio 1945. Uno dei suoi interlocutori è il meridionalista Giuseppe Isnardi (1886-1965), collaboratore dell’Animi, che dal 1928 al 1934 insegna al Liceo classico Carducci-Ricasoli di Grosseto e dal 1934 al 1951 a Pisa, dove insegna lettere al ginnasio G. Galilei, collega di Beatrice, insieme a G. Raniolo e a Ildebrando Imberciadori, che insegna lettere al triennio liceale.
Sull’esempio della madre, Beatrice si dedica alla cura dell’archivio di famiglia con l’aiuto della sorella Irene e della cugina Maria Elena Casella. Il ruolo di Beatrice nel conservare l’archivio di famiglia è ricordato proprio dalla Casella in alcuni passi delle sue Family Memorials: «The passage was marked by Italo Giglioli in the book found for me by Beatrice Giglioli at Cisanello, in September 1958» (p. 80); «I once found by chance, in Beatrice’s study, a notebook with some notes jotted down by Italo Giglioli» (p. 150).
Beatrice muore a Pisa il 7 febbraio 1988. Le ceneri per sua volontà sono state collocate nel cimitero di Pisa accanto a quelle delle sorelle Irene e Lilia. L’archivio è lasciato ad Antonio Ricci, che lo ha donato alla Biblioteca F. Serantini.
Note
- Italo nasce a Genova il 1° maggio 1852 da Giuseppe e Ellen Hillyer. Si laurea in agraria al Royal Agricultural College di Cirencester, contea di Gloucestershire. Muore a Pisa il 1° ottobre 1920.
- Costanza nasce a Roma il 2 ottobre 1856 dal reverendo anglicano Edward Seymour Stocker (1828-1900) e da Jean Hamilton Dunbar (1829-1862). Nel 1885 incontra Italo Giglioli e sarà suo padre Edward, il 26 agosto 1886, a celebrare il loro matrimonio a Londra. Oltre alla cura dei figli, Costanza coltiva le sue passioni e, grazie alla vicinanza del marito e alla conoscenza della storia della famiglia Giglioli, si interessa alle vicende del Risorgimento italiano, in particolare alle avanguardie democratiche e giacobine attive a Napoli tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. Da questi studi nasce il volume dedicato alla rivoluzione napoletana del 1799, pubblicato in Inghilterra nel 1903.
- Nata a Roma il 13 marzo 1858, Beatrice A.R. Stocker muore il 23 febbraio 1935 a Sonoma, in California, dov’è sepolta. Tracce molto interessanti della sua esperienza di missionaria si ritrovano in alcune lettere da lei inviate alla sorella Constance Giglioli Stocker, cfr. A Doorkeeper in the House of God: The Letters of Beatrice A. R. Stocker, Missionary to the Sioux, 1892-1893, a cura di A.M. Baker, «South Dakota History», vol. 22, n. 1, 24 marzo 1992, pp. 38-63.
- L’ultima figlia di Ellen Hillyer è stata chiamata Elena, così come quest’ultima ha voluto chiamare Maria Elena la sua unica figlia. Beatrice Elena non ha fatto a tempo a conoscere la nonna Ellen, morta nel 1894 in Abruzzo, a Chieti, dove risiedeva presso la famiglia del genero Raffaello Casella, marito di Elena Giglioli.
- «Notiziario» CAI – Sezione di Pisa, a. xxxvii, n. 1, 2017.
- SNS, Centro archivistico, fasc. Giglioli Beatrice. Dal fascicolo risulta che Beatrice Giglioli è iscritta al Pnf dal 31 luglio 1933, tessera n. 671151, e all’Afs (Associazione fascista della Scuola) dal 1934, tessera n. 022270.
- C. Giglioli Stocker, Una famiglia di patrioti emiliani. I Giglioli di Brescello, con appendice di 26 lettere inedite di patrioti del tempo, Milano [etc.], Società editrice Dante Alighieri, 1935.
- B. Giglioli, Diario 21 agosto 1943 – 1° gennaio 1945. Ricordi dell’estate 1944 di Antonio Ricci, a cura di F. Bertolucci, B. Cattaneo e G. Mangini, Ghezzano (PI), BFS edizioni, 2025.
- SNS, Centro archivistico, fasc. Giglioli Beatrice. L’incarico alla sns termina nell’a. a. 1959-60.