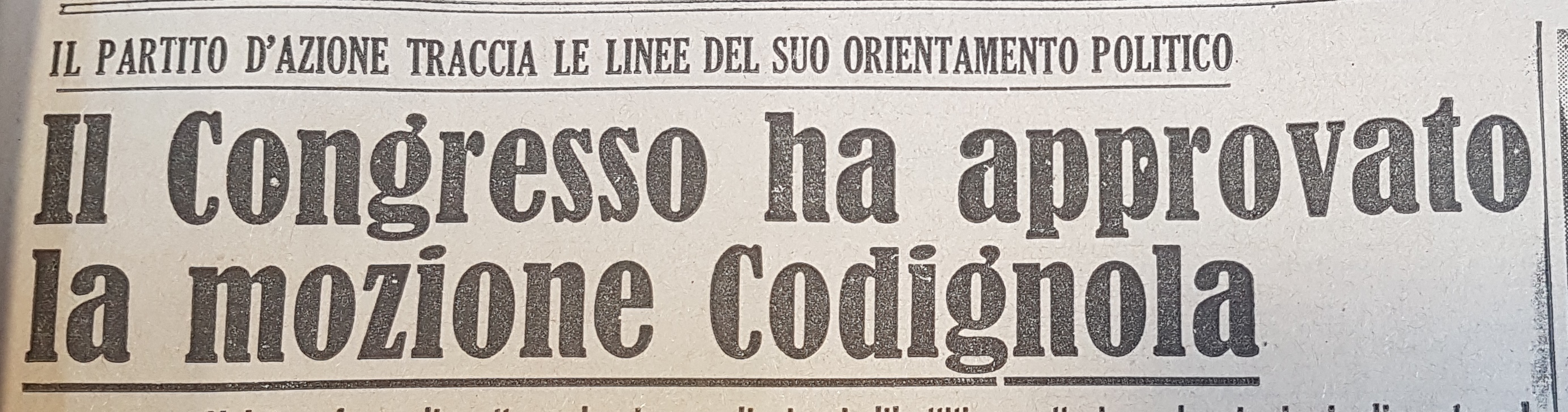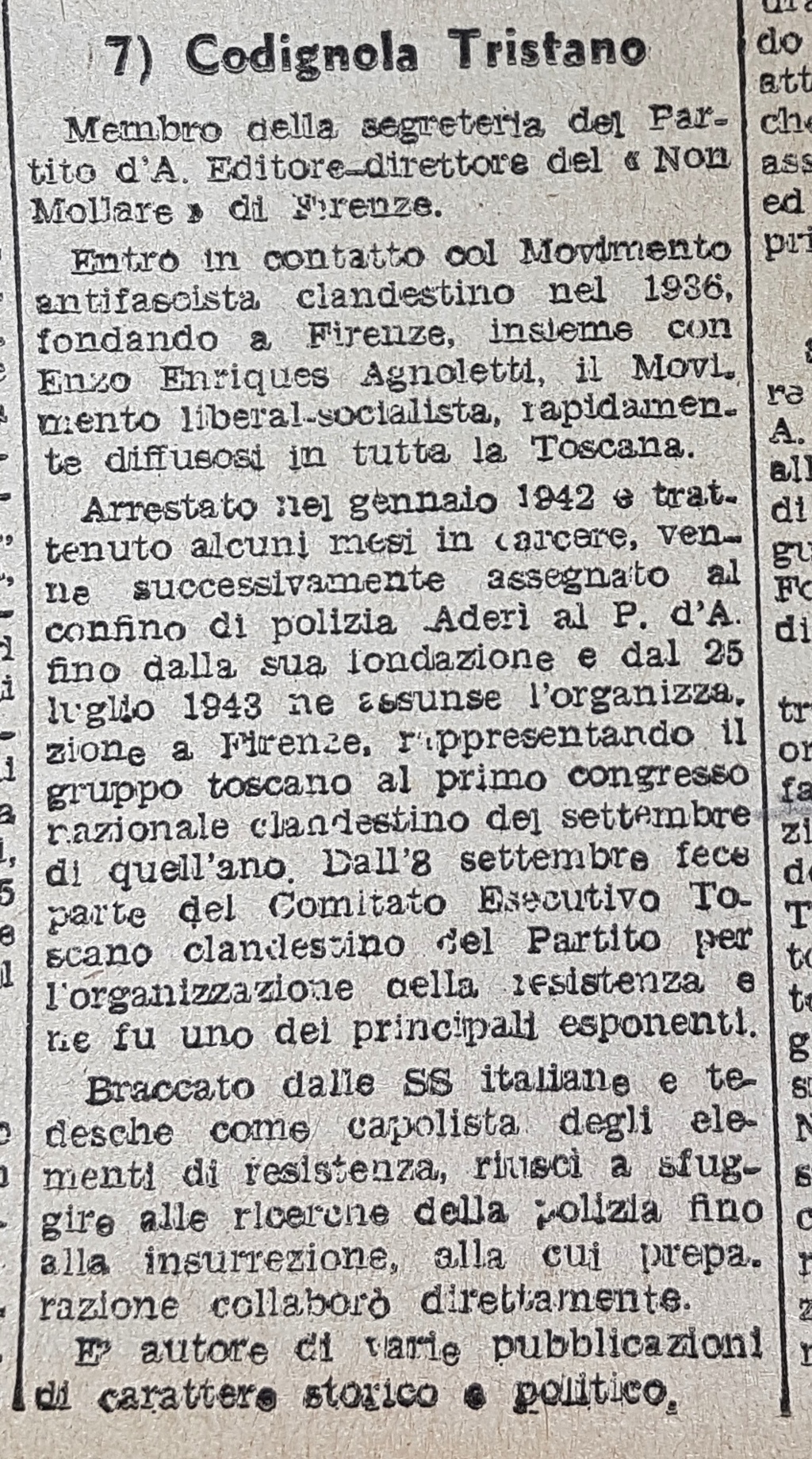Tristano Codignola: un azionista fiorentino all’Assemblea Costituente

Uomo di grande carattere e di elevato profilo morale, Tristano Codignola rappresenta una figura di estremo interesse e di indubbia levatura all’interno della complessa vicenda della sinistra italiana novecentesca, non foss’altro che per la tenacia e l’assoluta coerenza con le quali, pur in contesti e momenti diversi della storia politica nazionale, operò sempre a favore di un rinnovamento del socialismo italiano e di una sua affermazione come forza riformista e di governo capace di suscitare nell’Italia postbellica un’alternativa democratica e indirizzare il paese verso il conseguimento di una profonda e concreta trasformazione politica e sociale.
Un intendimento questo mai rimosso, che anzi accompagna con continuità tutta la vicenda politica di Codignola, muovendo dall’antifascismo delle origini e attraverso la successiva stagione azionista, per progredire poi nell’Italia repubblicana con la ricerca di un socialismo autonomista inteso come una “terza forza” realmente alternativa e libera da qualsiasi condizionamento. Un intento questo al quale egli cercherà sempre di mantenersi fedele, prima puntando, dopo la scissione del 1947 del Partito d’Azione, ad unificare entro formazioni minori le sparute frange socialiste liberali esterne al PSI e poi portando nel 1957 questa minoranza “eretica” entro lo stesso Partito Socialista, storico soggetto politico riformatore della società al quale Codignola rimarrà legato sino al 1981, anno della sua morte.
In questo articolato percorso, risaltano e non si perdono mai in Codignola alcuni tratti fondanti del suo pensiero politico, quali tra tutti il tema della libertà, della giustizia sociale, di una concezione laica della vita, che certo gli provengono da varie e composite frequentazioni culturali ma soprattutto dall’influsso del socialismo liberale volontaristico e aclassista dei fratelli Rosselli, che non per nulla caratterizza il gruppo azionista fiorentino di cui Codignola, nella transizione dal fascismo alla Repubblica, diventa l’indiscusso leader politico. È Firenze non per nulla il luogo, spaziale e al contempo ideologico, nel quale affondano le fondamenta del pensiero e della lunga militanza politica di Codignola, benché per la verità di natali non toscani.
Nato ad Assisi il 23 ottobre 1913 e figlio del grande pedagogista Ernesto, Tristano Abelardo Codignola (“Pippo” per gli amici e per i compagni di lotta) cresce però in Toscana, prima a Pisa e poi a Firenze, città nelle quali la famiglia si trasferisce a seguito degli incarichi di insegnamento del padre Ernesto. È nel capoluogo toscano che quest’ultimo, allievo e collaboratore di Giovanni Gentile, ottiene nel 1923 la cattedra di pedagogia alla facoltà di Magistero e vi dirige poi a partire dal 1930 la casa editrice La Nuova Italia. Ed è sempre a Firenze che Tristano completa i suoi studi, prima diplomandosi al Liceo Michelangelo e poi laureandosi in giurisprudenza nel 1935 con una tesi in Storia del Diritto Italiano (relatore Francesco Calasso), cattedra della quale Codignola sino al 1942 sarà peraltro assistente. Dopo la laurea, Tristano comincia a lavorare nella casa editrice del padre, impresa di cui poi sarà a capo per circa quarant’anni, dalla Liberazione sino alla sua morte. Già di sentimenti antifascisti, nel 1936 Tristano aderisce al movimento clandestino liberalsocialista di Calogero e Capitini, attività per la quale è segnalato agli organi di polizia e più tardi arrestato nella propria abitazione fiorentina il 27 gennaio 1942. Dopo alcuni mesi difficili di confino scontati a Lanciano, Tristano torna sul finire dell’anno a Firenze, dove riprende subito l’attività clandestina, divenendo nei mesi dell’occupazione tedesca protagonista indiscusso della Resistenza cittadina nelle file del Partito d’Azione. Della sezione fiorentina Codignola è infatti eletto segretario nel 1945, mantenendo a partire dallo stesso anno e sino al 1947 anche il ruolo di direttore dell’organo politico del partito, il settimanale Non mollare! che riprende il nome della testata fondata a Firenze nel 1925 dal gruppo antifascista di Italia Libera.
È appunto al Partito d’Azione che, nella sua coeva riflessione politica, Codignola riconosce nel quadro dell’Italia postbellica il ruolo di forza socialista di tipo nuovo, a cui spetta attuare una rivoluzione democratica e un rinnovamento di tutti gli istituti fondamentali della vita italiana. Una missione questa per la quale Codignola cerca di lavorare spingendo il partito, dopo la caduta del governo Parri e la fine della stagione ciellenista, verso un’impostazione di sinistra di tipo rivoluzionario che è quella propria dell’interpretazione fiorentina dell’azionismo, legata cioè ancora una volta al socialismo liberale dei Rosselli: “per noi toscani il partito non può avere che un senso rivoluzionario, perché vuole cambiare tutta l’organizzazione statale italiana” afferma Codignola parlando al I Congresso nazionale del PdA che si tiene a Roma nel febbraio del 1946 e che sancisce appunto la vittoria della sua mozione sull’indirizzo politico del partito.
A muovere Codignola su questa strada è anche la preoccupazione di ricondurre ad unità ideologica e politica il partito a fronte dei vari dissidi interni e di dotarlo così di una posizione autonoma e di equilibrio rispetto alle tentazioni trasformiste che nel nuovo quadro politico che anticipa il doppio voto del 2 giugno 1946 animano anche il campo delle sinistre. Già in previsione di questo passaggio fondamentale, discutendo dei possibili e futuri schieramenti interni all’Assemblea Costituente, Codignola, mentre riconosce nel PdA la “punta avanzata della democrazia progressista” e il solo “partito intimamente ed essenzialmente democratico”, gli attribuisce al contempo il compito di “creare il terreno di equilibrio fra socialisti e comunisti, impedire ai primi una politica di trasformismo, impedire ai secondi una prevalenza di motivi classisti (creatori di privilegi) su motivi democratici” imponendo al contempo “il chiarimento delle posizioni conservatrici della democrazia cristiana” (T. Codignola, Al di là della Costituente, «Non Mollare!» 18 aprile 1946).
In modo non dissimile, mentre egli riafferma a seguito dell’esito del voto del 2 giugno il valore della scelta repubblicana come “l’unica soluzione logicamente democratica”, ravvisa nuovamente la pericolosità della “tendenza di comunisti e socialisti a varare con la Democrazia Cristiana un accordo di condomino governativo” rivendicando invece per il PdA la scelta coerente di rimanere all’opposizione; un’opposizione tuttavia costruttiva che “come funzione essenziale della vita democratica e della dialettica parlamentare, si risolve in effettiva collaborazione da svolgersi attraverso il libero contrasto anziché attraverso la corresponsabilità di governo” (T. Codignola, Dalla monarchia alla repubblica, «Non Mollare!» 8 giugno 1946). Emergono già da queste posizioni il riconoscimento più tardo che Codignola avrà modo di fare del Parlamento come luogo preposto al libero e democratico confronto, nonché la sua peculiare natura di deputato e politico disposto a ricercare il compromesso nella concretezza dell’agire politico, senza mai però scendere a patti su questioni di principio.
Alle elezioni del 2 giugno per l’Assemblea Costituente, Codignola si candida per il PdA nel XV Collegio elettorale di Firenze-Pistoia, nonché contemporaneamente nel XVI di Pisa-Livorno-Lucca-Apuania. Nella prima circoscrizione è presentato al quarto posto della lista azionista dopo Piero Calamandrei, capolista, Max Boris e Carlo Campolmi ed ottiene il terzo miglior piazzamento con 566 preferenze a fronte dei 1.941 voti del Calamandrei e dei 756 di Carlo Furno. Nella seconda circoscrizione Codignola appare invece in terza posizione dopo Guido Calogero e Amato Mati, piazzandosi al secondo posto con 588 voti di preferenza alle spalle di Calogero che ne ottiene 1.266. Il responso che il suo nome ottiene alle urne è quindi positivo, benché in realtà l’esiguo risultato elettorale riportato complessivamente dal PdA (334.784 voti, di cui 28.364 in Toscana) non consente al partito l’ottenimento di alcun quoziente pieno, di modo che i propri candidati potranno esser eletti solo tramite il Collegio Unico Nazionale. Tra i sette deputati azionisti eletti così nella lista nazionale all’Assemblea, Codignola risulta il settimo, alle spalle di Alberto Cianca, Riccardo Lombardi, Piero Calamandrei, Fernando Schiavetti, Leo Valiani e Vittorio Foa. Questi, entrati in Assemblea, costituiscono il gruppo parlamentare definitosi “autonomista” unendosi a Ferruccio Parri e a Ugo La Malfa, fuoriusciti dal PdA nel febbraio ed eletti nella lista di Concentrazione Democratica Repubblicana.
Nonostante Codignola sia tra i deputati più giovani, la sua attività all’Assemblea si distingue per la quantità e qualità degli interventi che vi svolge, nonché per l’evidente capacità dialettica e critica che contraddistingue il suo interloquire. Due sono soprattutto gli ambiti di discussione nei quali egli fa sentire con autorevolezza la propria voce. Da un lato vi è la questione dell’ordinamento autonomistico della Repubblica, tema non nuovo in Codignola che già della necessità di uno Stato a base autonomistica aveva parlato nelle Direttive programmatiche al PdA fiorentino del giugno 1944, quando aveva inteso l’autonomia come “autogoverno e autocontrollo del cittadino che ha il diritto e il dovere (…) di gestire direttamente la cosa pubblica insieme con gli altri consociati”. Più tardi, nell’ambito dei lavori della Costituente, Codignola auspica una riforma autonomistica ispirata alla necessità “di ravvicinare la rappresentanza alla base del Paese, e di affidare a questa rappresentanza i più ampi poteri di autogoverno e di legislazione locale nell’ambito della legislazione generale”. Colpisce in tal senso come in Codignola la difesa delle autonomie di cui si fa proponente sia però sempre intesa nel pieno rispetto dei principi generali dello Stato come pure a difesa della sua stessa unità: “una effettiva e radicale riforma autonomistica non è quella che indebolisce la unità dello Stato, ma quella che la rafforza” (T. Codignola, Chiarificazione sulle autonomie, «Italia Libera» 2 agosto 1946). Si capisce anche da questo passaggio, come egli, pur facendosi garante più volte della difesa delle autonomie regionali e in particolare della necessità di garantire costituzionalmente le minoranze etniche e linguistiche delle zone di confine, avesse però ritenuto discutibile il sistema col quale si stava dotando alcune regioni italiane di statuti speciali, che a suo giudizio si erano rivelati in alcuni casi incompatibili con il principio di unità dello Stato. Per questo, nel luglio del 1947 aveva proposto con un emendamento all’articolo 108 del Titolo V del Progetto di Costituzione della Repubblica (poi non approvato) la necessità di formulare una dichiarazione che, nel rispetto dell’ordinamento regionale, garantisse però al contempo il mantenimento delle libertà fondamentali garantite ai cittadini dalla Costituzione.
A fianco del problema delle autonomie, è però il tema della scuola che in sede di Costituente suscita più di altri la vis critica di Codignola e l’appassionata difesa dei suoi principi. Sicuramente, l’impegno di Codignola su questo aspetto è da ricondursi in buona parte al peso che la questione dell’insegnamento esercita su di lui per il tramite del padre e dei suoi interessi pedagogici, interessi che peraltro egli condivide e che nel prosieguo della sua carriera parlamentare lo spingeranno in fatto di istruzione a divenire uno dei principali riformatori dell’Italia repubblicana. La battaglia che nell’aprile del 1947 Codignola porta avanti entro l’Assemblea Costituente soprattutto sugli articoli 27 e 28 del progetto (poi divenuti gli articoli 33 e 34 della carta costituzionale) è anzitutto una battaglia combattuta per la formazione di coscienze libere all’interno di una società laica e democratica. La matrice libertaria della pedagogia del Codignola si scontra in questa sede con l’impostazione dogmatica delle forze cattoliche, sullo sfondo di una accesa battaglia per la difesa della scuola pubblica.
Secondo Codignola, anzitutto, il progetto di Costituzione avrebbe dovuto limitarsi a indicare qualche breve dichiarazione generale, lasciando alla legislazione ordinaria il compito di affrontare i problemi particolari dell’ordinamento scolastico. In tal senso, i principi generali da affermare entro la carta costituzionale sarebbero dovuti essere quelli della libertà di insegnamento, del diritto di controllo dello Stato sull’insegnamento, e del riconoscimento della gratuità dell’istruzione almeno fino al 14° anno di età. Sul primo dei tre, tuttavia, è in atto un pericoloso equivoco dietro al quale, rivela Codignola nel suo appassionato intervento in aula del 21 aprile 1947, si cela la contrapposizione tra il principio laico di “libertà nella scuola” e quello cattolico di “libertà della scuola”. I cattolici e le forze democristiane, con libertà di insegnamento intendono soprattutto affermare la “libertà della scuola”, cioè il dovere dello Stato di garantire a chiunque – ad istituti ed enti privati quindi – la piena libertà di organizzare ed esercitare la funzione educativa, dice Codignola, “fino alle estreme conseguenze che siano loro consentite”. Ciò significa però che la scelta dei contenuti, delle idee e dei comportamenti da trasmettere nell’insegnamento rischia di essere ispirata a principi di parte e diventare nel caso della scuola cattolica un’educazione autoritaria all’accettazione di una verità rivelata che è una Verità sola. La scuola della Repubblica deve invece educare al pensiero libero e critico, perché se suo scopo è quello di assicurare un’educazione democratica del cittadino l’unico modo è che si faccia portatrice di un principio di libertà di insegnamento che promuova la convivenza e il confronto di diverse posizioni culturali e ideologiche. Soltanto la scuola pubblica, come palestra di confronto tra verità diverse, può assicurare questo principio di libertà. C’è in questa convinzione la consapevolezza, che è propria di Codignola e che non a caso era stata pure alla base della pedagogia del padre, che un’educazione autoritaria rischi di trasmettere un’attitudine autoritaria, laddove invece un insegnamento veramente libero può divenire un propulsore dello sviluppo democratico del paese.
Il laicismo di Codignola, sempre presente nella sua attività parlamentare (non a caso egli vota contro l’accettazione nella carta costituzionale del Concordato del 1929) è particolarmente evidente nella difesa che egli fa in aula della scuola pubblica contro gli assalti democristiani e nei riguardi soprattutto del Dc Guido Gonella, il “ministro dell’istruzione privata” come lo apostrofa Codignola, intento a preparare “una riforma clandestina della scuola”. Un argine a simili progetti viene posto soprattutto grazie alla battaglia combattuta dal PdA e dalle altre forze laiche attorno ad un emendamento al comma 1° dell’art. 27 del progetto, firmato assieme ad altri deputati dallo stesso Codignola. Ribaltando il senso di un precedente emendamento democristiano che proponeva la norma del sovvenzionamento da parte dello Stato delle scuole non statali, la controproposta firmata da Codignola – che poi si affermò nella votazione per appello nominale con uno scarto di circa quaranta voti – riconosceva che la piena libertà di istituzione di scuole da parte di enti e di privati fosse però “senza oneri per lo Stato”. Il tentativo democristiano di porre a carico dello Stato la “libertà della scuola”, nel senso dato dai cattolici, fu in questo modo respinto.
L’impegno profuso in sede di Costituente da Codignola per una scuola pubblica laica e democratica diverrà poi una costante della sua successiva attività politica e parlamentare, sia come responsabile dal 1958 della Commissione scuola del Psi, che come deputato socialista protagonista di numerose battaglie (come quella sostenuta contro il piano decennale per lo sviluppo della scuola presentato nel 1958 dal governo Fanfani) nel farsi anche di importanti riforme quali l’istituzione della scuola media dell’obbligo (1962), della nuova scuola materna di Stato (1968), nonché della liberalizzazione agli accessi universitari e dei piani di studio sancita dalla legge n. 910 del 10 dicembre 1969, ricordata ancora oggi come “legge Codignola” dal nome del suo ideatore.
Un impegno coerente, quello di Codignola nei riguardi della scuola, che richiama la più generale coerenza con la quale egli portò avanti nella lotta politica i suoi principi fondamentali, spesi sempre a vantaggio dell’affermazione di una compiuta democrazia laica e socialista.
Articolo pubblicato nel maggio del 2016.