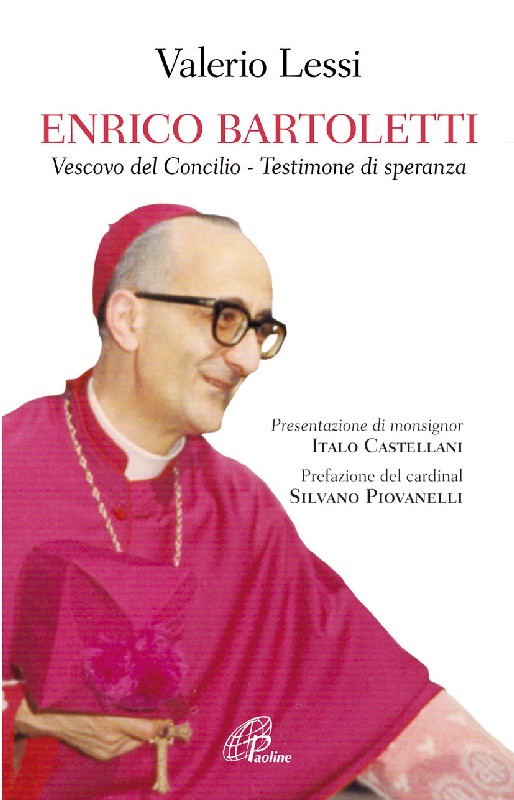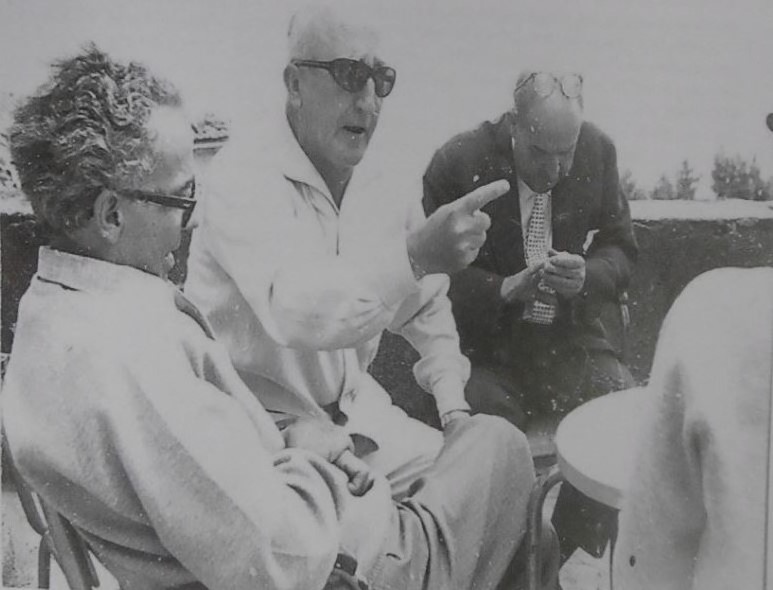“Io sono quel che sono… io vivo ai margini della città… sono un ragazza di strada” cantavano nel lontano 1966 i Rokes in una canzone che, sebbene temporalmente successiva, ben rappresenta l’infanzia “complicata” che Alberto Baumann passò a Montecatini.
Alberto è stato definito un “artista eclettico, un cantastorie sfacciato, un comunicatore innovativo”, ha scritto poesie, racconti e canzoni, realizzato opere pittoriche e gioielli in oro e argento, è stato un giornalista creatore di format televisivi. Ha vissuto da personaggio “contro”: dopo essersi sposato nel 1963 con Eva Fisher, una donna di tredici anni più grande di lui, recandosi in bicicletta in Campidoglio a Roma, decise nel 1967 di partire per la Guerra dei Sei Giorni come corrispondente di guerra lasciando a casa la moglie e un figlio di tre anni.
È stato soprattutto un ebreo, se non forse per religione, sicuramente per senso di appartenenza, soprattutto a partire dall’emanazione delle leggi razziali nel 1938.
Alberto Baumann nacque “per caso”, come diceva lui stesso, a Milano nel 1933 e giunse all’età di due anni a Montecatini Terme dove il padre ungherese Alessandro, un giornalista rimasto a vivere in Italia dopo essere stato inviato al seguito dell’esercito austro-ungarico aveva assunto l’incarico di direttore dell’Ufficio Propaganda, quello che oggi si sarebbe chiamato Ufficio Relazioni Esterne delle Terme e scriveva articoli a sfondo turistico. Con il suo humour diceva che, rincorrendo gli italiani, era arrivato a Viareggio, città nella quale con una cavalleria “da Belle Epoque”, aiutandola a scendere dalla carrozza, visto che aveva una gamba ingessata, conobbe Estelle Piperno, livornese di famiglia ma nizzarda di nascita, che divenne poi sua moglie. Per uno degli strani casi della storia il padre di Estelle, Alfredo, aveva combattuto contro gli austriaci nella guerra appena conclusa.
Montecatini divenne così la città di adozione di Alberto e il teatro della sua vita da “ragazzo di strada”. Nel 1938, a causa delle leggi antiebraiche, il padre, ebreo, apolide e recalcitrante ad indossare il distintivo fascista venne confinato a Ruoti[1], in provincia di Potenza. La Lucania, la terra che meritava il plauso del Duce perchè “non era sufficientemente infetta da tutte le correnti perniciose della società contemporanea” era diventata la terra di esilio per gli oppositori del regime. Alessandro Baumann tornerà a Montecatini in una sorta di licenza per un paio di giorni solo nel 1942.
Il 1938 fu anche l’anno in cui il giovane Baumann avrebbe dovuto fare il suo ingresso nel mondo dell’istruzione. A causa delle già citate leggi leggi razziali non potè però frequentare ufficialmente le aule scolastiche. Come scriveva nei suoi ricordi Alberto, per gli amici Berzi, cioè Albertino in ungherese, grazie al suo spirito di adattamento e all’aiuto del maestro Gennai, continuò però a varcare la soglia della scuola, pur non figurando ufficialmente in quanto ebreo. Ricordava infatti che: “A scuola andavo però non mi sedevo sul banco, oppure mi sedevo e non facevo niente. I compiti li scrivevo ma non me li richiedevano mai… Seguivo le lezioni adagiato in fondo alla classe, sebbene alcune volte riuscivo a farmi spazio tra alcuni compagni, come un fantasma che tutti potevano notare senza poterlo vedere”.
Nel 1939 rimase orfano della madre e, con il padre lontano, fu costretto con la sorella Iolanda, della Loly, a vivere presso i nonni materni titolari di un “banco” di stoffe. Amava rammentare, come segno della povertà familiare, che le cinquanta lire trovate nelle tasche dei pantaloni che il nonno indossava al momento della morte furono usate per pagare il suo funerale.
Per superare le continue difficoltà economiche, la nonna produceva con del sughero tomaie per zoccoli, mentre il nipote si recava in campagna per racimolare rape, barbabietole e la farina gialla con cui fare della polenta.
Il problema del cibo era una costante tanto che i ragazzi della banda di Alberto, il gruppo di via Cappellini di cui faceva parte tra gli altri anche Renzo Montagnani, avevano l’ordine, una volta usciti da scuola, di non tornare a casa se non con qualcosa da mangiare. Montecatini all’epoca era un grande “lazzarett”, cioè un ospedale militare tedesco e così per trovare qualcosa da mettere sotto i denti Alberto si intrufolava spesso nel parco dell’Hotel La Pace dove cercava gli avanzi dei pasti che i degenti meno gravi avevano consumato passeggiando.
“Mi ricordo pezzi di pane tedesco con burro e marmellata, questo pane nero… golosamente si mangiava, se te lo davano. E poi si andava a fare castagne, cioè a rubare castagne sulle colline“.
Spesso il giovane Baumann andava ad “aprire il negozio del nonno”. Doveva prendere in pratica una tavola di due metri per uno e mezzo, trovare due “caprette” sulle quali adagiare la tavola stessa e disporre su questo elementare “banco” le mercanzie disponibili per la vendita, cioè tovaglie, cravatte, calzini.
Un giorno con i suoi amici di Via Cappellini, tutti ugualmente affamati, salì su un carro armato tedesco fermo in colonna. Introdotta la mano nel mezzo sottrasse al soldato tedesco addormentato al comando un mitra Mauser con cui, assieme ai compagni, si divertì a imparare a sparare. Il mitra venne poi, con grande rammarico di tutti, preso in consegna da un partigiano.
Alberto nelle settimane seguenti vide con terrore, mentre cercava di trovare le cicche con cui barattare con i contadini del cibo, due persone impiccate nella piazza principale di Montecatini. Al loro corpo era attaccato un cartello con scritto “Questo succede a chi tradisce i soldati tedeschi”. Mentre Alberto passava le donne amiche dei nazisti fotografavano.
Più o meno negli stessi giorni parte degli ebrei catturati in seguito a una soffiata nella retata di Montecatini venne radunata nell’albergo Croce di Malta. Fra i catturati figuravano, a detta di Alberto, anche due fratelli poliomelitici di nome Fiorentino, che erano stati presi con la madre[2] e il signor Abel Colembiowsky, un polacco che girava la città cercando di vendere oggetti utili per il ricamo e il cucito contenuti in una cassetta che portava al collo. La nonna di Alberto decise di mandarlo da quest’ultimo per restituirgli un vassoio di argento che il polacco le aveva prestato. Colembiowsky, alla vista di Alberto nella hall dell’albergo, resosi conto del fatto che questi rischiava di essere riconosciuto in una hall piena di SS e di ebrei come lui, lo cacciò via urlando “come un cane con la bava alla bocca” salvandogli così probabilmente la vita[3]. Nelle ore successive si sparse la voce che le persone catturate fossero state portate in una cittadella vicina, nessuno immaginava all’epoca che la destinazione finale fu il lager.
La scena dell’impiccagione, la retata di Dannecker e il rischio corso nell’albergo da Alberto spinsero nonna Anita a cercare, dopo aver sistemato la piccola Anita dalle suore di don Bosco a Montecatini, di organizzare la fuga del nipote.
Scappato nelle campagne, il ragazzo trovò degli artisti circensi di Firenze che lo presero con loro insegnandogli dei giochi e facendolo esibire. Alberto ricordava di essersi divertito un sacco in quel periodo e di aver imparato molti trucchi che avrebbe usato in seguito anche con i figli, come quello della “sigaretta mangiata” che rispuntava nella sua bocca integra dopo alcuni minuti.
Grazie ad una carta di identità falsa intestata a un inesistente “Gino Fabbri nato a Montecatini il 12 maggio 1933” fornitagli da Monsignor Barni, con cento lire in tasca e un biglietto ferroviario di sola andata, Alberto si recò alla stazione di Montecatini per prendere il treno che lo avrebbe condotto a Sacile, nei pressi di Pordenone. Lungo la strada Alberto si sentì chiamare “Picolo picolo” da un soldato tedesco affacciato a un balcone che gli lanciò un vasetto di marmellata solida. Forse, raccontava con ironia Alberto, “se quel soldato si fosse accorto che ero ebreo non l’avrebbe fatto”.
Nella cittadina veneta, a detta di don Barni[4], avrebbe dovuto incontrarsi con un sacerdote che lo avrebbe ospitato. Nella concitazione di quei momenti il prelato si era sbagliato sul conto dell’amico sacerdote che purtroppo era deceduto ormai da anni. Alberto si trovò quindi solo in un paese sconosciuto e alla mercé di chiunque. Non aveva con se nulla se non pochi vestiti: una maglia girocollo, un paio di pantaloni alla zuava e scarpe troppo grosse per lui. Decise di tornare in Toscana a piedi e trovò rifugio presso la casa di un operaio padre di cinque figli. Questi, dopo averlo ospitato per alcune sere, gli domandò se per caso fosse ebreo e di fronte alla risposta affermativa del giovane con le lacrime agli occhi lo invitò ad andarsene perchè temeva per l’incolumità dei suoi familiari. Gli donò quindi dei soldi e lo accompagnò alla porta.
Vagò a questo punto per alcuni mesi nell’Italia occupata dai nazisti fino a quando incontrò i soldati americani della 5a Armata dei quali divenne una delle mascotte.
Tornò a Montecatini poco prima della Liberazione e si unì a un gruppo di ragazzi più grandi. che lo spinsero a compiere delle azioni di sabotaggio. I nazisti in ritirata cercavano di far saltare con dei candelotti posti ogni 200-300 metri le linee ferroviarie per ostacolare l’arrivo delle truppe alleate. Il suo compito, realizzato con incoscienza e grande divertimento, era quello di spiare i nazisti all’opera e di recuperare l’esplosivo quando questi si erano allontanati impedendo così che la ferrovia venisse distrutta. Ricordava così quel periodo: “E un giorno si vide passare un gruppo di tedeschi che facevano delle buchette sotto il binario. Erano quattro o cinque, facevano questa buchetta, dopo di che riprendevano urla specie di trenino che si guidava con le mani… Andavano avanti e arrivavano altri quattro o cinque, dopo un po’, e mettevano la dinamite, la gelatina, in questa buca per far saltare il binario. Il mio amico Alvaro, molto più grande di me e mio vicino di casa, mi chiamò e mi disse “Berzi”…anzi mi ricordo quando me lo disse aveva il manico della pistola, bianco, che gli usciva di qua… Berzi, vali lì e levagli tutto quello che hanno messo dentro. Te strappa…” Collaborava, senza saperlo, con i partigiani della brigata Garibaldi e di Giustizia e Libertà[5].
 Il padre tornò a Montecatini nel 1945 dopo essersi trattenuto a Ruoti per svolgere l’attività di interprete per il principe Ruffo di Calabria con gli ufficiali anglofoni sbarcati in Italia e di istitutore di inglese della principessa Maria Lucia Ruffo. “Era un professore di inglese e altre lingue splendido, mio padre. Si fermò a Roma, e poi venne su e arrivò. Io mi ricordo quando torno. Da anni non lo vedevo più ma l’avevo sempre presente perchè mia nonna non faceva altro che raccontare di papà. E stavo accendendomi una cicca, pensa te, ero terrorizzato. Io non fumavo davanti a mio padre nemmeno quando avevo vent’anni. Mi misi una cicchetta in bocca e in quel mentre vedo una jeep che si ferma proprio davanti a casa mia, con un ufficiale. E vedo mio padre che scende. La prima cosa… Non sapevo se inghiottire questa cicca o cosa… So che in qualche modo la spensi, la buttai. E poi entrò mio padre, abbracci e baci“.
Il padre tornò a Montecatini nel 1945 dopo essersi trattenuto a Ruoti per svolgere l’attività di interprete per il principe Ruffo di Calabria con gli ufficiali anglofoni sbarcati in Italia e di istitutore di inglese della principessa Maria Lucia Ruffo. “Era un professore di inglese e altre lingue splendido, mio padre. Si fermò a Roma, e poi venne su e arrivò. Io mi ricordo quando torno. Da anni non lo vedevo più ma l’avevo sempre presente perchè mia nonna non faceva altro che raccontare di papà. E stavo accendendomi una cicca, pensa te, ero terrorizzato. Io non fumavo davanti a mio padre nemmeno quando avevo vent’anni. Mi misi una cicchetta in bocca e in quel mentre vedo una jeep che si ferma proprio davanti a casa mia, con un ufficiale. E vedo mio padre che scende. La prima cosa… Non sapevo se inghiottire questa cicca o cosa… So che in qualche modo la spensi, la buttai. E poi entrò mio padre, abbracci e baci“.
Ricordava la liberazione di Montecatini come una festa di biciclette. Tutti gli abitanti tirarono fuori dalle loro case le bici che avevano nascoste per evitare che venissero prese dagli occupanti. I poliziotti avevano una fascia al braccio con la scritta CLN, cioè “Comitato di LIberazione Nazionale”. Finita la guerra Alberto trovò lavoro come fattorino in un albergo del lido di Venezia e poi nel ’52 venne “adottato dalla città di Roma” dove cominciò a lavorare presso l’Hotel Continentale come cassiere del ristorante e segretario dell’albergo. Scoprì presto via Margutta, che divenne la “sua” strada, e Piazza di Spagna, dalle quali rimase folgorato. Si intratteneva spesso presso il bar Notegen dove conobbe i più grandi esponenti della vita culturale romana dell’epoca: Campigli, Mafai, Amerigo Tot. Il padre andò a trovarlo solo una volta a Montecatini e morì a sessantuno anni senza che il figlio potesse funerale a causa della mancanza di soldi. A fine anni Cinquanta con una inchiesta sulla sinagoga di Roma per la rivista “Roto sei-Sei rotocalchi in uno” cominciò a dedicarsi al giornalismo e incontrò il rabbino Elio Toaff. Collaborò con la rivista Il Mondo diretta da Pannunzio grazie ad Aldo Garosci, amico dei fratelli Rosselli e co-fondatore di Giustizia e Libertà. Nel 1963, come già detto, si sposò in Campidoglio in bicicletta con Eva Fischer, cittadina iugoslava unitasi alla lotta partigiana italiana. È stato l’ideatore di Shalom, il primo quotidiano degli ebrei italiani e animatore del gruppo di amici composto fra gli altri da Enrico Modigliani, Mariolino Di Segni e Ariel Toaff che nei primi anni Settanta si impegnò per cancellare le scritte antisemite ricorrenti all’epoca sui muri della capitale. Negli anni Settanta affiancò all’attività di giornalista quella di scrittore, creò per una TV locale il controgiornale, una trasmissione di news ironica che ebbe un notevole successo tanto che un noto imprenditore milanese gli chiese, ottenendo una risposta negativa, di trasferirsi al Nord per lavorare con lui. A partire dagli anni Ottanta ha esteso i suoi interessi anche alla pittura.
Alberto è scomparso il 1 novembre 2014 nella sua casa di Trastevere a Roma. Amava dire spesso con il solito spirito “In Italia il due novembre ricordano i morti… chissà se quest’anno nonno Alfredo arriva primo!”.
[1]Ruoti è un comune italiano di 3551 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata facente parte della Comunità Montana Marmo Platano (fonte Wikipedia)
[2]Nel sito del Cdec e in quello di Anna Pizzuti non figurano uomini di nome Fiorentino catturati. Risultano invece arrestate e deportate ad Auschwitz due sorelle: Ada Fiorentino, nata a Roma il 9/12/1866, arrestata il 5/11/43, partita il 9/11/43 e arrivata ad Auschwitz il 14/11/43 e Margherita Fiorentino, nata a Pisa il 22/8/1888. E’ possibile che ad anni di distanza Alberto confonda i nomi indicati con i volti di altre persone.
[3]Nel sito del Cdec e in quello di Anna Pizzuti non risultano deportati con questo nome. Forse il signore citato riuscì a sfuggire alla cattura.
[4]Don Guido Barni, nato a Montevettolini, laureato in teologia e filosofia, venne nominato nel 1912 parroco di Santa Maria Assunta a Montecatini. Resse la parrocchia fino al 5 agosto 1952. Fra le sue opere ricordiamo nel nel1917 l’istituzione dell “l’ospizio della Carità” e di una biblioteca circolante
[5]Le brigate Garibaldi operanti durante la Resistenza erano organizzate dal Partito Comunista Italiano e composte quindi principalmente da comunisti. Furono le formazioni partigiane più numerose e quelle che subirono il maggior numero di perdite. I suoi componenti si distinguevano per un fazzoletto rosso che portavano al collo. Le brigate di Giustizia e Libertà erano legate al Partito d’Azione e coordinate da Ferruccio Parri. I suoi componenti si distinguevano per l’uso di un fazzoletto verde.