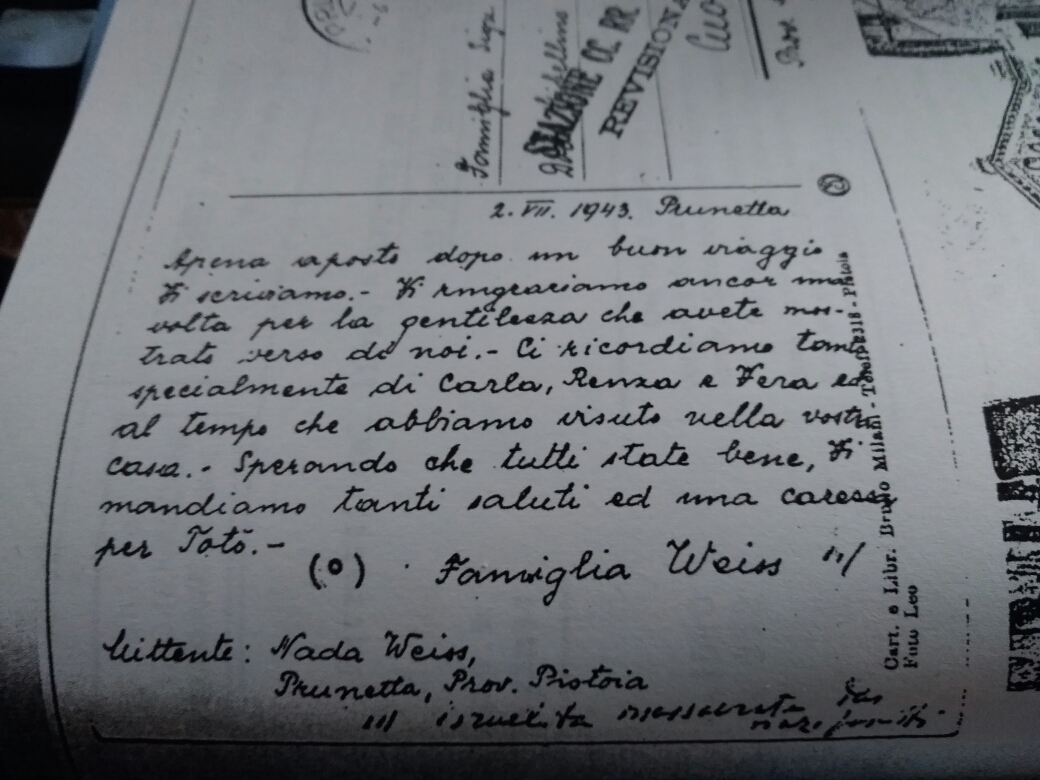Ersilio Ambrogi: antifascista o informatore dell’OVRA?

Un quadro: i termini della questione
«Non rischiamo di essere smentiti affermando che il Pnf ha ricevuto l’apporto di gruppi compatti da tutti i partiti politici, eccetto che dal partito comunista»[1]. Nell’aprile 1928, in una serrata difensiva sulle pagine di «Stato operaio», Secondino Tranquilli tentava di scagionare così il presunto cedimento di alcuni militanti comunisti di fronte alle pressioni della polizia fascista. Pur cariche di impegno politico, tuttavia, le parole dell’intellettuale marsicano – poi conosciuto con lo pseudonimo di Ignazio Silone – poggiavano su fondamenta decisamente instabili. Ad oggi, infatti, il graduale accesso alle fonti archivistiche ha mostrato quanto e come – in realtà – le cellule comuniste si fossero rivelate uno dei terreni d’infiltrazione più fertili per il regime[2].
D’altronde, fin dal 1923, il modo in cui il partito si era attrezzato ad una situazione di semilegalità ne aveva fatto il principale obiettivo della Polizia politica guidata da Arturo Bocchini. Già nel 1925 una prima retata aveva assestato forti danni a molte federazioni, permettendo all’Ovra di acquisire preziose informazioni su militanti di base, segretari e dirigenti; operazioni destinate a moltiplicarsi tra il 1926 e il 1927, quando i fascisti riuscirono ad intercettare anche uomini e indicazioni orbitanti attorno al Centro estero del Pcd’I[3]. Come ciò avvenne non è difficile da immaginare: l’ampiezza e la profondità organica della rete clandestina comunista – studiate con accuratezza dalla macchina poliziesca – avevano reso relativamente semplice l’inserimento di agenti segreti, spie e osservatori in borghese, nonché la creazione di canali diretti con alcuni dissidenti dalla linea adottata dall’Internazionale. Se l’individuazione degli emissari del Centro costituiva una priorità assoluta, inoltre, quella disposta nei confronti dei simpatizzanti restava una morsa flebile, avvolta dalla consapevolezza che prima o poi sarebbero serviti da esche per intercettare i militanti più significativi. Una volta arrestati, interrogati e incarcerati, i funzionari si rendevano così conto del labirinto di delazioni entro il quale si erano inconsapevolmente mossi, finendo spesso per subire il peso e le pressioni delle torture e degli interrogatori: non stupisce pertanto che alla fine dell’estate 1927 i comunisti arrestati risultassero «almeno duemila […] e che, in quasi tutti i casi, la loro cattura [fosse] stata assicurata da spie, informatori o agenti provocatori premiati con notevoli somme di denaro dalle varie polizie che [concorrevano] alla caccia al comunista»[4].
Ciò detto, è comunque importante isolare l’arco temporale in cui il fenomeno si consolidò: quello tra il 1927 e il 1932. Di fatto, nel gennaio 1927 l’istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato aveva aperto una fase di crescenti tensioni che, pochi mesi dopo, sarebbero sfociate nel cosiddetto «processone» contro i comunisti e nelle conseguenti condanne a dirigenti del calibro di Gramsci, Terracini, Scoccimarro e Roveda. A queste si aggiunsero le difficoltà scaturite dalla rovinosa crisi economica del 1929 e – soprattutto – dalle crescenti tensioni legate all’esistenza di linee antitetiche all’interno del partito, crepe in cui la polizia fascista fu capace di penetrare con efficacia. In questo quadro, la paura, le minacce e le perquisizioni – al pari delle generose offerte di denaro, degli adescamenti e dei presunti favoritismi avanzati dalle forze fasciste – generarono un progressivo stravolgimento degli itinerari esistenziali e dei percorsi ideologici di numerosi militanti: un meccanismo del quale peraltro cadde vittima lo stesso Silone, probabilmente ricattato dopo l’arresto del fratello Romolo e protagonista di una vicenda segnata da risvolti familiari, politici e psicologici mai completamente chiariti[5].
Proprio la vicenda Tranquilli, ad ogni modo, risulta utile per introdurre la figura al centro di questo breve contributo: quella di Ersilio Paolo Giuseppe Ambrogi. In particolare, assieme ad essa sembra configurare un osservatorio privilegiato allo scopo di analizzare in che misura le lotte di fazione finirono con il contraddistinguere lo spionaggio comunista.
La vicenda Ersilio Ambrogi: antifascista o collaborazionista?
 Come già evidenziato, le divergenze interne all’Internazionale erano ben note alla polizia fascista. Da un lato, ciò consentì all’Ovra di insinuarvisi per accentuarne le contrapposizioni; dall’altro – recuperando le parole di Mimmo Franzinelli – gli scontri toccarono punte talmente accese da «indurre esponenti del partito a denunziare identità e recapiti degli avversari interni, con la giustificazione machiavellica di favorire, insieme alla prevalenza della propria corrente, l’interesse generale del movimento comunista»[6]. Non è certo se furono queste motivazioni, assieme a quelle familiari, a spingere Silone – uscito profondamente amareggiato dalla sua esperienza come delegato al VII Plenum dell’Internazionale, dove aveva assistito all’espulsione di Grigorij Zinov’ev – ad intrecciare la sua fitta corrispondenza con l’ispettor Bellone; è forse più sicuro che lo furono nel caso di Ersilio Ambrogi, nonostante un percorso biografico segnato da ombre (tra cui quella di essere stato, viceversa, una spia stalinista) che attendono ancora di essere chiarite.
Come già evidenziato, le divergenze interne all’Internazionale erano ben note alla polizia fascista. Da un lato, ciò consentì all’Ovra di insinuarvisi per accentuarne le contrapposizioni; dall’altro – recuperando le parole di Mimmo Franzinelli – gli scontri toccarono punte talmente accese da «indurre esponenti del partito a denunziare identità e recapiti degli avversari interni, con la giustificazione machiavellica di favorire, insieme alla prevalenza della propria corrente, l’interesse generale del movimento comunista»[6]. Non è certo se furono queste motivazioni, assieme a quelle familiari, a spingere Silone – uscito profondamente amareggiato dalla sua esperienza come delegato al VII Plenum dell’Internazionale, dove aveva assistito all’espulsione di Grigorij Zinov’ev – ad intrecciare la sua fitta corrispondenza con l’ispettor Bellone; è forse più sicuro che lo furono nel caso di Ersilio Ambrogi, nonostante un percorso biografico segnato da ombre (tra cui quella di essere stato, viceversa, una spia stalinista) che attendono ancora di essere chiarite.
Nato a Castagneto Carducci (LI) il 16 marzo 1883, figlio di Antonio e Corinna Belli, Ambrogi crebbe in un ambiente di estrazione borghese. Il padre, medico condotto, gli aveva impartito un’educazione vicina alle posizioni del cattolicesimo liberale. Un’impostazione dalla quale si allontanò molto presto, attratto piuttosto dalle idee anarchiche che Pietro Gori aveva contribuito a diffondere lungo la costa toscana[7]. Recatosi a Pisa per studiare legge, dopo essersi iscritto al Psi prese parte – nel 1904 – ad in gruppo rivoluzionario internazionalista e antimilitarista in cui conobbe future figure di spicco dell’Alleanza Internazionale Antimilitarista quali Alfredo Polledro, Ugo Nanni, Domenico Zavattero e Cesare Maragoni. Sempre nello stesso anno, incaricato di cercare proseliti, si trovò coinvolto nella sparatoria che la polizia di Sestri Levante aprì sulla folla durante un comizio del socialista Giovanni Pertini. Ne seguì un durissimo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali alla cui testa si pose lo stesso Ambrogi, il quale finì arrestato e condannato ad undici mesi di reclusione. Uscito dal carcere, iniziò così una fitta serie di viaggi che lo portarono a maturare contatti con soggetti libertari tra Svizzera, Francia (dove nel 1906 prese parte alle manifestazione indette dalla Confédération générale du travail) e Germania, prima di rientrare al paese natale (1911) e di contribuire – assieme ai braccianti Cesare Morganti e Giacinto Bongini – alla nascita del gruppo anarchico castagnetano “P. Gori”. L’anno successivo, dopo essersi laureato in legge all’Università di Bologna, aprì uno studio di consulenza legale a Milano: allo scoppio del primo conflitto mondiale venne richiamato alle armi, ma, come riportano le informazioni presenti nel suo fascicolo del Casellario Politico Centrale (aperto nel 1905 e chiuso nel 1942), finì più volte incarcerato per propaganda antimilitarista e disfattista. Ormai sempre più distante dall’anarchismo, nel 1919 scelse di rientrare nel Psi. Eletto deputato, esponente di spicco della corrente massimalista del partito, emerse ben presto come una delle personalità più incisive del socialismo tirrenico: una popolarità che, nel 1920, gli valse contemporaneamente l’elezione a sindaco di Cecina (rimasta fino al 1925 sotto la provincia di Pisa) e a presidente dell’Amministrazione provinciale di Pisa.
Tuttavia, fu la scissione di Livorno a segnare definitivamente il suo percorso politico: nel 1921 aderì infatti al Pcd’I, trovandosi da subito protagonista di violenti scontri contro le milizie fasciste. Destituito dall’incarico di primo cittadino per aver «levato dagli uffici del Municipio di Cecina i ritratti dei Sovrani e la targa della Vittoria»[8], venne arrestato per «omicidio» e «tentato omicidio» nei confronti di alcuni squadristi. Grazie all’elezione come deputato comunista per la circoscrizione Livorno-Pisa-Lucca-Massa riuscì comunque ad eludere la condanna a 21 anni e ad uscire di carcere già nel maggio 1921 (la complessità della vicenda giudiziaria meriterebbe adeguati approfondimenti). In un clima di crescente violenza, ad ogni modo, decise di lasciare l’Italia e di iniziare in Germania un’attività di stretta collaborazione con il Kommunistische Partei Deutschlands. Non solo: nel 1922-1923, assieme ad Antonio Gramsci, venne eletto delegato a Mosca nel Komintern e successivamente nominato emissario dell’Internazionale comunista nell’Europa Occidentale. Fu in questo periodo che, pur in stretti rapporti epistolari con Terracini, Grieco e Togliatti, iniziò ad avvicinarsi sempre più alle posizioni di Amadeo Bordiga; e fu sempre in questa fase, in seguito ai durissimi contrasti emersi in seno al VI Plenum del 1926, che maturò un graduale adesione alle teorie di Lev Trockij. Dopo aver paventato – fallendo – la possibilità di creare anche in Russia un piccolo nucleo in contatto con il Centro estero del Pcd’I (di stanza in Francia e Belgio), si trovò così marginalizzato dal partito, finendo con l’esserne espulso nel 1929[9].
Ciononostante, i suoi rapporti con il Komintern proseguirono. Tornato a Berlino e guardato a vista da quella Gpu di cui aveva fatto parte, vi rimase dal 1930 al 1932. Fu proprio nella capitale tedesca che la polizia fascista, ormai perfettamente a conoscenza – dopo aver decapitato le sfere dirigenziali – di «tutto il meccanismo dell’organizzazione comunista»[10], iniziò a seguirlo più da vicino. Alcuni mesi prima, dettagliate informazioni su di lui erano state rilasciate al ministero dell’Interno dal prefetto di Livorno, Guido Farello, il quale aveva scorto nella linea politica intrapresa da Ambrogi una concreta possibilità di avvicinamento:
L’Ambrogi è uno dei capi del gruppo di sinistra tra gli emigrati politici. In una delle ultime riunioni del gruppo egli ebbe a manifestare la sua contrarietà che i componenti di esso non sanno discutere, accettando ogni relazione ed ogni risoluzione con una disciplina che non ha nulla di intelligente. Ciò non può dare nessuna utilità pratica e se non vi fosse il gruppo sinistro che discute e solleva obiezioni che illustrano e chiarificano le idee e i concetti manifestati da taluni oratori si avrebbero delle riunioni notevoli soltanto per l’apatia generale. Finì testualmente così: “i fatti dimostrano il mio dire, anche in questa riunione il compagno Garlandi ha parlato a lungo e contro la destra. Voi non dite nulla e fate blocco con essa contro di noi, questo dimostra che il gruppo non solo non ha capacità ma neanche serietà”. [11]
Le lettere inviate al padre, intercettate dall’Ovra, avevano rivelato al regime anche un’altra potenziale carta di adescamento: Ambrogi versava in drammatiche condizioni economiche. Nonostante tutto, la polizia scelse comunque di adottare nei suoi confronti la tipica tattica dispiegata nei confronti dei gruppi della «sinistra comunista»: fu infatti lasciato libero di operare tranquillamente, controllato e addirittura agevolato nei suoi spostamenti al fine di trarre profitto dalla opera disgregatrice procrastinata all’interno del partito. Dopo essersi trasferito in Belgio, egli aveva quindi fatto ritorno in Unione Sovietica senza incontrare alcun tipo di ostacolo: tuttavia, i suoi rapporti con Stalin e il temporaneo rientro nel partito bolscevico conobbero una brusca interruzione nel 1935, quando – passato nuovamente all’opposizione e ancora attivo nell’ala vicina a Bordiga – sfuggì alle «purghe» solo grazie all’intervento dall’ambasciata italiana a Mosca. Ripartito nuovamente alla volta di Bruxelles, fu qui che i fascisti tentarono definitivamente l’aggancio.
Il 31 luglio 1936, la Regia ambasciata d’Italia a Bruxelles inviò un telegramma riservatissimo e urgente a Roma. L’oggetto riportava la dicitura di «Ambrogi avv. Ersilio» e il contenuto una chiara sintesi della sua manifestazione d’intenti:
Ho l’onore di informare V. E. che ho potuto avvicinare l’Ambrogi allo scopo di conoscere i di lui intendimenti. Da tale colloqui è risultato che trattasi, come V. E. conosce, di un comunista dissidente, divenuto tale non per aver abbandonato le sue opinioni comuniste, ma per aver avuto campo di osservare da vicino il Governo sovietico all’opera. Egli (sono parole dell’Ambrogi), d’accordo con le diverse opposizioni, ritiene che la propria posizione politica sia insufficiente senza una lotta efficace contro la influenza della III° Internazionale. Ma, in considerazione del fatto che la III° Internazionale si appoggia sopra uno Stato potentissimo, ed avvantaggia la sua influenza dalle varie coalizioni di questo Stato con altri Stati, creando e sfruttando movimenti diretti a favorire e a rafforzare tali coalizioni nello esclusivo interesse del nazionalismo russo (che non sempre coincide con le esigenze del movimento rivoluzionario di cui essa si dice banditrice), ogni movimento di opposizione, ha continuato l’avvocato Ambrogi, limitato ai gruppi proletari dissidenti è a priori votato all’insuccesso ed è quindi necessaria la coordinazione di altre forze di opposizione coincidenti. Inoltre (sono ancora parole dell’Ambrogi) si può constatare la esigenza di tutti i punti di coincidenza anche fra lo Stato fascista e la opposizione comunista nella questione della lotta contro la influenza della III° Internazionale. L’Ambrogi intende in questa lotta mettere a profitto tutta la propria esperienza ove sia possibile un accordo diretto alla coordinazione di forze contro la influenza moscovita. Ma tale accordo sarebbe possibile (anche per ragioni tattiche) solo se non si escludesse a propri quella attività politica che spinge il Sig. Ambrogi alla lotta contro la III° Internazionale. In altri termini, l’Ambrogi teme che le varie frazioni di comunisti attualmente in opposizione con la III° Internazionale siano, a causa della loro debolezza, assorbite nuovamente dal Governo dell’Urss o dalle sue emanazioni; ad evitare ciò l’Ambrogi domanda un’intesa col Governo Fascista e l’appoggio di essa. Circa i termini concreti di tale accordo e delle attività dell’Ambrogi, questi ritiene che non potrebbe altrimenti discutersi che in colloqui che un incaricato del Governo Fascista dovrebbe avere col sig. Ambrogi, probabilmente in un tempo molto prossimo. [12]
Furono questi contatti e la percezione che i comunisti maturarono di essi a spingere Dante Corneli, nel suo ricordo del 1979, a dipingere Ersilio Ambrogi come un «agente staliniano e spia fascista che aveva fornito alla polizia italiana importanti notizie sull’attività clandestina che il partito svolgeva in Italia»[13]. Certo, le due parti in causa cercarono in quei contatti – frequenti tra il 1936 e il 1937 – favori vicendevoli: la polizia mussoliniana indicazioni finalizzate ad intercettare i movimenti dei principali esponenti attivi nella rete clandestina comunista; Ambrogi un appoggio alla sua causa politica, aspetto che il fascismo cercò di promuovere anche attraverso l’offerta di vantaggiose concessioni quali la promessa di una radiazione dal Casellario politico centrale o la cancellazione del suo nome dall’elenco dei «sovversivi attentatori o capaci di atti terroristici»[14]. Eppure, nonostante i contatti, Ambrogi conservò sempre una scaltrezza che – in realtà – gli consentì di non cadere nella trappola dell’Ovra, evitando di trasmutarsi come altri suoi compagni in un fiduciario dei servizi segreti.
Constatata l’impossibilità di incidere sulla linea intrapresa dal Pcd’I e ormai sempre più emarginato, egli decise così di interrompere ogni forma di relazione con la polizia politica. A confermarlo un telegramma rigido e nervoso inviato da Guido Leto, capo della Polizia politica, alla Divisione affari generali e riservati il 15 ottobre 1940:
Si comunica che l’arresto dei connazionali Ambrogi Ersilio e Carrà Renzo è stato provocato – come quello di vari altri sovversivi – da questo Ministero allo scopo di eliminarli dal loro campo di azione all’estero, cosa più che opportuna specie nell’attuale momento. Per quanto riflette il contenuto del rapporto della Gerenza degli Affari Consolari a Bruxelles e, più specificatamente, l’accenno che vien fatto, in tale rapporto, ai contatti avuti dall’Ambrogi Ersilio con la R. Ambasciata a Bruxelles, codesto stesso Ministero sa come ebbero origine e come si risolsero, invero in ben poca cosa, i contatti stessi. È noto che l’Ambrogi, il quale nel 1924 fu condannato dalla Corte di Assise di Livorno in contumacia ad anni 21, mesi 10 e giorni 18 di reclusione per essersi reso moralmente e materialmente responsabile del grave eccidio di Cecina del 1921, nei primi del 1922 riuscì a raggiungere il “paradiso sovietico” ove, accolto con tutti gli “onori”, si mise a servizio della Gpu, dirigendone la sezione italiana. Egli lasciò poi la Russia soltanto per circostanze e contrasti ideologici, ma, come ricorderà codesto Ministero, egli dichiarò esplicitamente, quando noi tentammo approcci e contatti con lui, che “era comunista e rimaneva tale”, rifiutandosi recisamente di relazionarci su cose, uomini e metodi della Gpu. Ragioni di opportunità consigliarono, sul momento, di mantenere ugualmente i contatti con lui per poter trarre almeno qualche profitto della campagna giornalistica che egli si proponeva di svolgere in dipendenza dai contrasti ideologici che gli avevano fatto abbandonare la Russia. Ma, anche da questo lato, l’Ambrogi servì ben poco tanto che fummo costretti a troncare i rapporti iniziati con lui. L’Ambrogi è sempre stato un elemento pericoloso e resta tale, pertanto, non vi sono motivi di sorta che possano consigliare di avere per lui qualsiasi considerazione e di dispensarlo dal rendere, come gli altri, i dovuti “conti” sull’attività sovversiva da lui svolta all’estero. [15]
Allontanato dai compagni e messo al bando dal fascismo, nel 1940 Ambrogi venne arrestato dopo l’invasione del Belgio, rilasciato dai tedeschi e poi nuovamente catturato ed estradato in Italia. Assegnato al confino politico per un anno, dopo l’armistizio di Cassibile fu deportato in Germania.
La sua esperienza politica sarebbe rimasta ai margini anche al termine della guerra, quando si ritirò a Livorno per riprendere l’attività di avvocato. Il Pci lo tenne infatti sempre a debita distanza, condizionato dalle voci sul suo conto e da un ruolo mai definitivamente chiarito. Ottenne la riammissione solo nel 1957, sette anni prima di morire – l’11 aprile 1964 – a Venturina. A favorirne il rientro, arrivato dopo molteplici tentativi di riammissione, furono probabilmente l’età ormai avanzata e l’allentamento delle norme di accesso al partito che seguirono alle conseguenze dei fatti di Budapest e alla dura requisitoria con cui Kruscev aveva condannato i crimini di Stalin nel corso del XX Congresso del Pcus (1956). La sua storia, oltretutto, non venne neppure accennata da Paolo Spriano nei sui volumi sulla Storia del Partito comunista (nominato solo due volte, ma nei volumi antecedenti a quelli relativi al secondo dopoguerra) [16], specchio di un insabbiamento politico che difficilmente poteva trovare la sua ragion d’essere nella mancanza di informazioni al riguardo.
Il resoconto dei rapporti di Ambrogi con i fascisti, tuttavia, non ci consegna il profilo di un informatore. Piuttosto, emerge il quadro di un militante tanto avverso alla causa fascista, quanto apparentemente ostile alla direzione imboccata dall’Urss di Stalin e dalla maggioranza dei comunisti italiani. Una vicenda qui solo scalfita ed in attesa di scavi più accurati, eppure ugualmente utile per problematizzare più a fondo la complessa cornice degli anni della clandestinità e del collaborazionismo.
[1] S. Tranquilli, Borghesia, piccola borghesia e fascismo, in «Stato operaio», aprile 1928.
[2] Cfr. M. Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia fascista, Bollati Boringhieri3, Torino 2020, pp. 311-312; M. Canali, Le spie del regime, Il Mulino, Bologna 2004.
[3] Cfr. C. Pinzani, Il partito nella clandestinità: problemi di organizzazione (1926-1932), in M. Ilardi – A. Accornero (a cura di), Il Partito comunista italiano. Struttura e storia dell’organizzazione (1921-1979), Feltrinelli, Milano 1982, pp. 975-1005.
[4] P. Spriano, Storia del Partito comunista. Gli anni della clandestinità, II, Einaudi, Torino 1969, p. 110.
[5] Romolo Tranquilli era stato fermato a Como con l’accusa – mai confermata – di aver preso parte all’attentato che il 12 aprile 1928 aveva provocato 20 morti e 23 feriti alla fiera di Milano, arrestato e tradotto nel carcere di Marassi, a Genova. La vicenda colpì profondamente Silone, il quale, forse nell’invana speranza di una sua scarcerazione, intrecciò fino al 1930 un intreccio di informazioni con l’ispettore Guido Bellone sotto il falso nome di «Silvestri»: cfr. M. Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra, cit., pp. 335-342. Cfr. anche: M. Canali – D. Biocca, L’informatore: Silone, i comunisti e la polizia, Luni, Milano 2000.
[6] Cfr. M. Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra, cit., p. 320.
[7] Cfr. A. Mettewie Morelli (a cura di), Lettres et documents d’Ersilio Ambrogi (1922-1936), in «Annali della Fondazione Giacomo Feltrinelli», 1977, pp. 173-291.
[8] Cfr. «Il Messaggero Toscano» 4 febbraio 1921.
[9] Per un breve quadro biografico di Ersilio Ambrogi, si veda: F. Andreucci – T. Detti (a cura di), Il Movimento operaio italiano. Dizionario biografico, I, Editori Riuniti, Roma 1975, pp. 58-60; F. Bertolucci, Ambrogi, Ersilio, in http://www.bfscollezionidigitali.org/entita/12902-ambrogi-ersilio/ (ultima consultazione: 21 settembre 2020); M. Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra, cit., pp. 334-335.
[10] P. Spriano, Storia del Partito comunista. II, cit., p. 353.
[11] Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della Pubblica Sicurezza, Casellario Politico Centrale, b. 92, fasc. 747, Ambrogi, Ersilio Paolo Giuseppe, Telegramma del prefetto di Livorno al ministero dell’Interno, 7 giugno 1929. Nel comunicato, il nome di Garlandi è sottolineato.
[12] In ibidem, Telegramma della Regia ambasciata d’Italia a Bruxelles al ministero dell’Interno con oggetto Ambrogi avv. Ersilio, 31luglio 1936
[13] D. Corneli, Lo stalinismo in Italia e nell’emigrazione antifascista, III, Ripoli, Tivoli 1979, p. 32.
[14] Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della Pubblica Sicurezza, Casellario Politico Centrale, b. 92, fasc. 747, Ambrogi, Ersilio Paolo Giuseppe, Comunicato del capo della Polizia politica alla Divisione affari generali e riservati del ministero dell’Interno, 15 ottobre 1940. Il telegramma, datato 29 novembre 1937 e firmato dal prefetto di Livorno, Emanuele Zannelli, recitava in chiusa che «in questi ultimi tempi [Ambrogi] si è dichiarato favorevole ai troschisti e desideroso di combattere di più il comunismo che il fascismo italiano. Richiami al riguardo la ministeriale n° 14064747 dell’11 Marzo 1936».
[15] In ibidem.
[16] Nei primi due volumi, il nome di Ambrogi compare solo saltuariamente: cfr. P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Da Bordiga a Gramsci, I, Einaudi, Torino 1967, pp. 90; 100; 130; 163; 175; 217-220; 228n; 296n.; Id., Storia del Partito comunista italiano, II, cit., p. 9.