UNA COSPIRAZIONE IN MARE APERTO.

Fra le diverse ricorrenze dell’Undici settembre (Strage nel carcere di Attica, 1971; Golpe in Cile, 1973; Attacco alle Twin Towers, 2001), ve ne è una che appartiene alla storia dell’antifascismo in Italia, ossia l’attentato politico compiuto da Gino Lucetti contro Benito Mussolini, appunto l’11 settembre 1926. «Della serie di attentati che punteggiarono la soppressione delle libertà italiane – come sottolineò lo storico “azionista” Aldo Garosci – esso fu quello in cui si espresse la più lucida e chiara volontà politica».
Il mancato tirannicida, una volta catturato, davanti agli inquirenti si era proclamato «anarchico individualista», onde evitare conseguenze per altri; ma, in contrasto con l’interpretazione in chiave solipsistica del suo gesto, risulta ormai appurata l’esistenza di una rete cospirativa con condivise finalità che vedeva il coinvolgimento, a diversi livelli, di anarchici di differente tendenza, ex-arditi del popolo e antifascisti “d’azione”. Meno conosciuta ed indagata rimane invece la decisiva riunione tenutasi segretamente un anno prima dell’attentato a Livorno dove, come le autorità non ignoravano, erano attivi imbarchi e collegamenti clandestini.
Infatti, secondo la testimonianza dell’anarchico carrarino – poi comandante partigiano – Ugo Mazzucchelli (1903-1997), avvalorata dallo storico Gino Cerrito, nell’estate del 1925 a Livorno vi era stata una riunione clandestina, a bordo di un barcone in mare aperto, a cui presero parte, oltre a Lucetti e a Mazzucchelli, gli anarchici livornesi Augusto Consani e Virgilio Recchi, già organizzatori del Battaglione degli Arditi del popolo, nonchè due minatori anarchici di San Giovanni Valdarno e qualche altro militante non identificato[1]. Lucetti era infatti rientrato clandestinamente da Marsiglia, dove era espatriato alla fine del 1922 intessendo rapporti con gli ambienti più risoluti del “fuoriuscitismo” antifascista. Da quanto si può dedurre e come confermato dal militante anarchico Piero Di Pietro, in questa riunione, preceduta da altri incontri nel carrarese, era stato deciso e delineato un piano operativo per l’eliminazione fisica di Mussolini, oltre a concertare conseguenti sollevazioni contro il regime. Infatti, dopo la mancata insurrezione a seguito del delitto Matteotti e il fallimento della politica aventiniana, «ogni transazione [era] divenuta impossibile».
Lucetti, anarchico d’azione, era eticamente determinato ad attentare alla vita del duce sin dal dicembre 1922, a seguito della strage operaia di Torino, e già nel gennaio-febbraio 1923 si era recato a Roma per verificarne l’attuazione- Il progetto dovette però essere rinviato in quanto Lucetti rimase coinvolto e ferito in una sparatoria con i fascisti ad Avenza, presso il caffè Napoleone in piazza Rivellino, avvenuta nella notte fra il 25 e il 26 settembre 1925. Ricercato dai fascisti e dalla polizia, dovette quindi nascondersi e l’11 ottobre imbarcarsi come “clandestino” su un naviglio per il trasporto di marmo diretto a Marsiglia[2].
L’ANARCHICO ARDITO
 Gino Lucetti era nato ad Avenza, frazione del comune di Carrara (MS), il 31 agosto 1900, da Filippo e Adele Crudeli[3]. Dopo aver studiato sino alla VI classe elementare, aveva iniziato a lavorare in cava, divenendo un lizzatore, ossia addetto al faticoso e pericoloso spostamento dei blocchi di marmo. In gioventù era stato vicino agli ideali repubblicani, peraltro non in contraddizione con quelli libertari[4].
Gino Lucetti era nato ad Avenza, frazione del comune di Carrara (MS), il 31 agosto 1900, da Filippo e Adele Crudeli[3]. Dopo aver studiato sino alla VI classe elementare, aveva iniziato a lavorare in cava, divenendo un lizzatore, ossia addetto al faticoso e pericoloso spostamento dei blocchi di marmo. In gioventù era stato vicino agli ideali repubblicani, peraltro non in contraddizione con quelli libertari[4].
Secondo quanto si può dedurre dal confuso Foglio matricolare n. 17822, il 24 marzo 1918 era stato chiamato sotto le armi e, al 2 luglio seguente, risultava «giunto in territorio dichiarato in stato di guerra» ed assegnato come autiere al 2° Reparto d’Assalto di Marcia che, alla vigilia della battaglia finale di Vittorio Veneto, si trovava dislocato nel trevigiano, fra Pederobba e Palazzon. Probabilmente non aveva preso parte a combattimenti, ma dopo l’attentato a Mussolini, la circostanza d’aver comunque fatto parte degli Arditi venne omessa nelle cronache, eccetto che in un articolo sfuggito alla censura, pubblicato su «La Nazione» del 14 settembre 1926, mentre su altri giornali, come la «Gazzetta livornese» del 13 settembre, fu indicato quale ex artigliere[5].
Dopo essere stato posto in congedo provvisorio il 28 febbraio 1919, il 1° dicembre 1919 venne richiamato in servizio presso diversi reggimenti di fanteria (90°, 65°, 25°), venendo impiegato anche nella bonifica dei residuati bellici. Ancora in grigioverde, nel 1921 per un’assenza di quattro giorni fu denunciato per diserzione e per aver sottratto «oggetti d’armamento» (un fucile 91 con relativa baionetta), venendo però assolto, condonato e finalmente congedato nel novembre 1921.
Tornato ad Avenza, alla fine del 1922 decideva di lasciare illegalmente l’Italia a seguito di scontri avuti con fascisti nella zona di Carrara; aiutato dal fratello Andrea, s’imbarcava su un navicello carico di marmo, approdando a Nizza e poi a Marsiglia dove gli fu sempre possibile trovare lavoro come scalpellino presso laboratori del marmo gestiti da italiani di simpatie libertarie o antifasciste.
In Francia era entrato in relazione con esponenti di primo piano dell’anarchismo, dall’antiorganizzatore Paolo Schicchi al federalista Camillo Berneri, e nel 1924, aveva aderito alle Legioni garibaldine della Libertà che, velleitariamente, avrebbero dovuto penetrare in Italia e rovesciare con le armi il regime mussoliniano.
Nello stesso anno risultava essere abbonato alla rivista anarchica «Pensiero e volontà», di cui erano promotori Errico Malatesta e Luigi Fabbri, collaborando saltuariamente al settimanale «Fede!», diretto da Luigi Damiani; due testate non riconducibili all’anarchismo di tendenza individualista.
Dopo l’infausto epilogo garibaldino, apparve evidente che, contro il totalitarismo fascista, altre strade andavano percorse e, superando le diverse impostazioni teoriche, gli anarchici raggiunsero una sostanziale unità d’azione.
Lucetti, come si è visto, sarebbe rientrato in Italia nell’estate del 1925 per uccidere il duce, nella prospettiva d’innescare sommosse, scioperi e attentati; ma in ottobre dovette precipitosamente ripartire alla volta della Francia.
Ritornato furtivamente in Versilia alla fine del maggio 1926, su un barcone da Marsiglia al porto di Marina di Carrara (secondo diversa fonte, nascosto in un vagone merci al confine di Ventimiglia), s’entrò nella fase operativa del piano: in giugno, Lucetti soggiornò almeno una settimana a Roma, ospite di Caterina Diordi, cercandovi anche un lavoro come scalpellino, e forse ancora un giorno o due a metà luglio.
Fra una “trasferta” e l’altra, trovò ospitalità presso compagni compiacenti a Montignoso e soprattutto a Viareggio, con qualche fugace visita familiare ad Avenza.
 Con ogni probabilità in questo periodo, furono reperite le armi, una pistola automatica Browning procuratagli dal repubblicano romano Vincenzo Baldazzi (1898-1982), detto “Cencio”, già dirigente nazionale degli Arditi del popolo, e due bombe a mano SIPE, a frammentazione, che l’anarchico avenzino Gino Bibbi (1899-1999), suo cugino, aveva recuperato a Trieste dall’anarchico Umberto Tommasini (1896-1980), così come confermato da entrambi. Dell’attentato in preparazione appare accertato che furono messi al corrente o vi ebbero una qualche parte gli anarchici Malatesta, peraltro in stretti rapporti sia politici che amicali col Baldazzi, Temistocle Monticelli e Luigi Damiani, esponenti di primo piano dell’Unione anarchica italiana già costretta all’attività clandestina[6].
Con ogni probabilità in questo periodo, furono reperite le armi, una pistola automatica Browning procuratagli dal repubblicano romano Vincenzo Baldazzi (1898-1982), detto “Cencio”, già dirigente nazionale degli Arditi del popolo, e due bombe a mano SIPE, a frammentazione, che l’anarchico avenzino Gino Bibbi (1899-1999), suo cugino, aveva recuperato a Trieste dall’anarchico Umberto Tommasini (1896-1980), così come confermato da entrambi. Dell’attentato in preparazione appare accertato che furono messi al corrente o vi ebbero una qualche parte gli anarchici Malatesta, peraltro in stretti rapporti sia politici che amicali col Baldazzi, Temistocle Monticelli e Luigi Damiani, esponenti di primo piano dell’Unione anarchica italiana già costretta all’attività clandestina[6].
L’ATTENTATO SENZA FORTUNA
Dopo l’attentato, sia sulla stampa che nell’inchiesta giudiziaria, venne dato molto risalto ai collegamenti dell’anarchico con «le centrali dell’antifascismo» in Francia e lo stesso Mussolini additò «certe tolleranze colpevoli e inaudite di oltre frontiera», ma in realtà Lucetti si era mosso in modo autonomo, facendo piuttosto affidamento sui compagni in Italia. Infatti, ai compagni di Marsiglia tenne nascosto l’imminente partenza per l’Italia e chiese i soldi necessari per il viaggio ad un’ignara compaesana. Considerato che il “fuoriuscitismo” era pesantemente infiltrato dalla polizia politica fascista, tale scelta gli permise di muoversi con relativa sicurezza, cogliendo di sorpresa l’apparato poliziesco, tanto che in conseguenza dell’attentato, Mussolini dimissionò il capo della polizia Crispo Moncada, sostituito dal “superpoliziotto” Arturo Bocchini.
Giunto a Roma, il 2 settembre 1926, Lucetti trovò alloggio, sotto falso nome, presso l’albergo “Trento e Trieste”, grazie all’amico e compagno Leandro Sorio che vi lavorava come cameriere, e la mattina dell’11 settembre 1926 entrò in azione nei pressi del piazzale di Porta Pia, eludendo la vigilanza di una cinquantina di agenti in divisa e in borghese dislocati lungo il percorso “presidenziale”.
 Al passaggio dell’auto, una nera “limousine” Fiat 519, che conduceva Mussolini dalla sua residenza estiva di Villa Torlonia al Ministero degli Esteri a Palazzo Chigi[7], Lucetti lanciava, dopo averne accesa la miccia, una SIPE fidando che questa (pesante circa mezzo chilo) sfondasse il vetro dello sportello posteriore laterale destro ed esplodesse all’interno della vettura, dove era seduto il duce. Purtroppo, a causa del sobbalzo dell’auto per un avvallamento della strada, la granata colpì la cornice superiore della portiera, pochi centimetri sopra il vetro, rimbalzando e deflagrando sul selciato, col ferimento di otto passanti raggiunti da schegge[8].
Al passaggio dell’auto, una nera “limousine” Fiat 519, che conduceva Mussolini dalla sua residenza estiva di Villa Torlonia al Ministero degli Esteri a Palazzo Chigi[7], Lucetti lanciava, dopo averne accesa la miccia, una SIPE fidando che questa (pesante circa mezzo chilo) sfondasse il vetro dello sportello posteriore laterale destro ed esplodesse all’interno della vettura, dove era seduto il duce. Purtroppo, a causa del sobbalzo dell’auto per un avvallamento della strada, la granata colpì la cornice superiore della portiera, pochi centimetri sopra il vetro, rimbalzando e deflagrando sul selciato, col ferimento di otto passanti raggiunti da schegge[8].
Particolari poco conosciuti dell’azione armata sono stati rivelati da “Cencio” Baldazzi in un’intervista del 1976, che confermano il carattere tutt’altro che “individuale” dell’attentato: «c’entravo io, Malatesta, [Attilio] Paolinelli, c’entravamo tutti, tutto il cerchio nostro della resistenza romana. Noi avevamo preparato due attentati a Mussolini, uno al Tritone, ed uno a Porta Pia […] dopo aver organizzato una certa convergenza intorno Porta Pia»[9].
Lucetti, fu quasi subito catturato dal maresciallo capo Dottarelli e dal vice brigadiere Motta che, assieme all’ispettore di PS Bodini responsabile del servizio di scorta, si trovavano sull’Alfa Romeo che seguiva dappresso l’auto di Mussolini. Lucetti disponeva di un’altra SIPE e della pistola Browning, presumibilmente cal. 7,65, con proiettili artigianalmente modificati per renderli più efficaci, che non potè usare. Condotto in Questura in piazza del Collegio Romano (attualmente commissariato di PS Trevi-Campo Marzio), subì i primi interrogatori e pestaggi, mentre all’esterno fascisti facinorosi provocavano incidenti.
Già mezz’ora dopo l’attentato veniva arrestato Malatesta presso la propria abitazione e a distanza di poche ore la sua compagna, l’anarchica Elena Melli (1899-1946); a Roma, nella retata anti-anarchica finivano militanti noti quali i tre fratelli Turci, Aldo Eluisi, Francesco Porcelli, Carlo Monticelli, Eolo Varagnoli, Adelmo Preziosi ma anche semplici simpatizzanti oppure non anarchici, fra cui i comunisti Umberto Terracini e, a Milano, Ottorino Perrone. Non mancarono le spedizioni punitive, come quella contro l’onorevole socialista Attilio Susi a Santa Marinella.
A Livorno, col pretesto che fra i passanti feriti vi era il cappellaio Garibaldo Paoletti, originario di Livorno, i fascisti assaltarono il consolato francese. Sempre nella città labronica, innumerevoli furono i messaggi di felicitazione ed esecrazione, fra cui quello del Maestro Pietro Mascagni a cui Mussolini rispose personalmente. Nella chiesa di S, Giulia, invece, «venne cantato un solenne “Te Deum” di ringraziamento per lo scampato pericolo del Primo Ministro Benito Mussolini».
Nell’arco di pochi giorni furono effettuati almeno 500 arresti e 600 perquisizioni, soprattutto nella capitale ma anche altrove; ad esempio, tra minatori di S. Giovanni Valdarno. Tra i circa sessanta arrestati fra Carrara ed Avenza, vi erano gli amici, i familiari e i parenti di Lucetti ed anche la sua fidanzata, Nella Menconi (1899-1975). A Roma, furono subito tratti in arresto Baldazzi, Leandro Sorio (1899-1975) e Stefano Vatteroni (1897-1965). Quest’ultimi due vennero condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, rispettivamente a 20 e 18 anni di carcere, «complicità non necessaria»[10]. Baldazzi, invece, ebbe una condanna a cinque anni di carcere per la complicità nell’attentato e ad altri cinque per aver poi fornito aiuto finanziario alla madre di Lucetti[11]. I familiari, fra cui il cugino Gino Bibbi e la madre, furono assolti «per il reato di concorso in mancato omicidio di S.E. il primo ministro» nel giugno del 1927. Nelle settimane seguenti, numerose furono pure le sentenze per «apologia di attentato» nei confronti di persone che avevano espresso, magari in un’osteria, il proprio rammarico per il tentativo non andato a buon fine. Accadde anche a Livorno, dove nei pressi di Piazza dei Mille tre «giovanotti» furono arrestati e denunciati per aver parlato «a voce alta dell’attentato contro la persona di S.E. Mussolini, esaltando l’attentatore, augurando un nuovo infame gesto contro il Duce»[12]. A Rio Marina, per lo stesso reato, il contadino anarchico Narciso Trenti fu condannato a 30 mesi di reclusione e 300 lire di ammenda[13].
CONDANNA E MEMORIA
Il processo, svoltosi dall’8 all’11 giugno 1927, apparve come una farsa, con l’avvocato d’ufficio Emilio Tommasi, che sembrava l’accusatore dell’imputato, mentre il P.M. Enea Noseda lo additava quale «parricida». A presiedere il Tribunale Speciale vi era il generale Carlo Sanna e della corte faceva parte il conte Antonio Tringali-Casanuova, futuro presidente del Tribunale speciale sino al 1943, nato a Cecina e fascista della prima ora. Lucetti venne condannato a 30 anni di reclusione; fra i delitti di cui fu ritenuto colpevole, quello di aver commesso il fatto «anche col fine d’incutere pubblico timore e di suscitare tumulto e pubblico disordine», con evidente allusione alle finalità di destabilizzazione del regime[14]. Da parte sua, durante l’udienza, Lucetti rifiutò decisamente l’accusa di essere un sicario eterodiretto, così come – sin dal primo interrogatorio – aveva tenuto a precisare che «il mio è stato un attentato da proletario».
Lo aspettavano 17 anni di carcere: dal Terzo Braccio di “Regina Coeli” nel luglio del 1927 fu condotto, via Livorno, nel penitenziario elbano di Portolongone (oggi Porto Azzurro) con i ferri ai polsi e «la lugubre casacca a righe», come riferito su «Il Telegrafo» dell’8 e 9 luglio.
Nel febbraio 1930 venne trasferito nel carcere di Fossombrone (PU), dove in occasione del Primo maggio 1932, assieme ad altri sei detenuti comunisti e anarchici – fra i quali il livornese Tito Raccolti e il veronese Giovanni Domaschi – realizzò artigianalmente e fece uscire dal carcere una quindicina di manifestini, oltre a cantare l’Internazionale e Bandiera rossa. A seguito di tale dimostrazione, il mese dopo fu deportato nell’isola-carcere di Santo Stefano (LT)[15]. Nel terribile penitenziario ex-borbonico, Lucetti rimase sino al settembre 1943, trattenuto dalle misure anti-anarchiche del governo Badoglio, anche dopo la “caduta” di Mussolini. Finalmente liberato da paracadutisti americani il 10 settembre, assieme ad una sessantina di “politici”, fu trasferito all’Isola d’Ischia dove, drammaticamente, il 17 dello stesso mese venne ucciso da un colpo d’artiglieria sparato dalle forze tedesche dalla costa napoletana, forse da Monte Procida o da Capo Miseno, con obiettivo le motosiluranti alleate presenti in porto.
 Quando la tragica notizia raggiunse il carrarese dove era in corso la resistenza, la prima formazione partigiana di tendenza libertaria assunse il suo nome e così anche quella poi ricostituita come “Lucetti bis”. A liberazione avvenuta, il CLN di Carrara, accogliendo l’ampia sollecitazione popolare, decise di intitolare a Lucetti la centrale e storica piazza Alberica, ma nel 1963 la giunta comunale decise di intitolargli la piazza Rivellino ad Avenza, mentre quella di Carrara tornava all’antica denominazione.
Quando la tragica notizia raggiunse il carrarese dove era in corso la resistenza, la prima formazione partigiana di tendenza libertaria assunse il suo nome e così anche quella poi ricostituita come “Lucetti bis”. A liberazione avvenuta, il CLN di Carrara, accogliendo l’ampia sollecitazione popolare, decise di intitolare a Lucetti la centrale e storica piazza Alberica, ma nel 1963 la giunta comunale decise di intitolargli la piazza Rivellino ad Avenza, mentre quella di Carrara tornava all’antica denominazione.
La salma di Lucetti, da Ischia, avrebbe fatto ritorno ad Avenza il 27 aprile 1947, salutata da un’enorme manifestazione popolare nella piazza a lui dedicata, con comizio tenuto dall’anarchico Giuseppe Mariani (1898-1974), suo compagno di detenzione a S. Stefano, e poi accompagnata in corteo sino al cimitero di Turigliano, dove ancora si trova.
Imbarcata su una nave a Napoli era approdata nel porto di Livorno sabato 26 aprile, venendo accolta e salutata – dalle ore 12 alle ore 15 – presso la sede della Federazione anarchica livornese in via Ernesto Rossi 80[16]. Come riferisce «La voca apuana» del 3 maggio 1947, «la salma dell’eroe era posta nella sede degli anarchici coperta di bandiere e una numerosa schiera di persone attendevano l’ora della cerimonia. Erano presenti compagni di tutti i partiti e numerosi cittadini», quindi in corteo il feretro giunse in piazza San Marco e, dopo un breve discorso di commiato, fu caricato su un’autoambulanza per l’ultimo trasferimento.
Accompagnata da una delegazione di anarchici carrarini e livornesi, dopo brevi soste commemorative a Pisa, Massa ed Avenza, il trasporto giunse a Carrara attorno alle ore 20 e la bara venne esposta presso la sede della FAI, in piazza Lucetti, in attesa delle grandi manifestazioni dell’indomani.
Alcuni anni dopo, Alberto Tarchiani, uno dei fondatori del movimento antifascista “Giustizia e Libertà”, riferendosi agli attentati alla vita di Mussolini, avrebbe commentato: «chi condannerebbe oggi quei tentativi che non avevano bassi scopi di vendetta, ma convinti propositi di evitare sciagure infinitamente più vaste, eliminando un uomo che, vaneggiando di gloria conduceva l’Italia alla devastazione materiale e morale?».
NOTE
1. Augusto Consani (1883-1953), pastaio, militante di primo piano dell’Unione anarchica livornese, era stato segretario della Camera sindacale del Lavoro (USI) nonché tra gli organizzatori dell’arditismo antifascista. Condannato a cinque anni di confino quale «elemento pericoloso per l’ordine dello Stato», fu deportato a Lipari nel dicembre 1926, venendo rimesso in libertà nel marzo 1927, in via condizionale, poichè ammalato di tubercolosi; ciò nonostante avrebbe continuato l’attività clandestina. Paradossalmente, nel saggio di Nicola Badaloni e Franca Pieroni Bortolotti, Movimento operaio e lotta politica a Livorno 1900-1926 (Editori riuniti, 1977) viene ritenuto «uno dei principali sostenitori di una linea “attendista”». Virgilio Recchi (1900-1982), operaio elettricista, fra i fondatori degli Arditi del popolo, è schedato dal 1926 come anarchico. Nel 1945, è nel Comitato di liberazione aziendale del Cantiere navale OTO e fa parte del Gruppo sindacale libertario; partecipa al Congresso fondativo della FAI in rappresentanza del gruppo “Pietro Gori” e nel 1947 è nella Giunta esecutiva della Camera del lavoro, per la componente anarchica.
2. Secondo una ricostruzione pubblicata sulla «Gazzetta livornese» del 13 settembre 1926, «raggiunta la spiaggia il Lucetti sempre aiutato dal fratello suo Andrea, si imbarcava notte tempo sopra un piccolo gozzo, raggiungendo a forza di remi Lerici, ove all’alba del giorno dopo, un navicello carico di marmi, alzava l’ancora per la Francia».
3. Nei suoi saggi, lo storico Renzo De Felice l’ha ritenuto «nativo della Garfagnana», probabilmente perché, subito dopo l’arresto, Lucetti aveva declinato una falsa identità dichiarando d’essere nato a Castelnuovo Garfagnana (LU).
4. Nel Carrarese vi era una storica collateralità fra gli ambienti repubblicani e anarchici e, in particolare, proprio ad Avenza questa risultava evidente nella bandiera nera della locale sezione mazziniana.
5. Risaliva forse a tale esperienza negli Arditi il «tatuaggio sinistro» “W la morte” che Lucetti recava sull’avambraccio oppure, secondo la declinazione poetica di Virgilia D’Andrea, alludeva a «La morte che dona la vita / La morte che risveglia i popoli / Non quella che li distende inermi ed inetti dentro una tomba senza gloria / La morte che spezza il tiranno / Non quella che la tirannia riassoda ed eterna» (Gloria anarchica, 1933).
6. Il 17 gennaio 1926 si tenne segretamente un Convegno della UAI a Milano ed un altro in forma clandestina ai primi di agosto dello stesso anno. Esiste, tra l’altro, una lettera alquanto sibillina, scritta da Malatesta il 4 settembre 1926 all’anarchico Alfonso Coniglio, in cui comunicava che «Le seicento lire di cui mi parli furono ricevute al principio di quest’anno e furono adoperate non per Pensiero e Volontà[il giornale anarchico diretto da Malatesta] ma per un bisogno urgente del nostro movimento. Io ti scrissi e ti dissi vagamente che cosa avevamo fatto del denaro – senza però entrare in particolari, perché si trattava di cose che non conviene scrivere […] Siamo pieni di belle speranze, ma per ora sono… speranze. Noi però facciamo tutto quello che possiamo perché presto diventino realtà».
7. Nel 1922, Mussolini dopo aver trasferito il ministero delle Colonie nel Palazzo della Consulta, aveva destinato Palazzo Chigi a sede del Ministero degli Esteri e in virtù della sua doppia carica di Presidente del Consiglio e di ministro degli Esteri, ne aveva fatto la sua sede ministeriale.
8. Se invece che la SIPE, ad accensione manuale, fosse stata impiegata la variante a percussione (tipo “Gallina”), l’esito avrebbe avuto ben altra efficacia, scoppiando all’urto.
9. Il coinvolgimento di Baldazzi è stato confermato dalla moglie Elena Vitiello, intervistata da Alessandro Portelli: «lo avevano preparato insieme. La cosa che l’attentato non riuscì, con tutte le misure e tutti i calcoli che avevano fatto, non avevano tenuto conto che la strada era leggermente in discesa».
10. Le prove a loro carico erano labili, tanto che secondo Guido Leto, allora funzionario dell’Ufficio speciale movimento sovversivo ed in seguito a capo dell’OVRA, «l’inchiesta assodò che [Lucetti] non aveva complici», forse anche per giustificare il fallimento della sicurezza.
11. Nonostante la stretta sorveglianza, Baldazzi, riuscì ad incontrarsi con Malatesta (erano vicini di casa, in via Andrea Doria) e a prendere accordi con Attilio Paolinelli ed Aldo Eluisi – entrambi anarchici ed ex-arditi del popolo – nel tentativo «di organizzare la fuga» di Lucetti il giorno stesso del processo.
12. L’arresto di in terzetto per apologia di reato, «Gazzetta livornese», 15 settembre 1926. I tre erano l’operaio carpentiere Vittorio Pieracci, il facchino Licurgo Niccolai e il muratore Ilio Fiorini; i primi due schedati come comunisti, il terzo quale socialista.
13. Per offese al Primo Ministro, «Gazzetta livornese», 16 settembre 1926. Sullo stesso quotidiano si trova anche la notizia del rinvio a giudizio per il capitano marittimo Emilio Oliviero, «imputato di non aver esposta la bandiera in occasione dell’attentato al Duce».
14. Le pene accessorie, oltre a tre anni di vigilanza speciale, erano tragicomiche: 300 lire di ammenda, 600 lire per concessioni governative, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. In seguito, per effetto dei decreti governativi di amnistia e indulto del 1932, 1934 e 1937, la pena risultò ridotta a 17 anni, con scarcerazione prevista per il 10 settembre 1945.
15. Le inumane condizioni di prigionia sono descritte anche dal comunista livornese (seppure nato a Pisa) Athos Lisa in Memorie. Dall’ergastolo di Santo Stefano alla Casa penale di Turi di Bari, Milano, Feltrinelli, 1973.
16. Anche a Livorno, un gruppo anarchico – quello del quartiere S. Jacopo – assunse il suo nome.
Articolo pubblicato nel settembre del 2024.









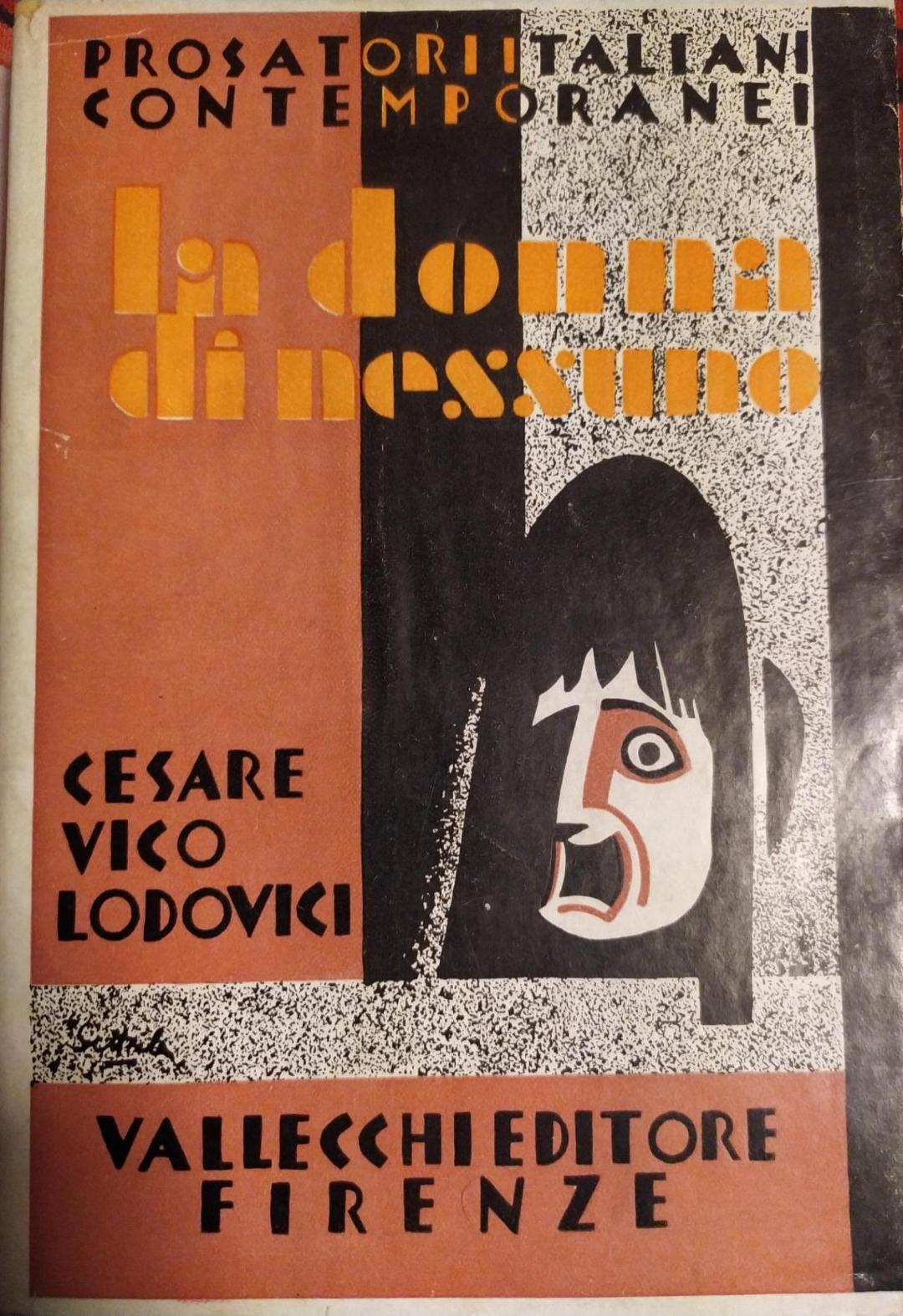
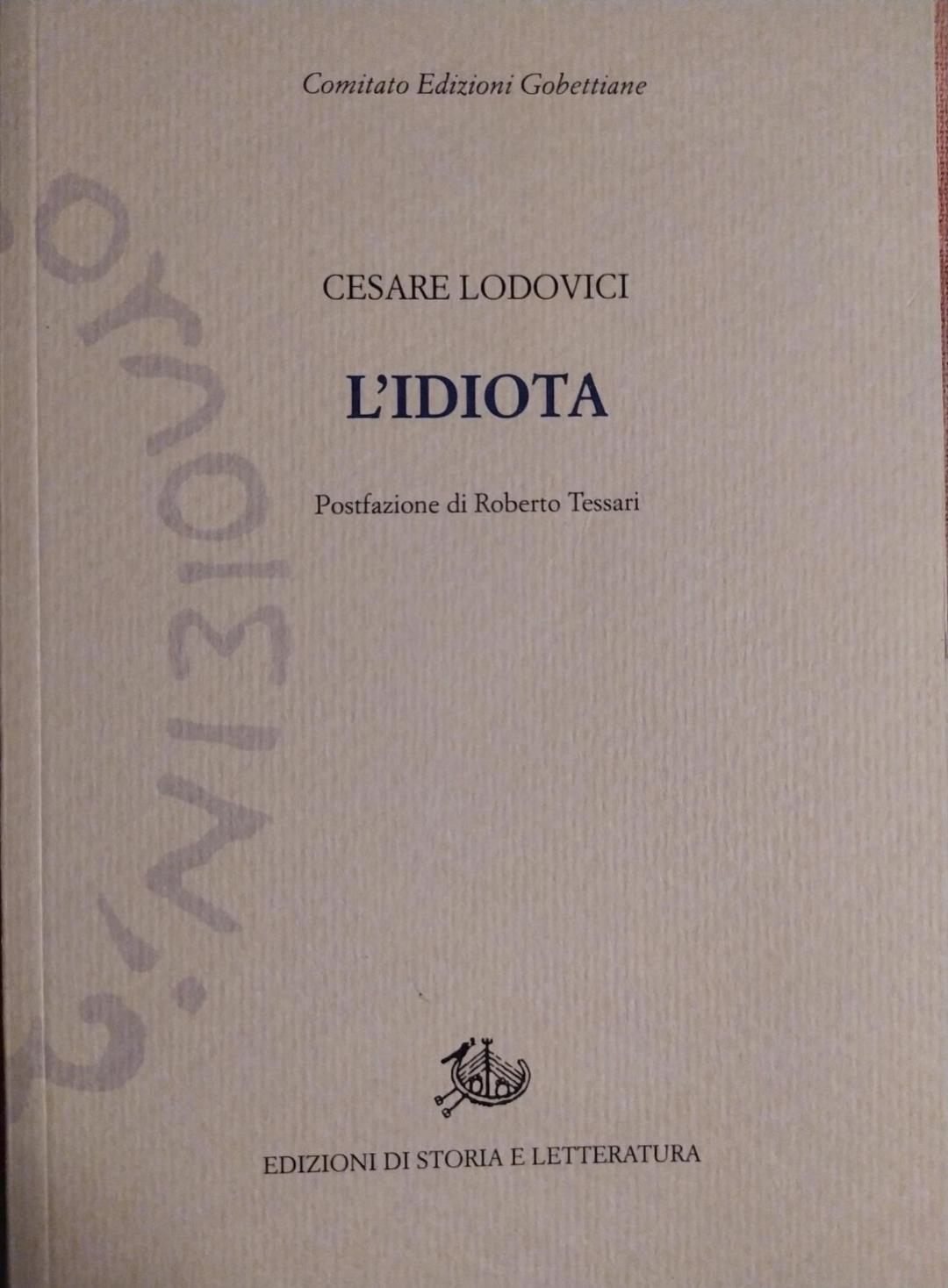

![Lodovici in auto [1923]](https://www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2021/10/Album_Ratto_Lodovici_in_auto_1923.jpg)








