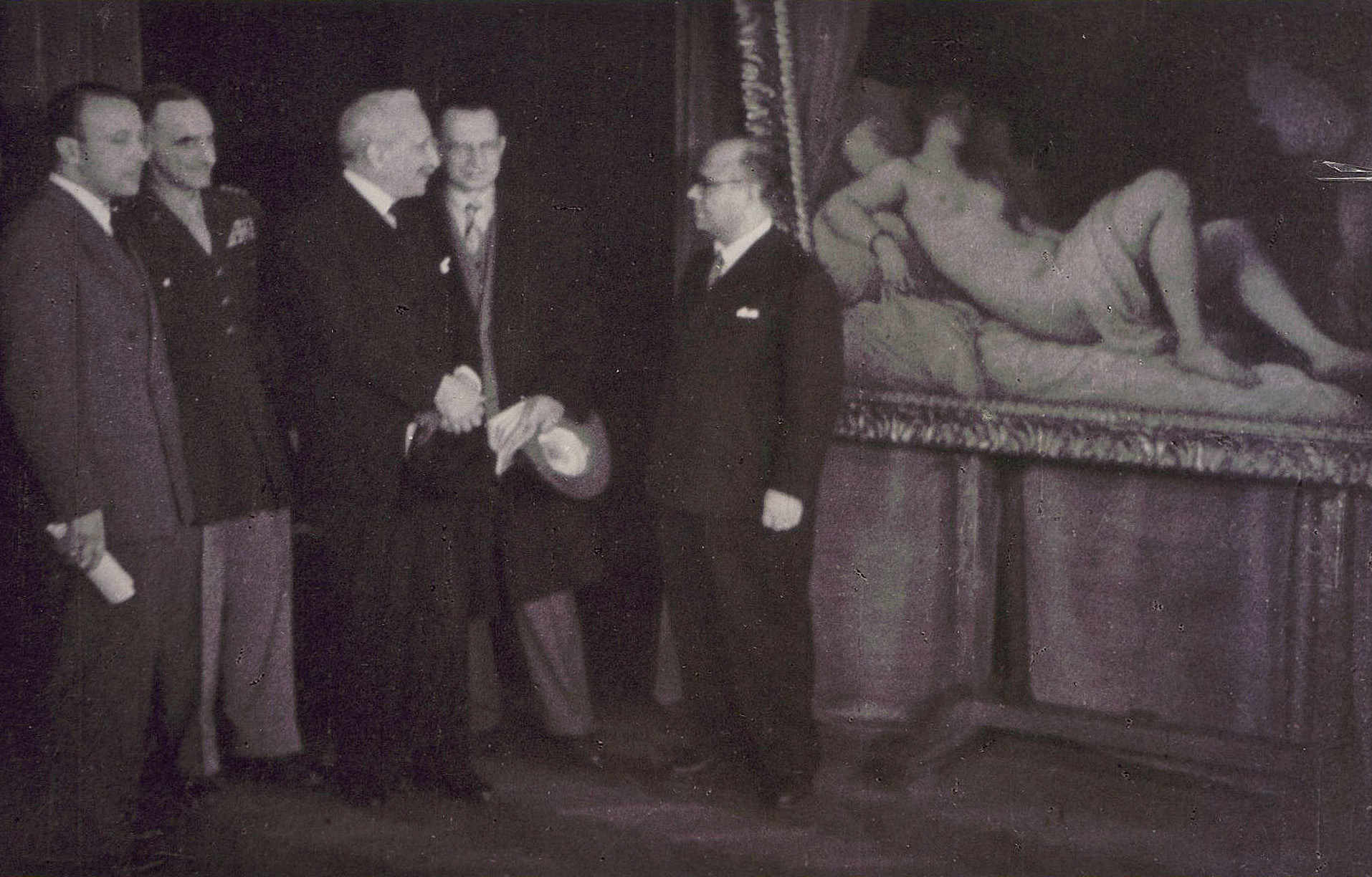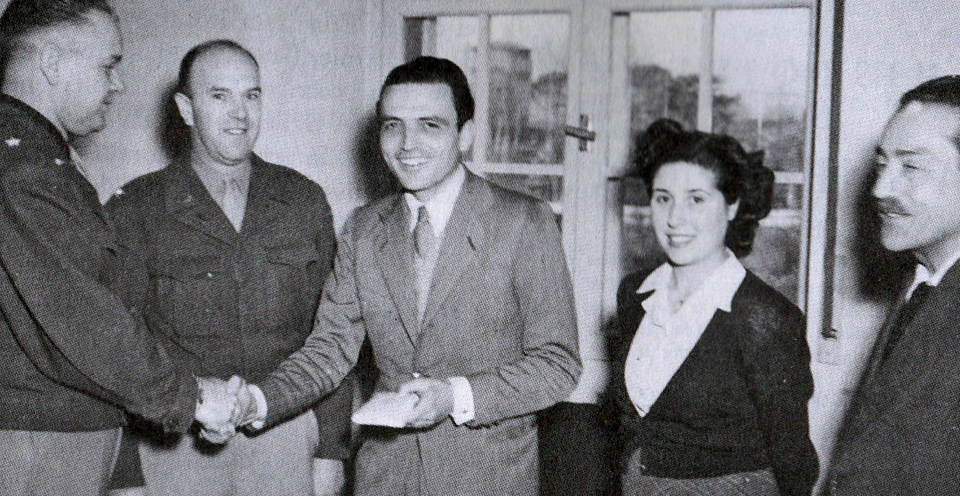Vaiano: storia di una Casa del Popolo

Dopo la fine della Grande Guerra, i socialisti ripresero con vigore, anche in Val di Bisenzio, l’attività di propaganda e di proselitismo: è in questo contesto che si colloca il progetto di dar vita ad una Casa del popolo.
Furono infatti la crescita del sindacato, del movimento cooperativistico, di quello mutualistico e del Partito socialista che fecero sorgere l’idea di costruire a Vaiano una Casa del popolo, per dare finalmente ai lavoratori uno spazio dove fosse possibile svolgere attività di tipo culturale e ricreativo.
Naturalmente bisognava risolvere il problema delle risorse. A questo riguardo, occorre tenere presente che il concordato per l’applicazione delle otto ore nel Pratese, stipulato il 6 maggio 1919, stabiliva che ogni ditta avrebbe versato alla Camera del lavoro, per la costruzione delle Case del popolo di Prato e di Vaiano, una somma non inferiore a sette lire per ogni operaio ed operaia. Dal canto loro, i lavoratori si impegnavano a rinunciare a dieci delle venti lire che avrebbero riscosso in occasione della firma della pace in favore delle erigende Case del popolo.
Grazie a questo meccanismo fu possibile raccogliere buona parte dei fondi necessari, il denaro mancante venne trovato tramite un’apposita sottoscrizione.
A Vaiano fu deciso di rialzare di un piano l’immobile della Cooperativa generale di consumo (sorta nel 1910) e di utilizzare il grande salone che si sarebbe così ottenuto come Casa del popolo. I lavori, iniziati ai primi di aprile del 1920, erano già conclusi nell’estate: in agosto nei locali della Casa del Popolo si svolse un’adunanza dei rappresentanti delle sezioni socialiste della vallata.
La Cooperativa generale di consumo era, a tutti gli effetti, la proprietaria del salone edificato dai lavoratori.
Ma la neonata Casa del popolo cadde ben presto sotto i colpi della violenza squadristica, che, il 17 aprile 1921, si abbatté prima su Prato e poi su Vaiano, colpita in quanto roccaforte del movimento operaio della zona. Nel pomeriggio del 17 aprile giunsero in paese quattordici camion carichi di fascisti scortati da un automezzo dei carabinieri. Sul camion di testa e su quello di coda era stata piazzata una mitragliatrice. Gli squadristi erano circa quattrocento. Arrivati in centro, cominciarono a sparare all’impazzata: il bilancio della spedizione fu di due morti (Guglielmo Vitali ed Umberto Corona) e di tredici feriti tra la popolazione: Vitali venne ucciso mentre stava parlando con degli amici fuori dal caffè detto di “Cucca”, Corona, un giovane diciassettenne soprannominato “il Profughino” perché aveva lasciato il suo paese durante la ritirata delle truppe italiane nel 1917, fu raggiunto da un colpo sparato da una finestra. La Cooperativa generale di consumo, la Società democratica di mutuo soccorso, la Lega laniera, la Lega edile e la Casa del popolo vennero devastate, la stessa sorte subirono diverse case, fra cui quella di Battista Tettamanti, che, negli anni precedenti, era stato alla testa dei lanieri della zona. L’ammontare dei danni fu superiore a 187.000 lire dell’epoca. I danni arrecati alla Casa del popolo furono calcolati in 17.280 lire. La spedizione era stata guidata dal pratese Tullio Tamburini, ex impiegato del lanificio Forti della Briglia, che sarebbe poi divenuto prefetto ed infine capo della polizia della Repubblica sociale italiana.
L’assalto squadristico significò la fine della Cooperativa generale di consumo, che, come si è detto, ospitava anche la Casa del popolo.
I fascisti assunsero il controllo della Cooperativa. L’immobile divenne la sede della Casa del fascio: il salone che era stato della Casa del popolo diventò una palestra dove, in caso di maltempo, si svolgevano le esercitazioni del premilitare. Ma dopo la fascistizzazione la Cooperativa cominciò a navigare in cattive acque ed infine fallì: nel 1929 i suoi locali furono messi all’asta ed acquistati da Dante Bardazzi, fornaio. I fascisti continuarono peraltro ad occuparli senza pagare una lira di affitto al proprietario.
L’immobile restò in loro mano sino al 25 luglio 1943.
Dopo la liberazione di Vaiano (10 settembre 1944) i lavoratori ripresero possesso dell’immobile che era stato della Casa del fascio, sistemandovi le loro organizzazioni politiche e sindacali: i locali furono occupati dal Partito comunista, dal Partito socialista, dalla Camera del lavoro, dalla risorta Cooperativa di consumo e dal Circolo ricreativo. Più tardi fu stipulato un regolare contratto di affitto col proprietario dell’immobile, Dante Bardazzi.
La ripresa della normale attività politica mise in luce la forza ed il radicamento del Partito comunista nella vallata. Anche la CGIL era molto forte: la Camera del lavoro di Vaiano sorse nel 1944.
Nel 1946 fu deciso di costruire una nuova sede per l’organizzazione camerale: il progetto prevedeva che all’edificio fosse annesso un politeama. Negli anni seguenti le energie dei lavoratori vaianesi furono assorbite da questo progetto: i lavori furono ultimati nel 1949, ma la crisi dell’industria tessile determinò la fine della Camera del lavoro di Vaiano, che, per il calo degli iscritti, fu costretta a cessare la sua attività nel giro di pochi anni. Il permesso per l’apertura della sala cinematografica nel nuovo politeama non venne concesso per ragioni politiche, ed il locale dovette essere venduto: si riaffacciò così l’esigenza di edificare una Casa del popolo.
Ma il momento non era propizio perché proprio in quegli anni il governo Scelba-Saragat (ribattezzato “governo SS” dai lavoratori) scatenò la sua offensiva contro le Case del popolo, decidendo, nel 1954, di recuperare allo stato tutti i beni che erano appartenuti al disciolto Partito nazionale fascista ed assestando, in tal modo, un duro colpo al movimento circolistico (nella sola provincia di Firenze, fra il 1953 ed il 1955, furono chiuse ben ventitré Case del popolo).
Nel corso degli anni Sessanta, col venire meno dello scelbismo e con l’avviarsi verso un risultato positivo della lenta gestazione del centrosinistra, il quadro politico si fece meno sfavorevole, mentre si rafforzava la coscienza che le case del popolo dovevano essere sempre più delle strutture capaci di coinvolgere ampi strati sociali e classi di età diversa. Per altro verso, l’aumento del reddito e dei consumi, il moltiplicarsi degli apparecchi radiotelevisivi ed il diffondersi della motorizzazione spinsero la gente verso nuove forme di utilizzazione del tempo libero, determinando una seria crisi delle case del popolo.
Ebbero quindi del coraggio i sette compagni che il 24 febbraio 1961, con rogito del notaio Ugolino Golini di Firenze, costituirono l’Associazione civile Casa del popolo di Vaiano. Ricordiamone i nomi: Natale Consorti, Dino Lilli, Giorgio Oliviero Meucci, Severino Morganti, Mauro Risaliti, Giuseppe Santi e Pietro Sizzi.
L’Associazione acquistò l’immobile del vecchio teatro Gustavo Modena, per costruire, sull’area da esso occupata, la nuova Casa del popolo, ma, prima che cominciassero i lavori, dovettero passare sette anni, durante i quali vennero esaminati vari progetti, tenendo conto della realtà di Vaiano e delle capacità economiche dell’Associazione stessa.
A dare la spinta necessaria alla realizzazione dell’opera fu l’avanzata del Partito comunista alle politiche del 1968 (+1,65% alla Camera), insieme con l’esplodere della contestazione studentesca e col riaccendersi delle lotte operaie, che, in tutta Italia, determinarono un rilancio delle case del popolo.
Verso la metà di luglio del 1968 l’impresa edile Carlo Fiaschi iniziò i lavori sulla base di un progetto fatto dal geometra Alberto Pastacaldi (la direzione tecnica dei lavori venne in seguito affidata all’architetto Vinicio Brilli ed all’ingegner Umberto Fiaschi).
L’inaugurazione della nuova sede ebbe luogo domenica 20 settembre 1970, centesimo anniversario della breccia di Porta Pia.
L’apertura dei nuovi locali ha permesso alla Casa del popolo di esplicare un’attività rilevante, alla quale hanno dato un valido contributo i giovani entrati a far parte dell’associazione. Molteplici sono state le iniziative, sia ricreative sia culturali, e costante è stato l’impegno in difesa delle libertà democratiche (giova sottolineare che la Casa del popolo ha rappresentato un punto di riferimento per gli alpini inviati a sorvegliare la Direttissima durante la tragica stagione degli attentati ferroviari degli anni Settanta-Ottanta).
Ed anche oggi la Casa del popolo gode di buona salute e continua a svolgere una funzione davvero preziosa, permettendo ai lavoratori di socializzare, di ricrearsi e di allargare i propri orizzonti culturali.