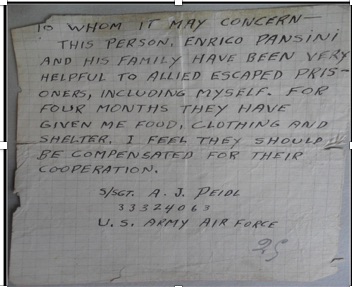Mazzino Chiesa, un uomo in mare

«Il bacino occidentale del Mediterraneo può venire considerato nel suo complesso come un unico mercato del lavoro per l’emigrazione italiana, nonostante le diverse condizioni, sia giuridiche, sia economiche dei paesi che ne fanno parte»: così scriveva il Commissariato generale dell’emigrazione nel 1926, riportando la stretta connessione e circolarità esistente tra le diverse sponde del Mediterraneo, in cui si venivano a intrecciare antichi insediamenti italofoni legati al commercio e alle professioni liberali, con nuovi flussi dell’emigrazione da lavoro attratti dagli interventi infrastrutturali, dalle attività portuali o minerarie, oltre che dai più tradizionali mestieri agricoli o servizi urbani. Alla metà degli anni ’20 si può stimare un totale di 550.000 persone di nazionalità italiana che vivevano stabilmente nei territori bagnati dal mar Mediterraneo e che intrattenevano con il paese di origine rapporti più o meno fitti e continui. Si trattava con ogni probabilità della più numerosa nazionalità in emigrazione nell’intero arco mediterraneo, considerando le minori dimensioni demografiche di Grecia e Malta, altri paesi con un’importante diaspora marittima.
Così come era successo con l’emigrazione politica degli esuli risorgimentali, lo spazio mediterraneo tornò a essere durante il periodo fascista un luogo di rifugio per gli emigrati politici avversati dal potere in Italia: gli antifascisti trovarono nei porti del “mare di mezzo” una risorsa molto importante per sfuggire alle maglie della repressione fascista e allo stesso tempo poter continuare a tenere rapporti con la società italiana.
L’intricato campo di relazioni dei sovversivi antifascisti che univa le coste del Mediterraneo si basava sulla presenza stabile delle comunità italiane all’estero, ma aveva poi bisogno di vettori e persone mobili che facessero da tramite. È il caso di Mazzino Chiesa, nato nel 1908 in un quartiere popolare di Livorno. La sua storia è strettamente legata al mare e al partito comunista: di madre valdese e di indole anarchica, fu attivo politicamente sin da giovane in un comitato sindacale comunista. Possiamo ricostruire la sua vicenda a partire dal fascicolo personale conservato nei faldoni della Polizia politica presso l’Archivio Centrale dello Stato e dall’intervista che gli fece Iolanda Catanorchi nel 1974, disponibile online.
 A 17 anni si imbarcò per un trasporto oltreoceano, senza avere però l’accortezza di passare ai compagni le consegne delle sue attività politiche. Commise così una grave imprudenza: «avevo del materiale del soccorso rosso e dei soldi in casa e sono partito […] imbarcai a bordo di questo vapore […] partimmo e io nel partire siccome avevo lasciato tutto il materiale a casa e non avevo avuto il tempo di fare… […] scrissi una lettera a mia madre, scrissi: “cara mamma dietro al quadro trovi il materiale, dallo a Gino”». La lettera fu intercettata dalla polizia, che a distanza seguì gli spostamenti del vapore fino al suo rientro. «Ritornando da Montereale [Montreal, n.d.a.], dal Canada, avevamo caricato del grano, quando arrivammo nel porto di Napoli, fuora, nel golfo di Napoli, vedemmo dei motoscafi della milizia che circondavano il vapore, difatti diedero ordine al comandante di dar fondo fuora. Quando fummo fermi ci invitarono tutti al centro…». Non ancora maggiorenne Chiesa venne arrestato per la prima volta e portato al carcere minorile di Napoli, quindi a Regina Coeli e poi a Livorno.
A 17 anni si imbarcò per un trasporto oltreoceano, senza avere però l’accortezza di passare ai compagni le consegne delle sue attività politiche. Commise così una grave imprudenza: «avevo del materiale del soccorso rosso e dei soldi in casa e sono partito […] imbarcai a bordo di questo vapore […] partimmo e io nel partire siccome avevo lasciato tutto il materiale a casa e non avevo avuto il tempo di fare… […] scrissi una lettera a mia madre, scrissi: “cara mamma dietro al quadro trovi il materiale, dallo a Gino”». La lettera fu intercettata dalla polizia, che a distanza seguì gli spostamenti del vapore fino al suo rientro. «Ritornando da Montereale [Montreal, n.d.a.], dal Canada, avevamo caricato del grano, quando arrivammo nel porto di Napoli, fuora, nel golfo di Napoli, vedemmo dei motoscafi della milizia che circondavano il vapore, difatti diedero ordine al comandante di dar fondo fuora. Quando fummo fermi ci invitarono tutti al centro…». Non ancora maggiorenne Chiesa venne arrestato per la prima volta e portato al carcere minorile di Napoli, quindi a Regina Coeli e poi a Livorno.
Da allora fu costantemente sorvegliato dalle forze dell’ordine. Nel 1931 Chiesa venne a sapere che era stato spiccato un mandato di cattura e decise di partire per la Corsica insieme ad altri quattro ricercati, con una barca comprata per l’occasione. «Quasi tutta a remi ce la siamo fatta, 42 ore ci abbiamo messo, siamo stati più bischeri noi, perché non c’era vento, non abbiamo trovato…». Stabilitosi a Bastia con altri fuoriusciti comunisti, si fece notare per la vivace propaganda antifascista. Nel novembre 1931 venne arrestato per aver picchiato a sangue Vasco Patania, un altro livornese venuto a Bastia insieme a un commerciante di stoffe, ritenuto un agente dell’Ovra. Nonostante la gravità delle percosse (in seguito alle quali Patania morì in un sanatorio a Livorno) il processo si concluse con una lieve condanna, un mese di prigione che Chiesa aveva già scontato, come riferiva alla polizia italiana un’informativa anonima:
Il Chiesa è così uscito glorioso e trionfante, accolto dai compagnoni suoi, fra gli applausi generali. […] l’avv. Moretti di cui già altra volta abbiamo parlato per il suo antifascismo […] fra gli unanimi applausi sostenne invece che il Chiesa è un perseguitato politico dovuto fuggire dalla sua patria perché odiato dal Fascismo […]. Il processo è emerso [sic] una requisitoria antifascista che ha fatto andare in sollucchero i fuoriusciti che in gran numero si erano dati convegno nell’aula e nelle adiacenze del Tribunale. Il Chiesa Mazzino non appena uscito è tornato alla carica ed alla sera stessa ha tenuto una concione antifascista sulla banchina del Porto (malgrado il freddo) e dinanzi agli operai della “Impresa Vestrini” ha parlato ancora delle necessità di naturalizzarsi francesi per evitare di tornare in Italia a morir di fame sotto la sferza del fascismo. I soliti canti antifascisti hanno posto termine alla gazzarra senza che la polizia intervenisse.
Partì quindi verso Marsiglia e si recò a Parigi. Qui prese contatto con i vertici del Partito comunista d’Italia (Pcd’I) in esilio: lavorò dapprima per il Soccorso rosso, poi insieme a Giuseppe Di Vittorio iniziò a occuparsi dell’organizzazione della propaganda presso i lavoratori dei porti. Dopo aver partecipato con lo stesso Di Vittorio a un congresso internazionale dei portuali ad Altona, vicino ad Amburgo, entrò ufficialmente nell’organizzazione sindacale per conto del partito.
Alla fine del 1932 i servizi informativi fascisti lo individuavano come «un rappresentante della federazione italiana dei lavoratori del mare» (Film), inviato dal comitato centrale del Pcd’i a Marsiglia «allo scopo di tentare di organizzare in detta associazione i marittimi delle navi mercantili italiane che toccano quel porto»: «costui frequenta spesso il Club dei marittimi di Marsiglia, cercando di avvicinare connazionali ai quali distribuisce stampa del partito e tessere». Prese contatto tra gli altri con gli ambienti dei portuali di Genova, Livorno, Savona, Napoli: «andavo nei porti, creavo i comitati di diffusione e stampa, e poi attraverso questi prendevamo contatti con i marinari e dovevamo andare molte volte negli ambienti equivoci, molte volte passavamo per magnacci, altre volte passavamo per contrabbandieri, altre volte… perché i marinari si trovano lì, non si trovano…».
Come ha ricostruito Paolo Spriano, nella storia ufficiale del Partito comunista, «in questo periodo [tra 1933 e 1934] una buona parte della propaganda clandestina comunista che riesce a penetrare nel Regno ha come veicolo i marittimi, e la polizia aumenta la sua sorveglianza sugli equipaggi». Per poter svolgere questa attività e sfuggire al controllo poliziesco, Chiesa assunse differenti identità, in un gioco di dissimulazione che gli apparati di sicurezza italiani stentavano a seguire: Mario Landrelli, Mario Sandrelli, Assante Puntoni, Luigi Lenzi, Mario Luschi, Mario Lucchi, André Bernard, Masianello, Silverio, Masini, Alfredo o Alfredone, Ernest Morioli, Ernst Boschi, Roque Celeste Amado sono alcuni dei nomi utilizzati, il più delle volte con la copertura di un documento falsificato. Nel marzo 1933 da Parigi un informatore della polizia politica riferiva gli estremi della carta d’identità francese di un certo Alfredo Ferrari, nella convinzione che si trattasse in realtà della copertura fittizia per un’altra persona, Luigi Lenzi. Non sospettava che la vera identità dell’uomo che stava seguendo era ancora un’altra, quella di Mazzino Chiesa.
Alcune missioni di cui venne incaricato dal partito appaiono particolarmente rischiose. Ad Algeri ebbe il compito di avvicinare i membri italiani della flotta navale, creare delle cellule comuniste a bordo e trovare un marinaio disposto a disertare per recarsi a un congresso ad Amsterdam, per poi andare a vivere in Russia. «Mi hanno dato una valigia a doppio fondo, con già il materiale, i clichet pronti, tutto il materiale, il passaporto svizzero, mi chiamavo Morioli Ernest». Riuscì nell’intento e tornò a Marsiglia con un disertore comunista. Sempre in Algeria, ma a Bona, fu ancora inviato per fare proselitismo tra gli italiani che caricavano i fosfati e i concimi chimici sui vapori.
Nonostante tutti questi spostamenti, il centro del suo peregrinare per i porti mediterranei rimaneva Marsiglia, dove teneva le fila dell’organizzazione dei marittimi. «Ero più utile io in questo lavoro…», dichiarò con orgoglio alla metà degli anni settanta. La guerra di Spagna segnò una cesura in questa sua attività. Si recò una prima volta come volontario insieme al fratello nelle formazioni di Giustizia e libertà, nella colonna Rosselli. Venne quindi severamente rimproverato dal partito che lo rispedì a Marsiglia a riprendere il lavoro con la Film, fortemente indebolita dalla sua partenza improvvisa. Qui però continuò a pensare alla Spagna: «è anche latore – segnalavano gli informatori fascisti – presso alcune personalità ed organizzazioni, di richieste di materiale bellico e di uomini». Riuscì a ripartire per il fronte spagnolo, per poi finire all’inizio del 1939 nel campo di concentramento di Argelès-sur-Mer. Dopo un breve periodo scappò e fece ritorno a Marsiglia, dove la polizia francese lo stava aspettando per trarlo in arresto. Riuscì a imbarcarsi clandestinamente su un vapore diretto a Tunisi. Qui trovò Giorgio Amendola e Velio Spano e fu introdotto nel gruppo degli italiani comunisti locali.
Attualmente è ospite di un giudeo che abita nella Avenue Jean Jures [sic] n. 59. Il controscritto – appena giunto – si mise subito in contatto con gli altri compagni di fede, ai quali rimprovera la mancata energia e la mancata attività di mettere in esecuzione il programma rivoluzionario e dinamitardo anarchico. Sembra – ma non lo si può affermare con prove specifiche – che il Chiesa avrebbe preso parte alla spedizione punitiva eseguita recentemente contro la sede del Dopolavoro del circolo rionale Bab El Kadra di Tunisi.
Nel corso del Ventennio, la vicinanza geografica tra le sponde del Mediterraneo e l’eredità storica delle circolazioni che avevano avuto luogo all’interno del bacino crearono delle condizioni favorevoli per gli antifascisti: di fronte alla situazione oppressiva che il regime fascista aveva instaurato all’interno della penisola e su cui imponeva in maniera sempre più dura i suoi apparati di controllo, il mare rappresentò una risorsa fondamentale per gli oppositori. Le vie acquatiche potevano portare con facilità in ambienti non sottoposti al codice penale fascista né alla sovranità della sua polizia, ma pur sempre familiari, grazie alla presenza delle comunità italiane e alla larga diffusione della lingua italiana nell’arco mediterraneo. La zelante attività di informatori e consoli non mancò di estendere la rete di controllo anche fuori dai confini, ma pur sempre sotto ordinamenti giuridici e statuali differenti da quelli dominati dal fascismo. In questa situazione si mossero persone e organizzazioni con una competenza specifica nel fare propaganda presso i portuali e la gente di mare. La ricostruzione dei loro percorsi e dei network su cui si muovevano è di grande interesse per un’analisi della centralità della dimensione mediterranea come spazio storico e geografico di libertà e democrazia.