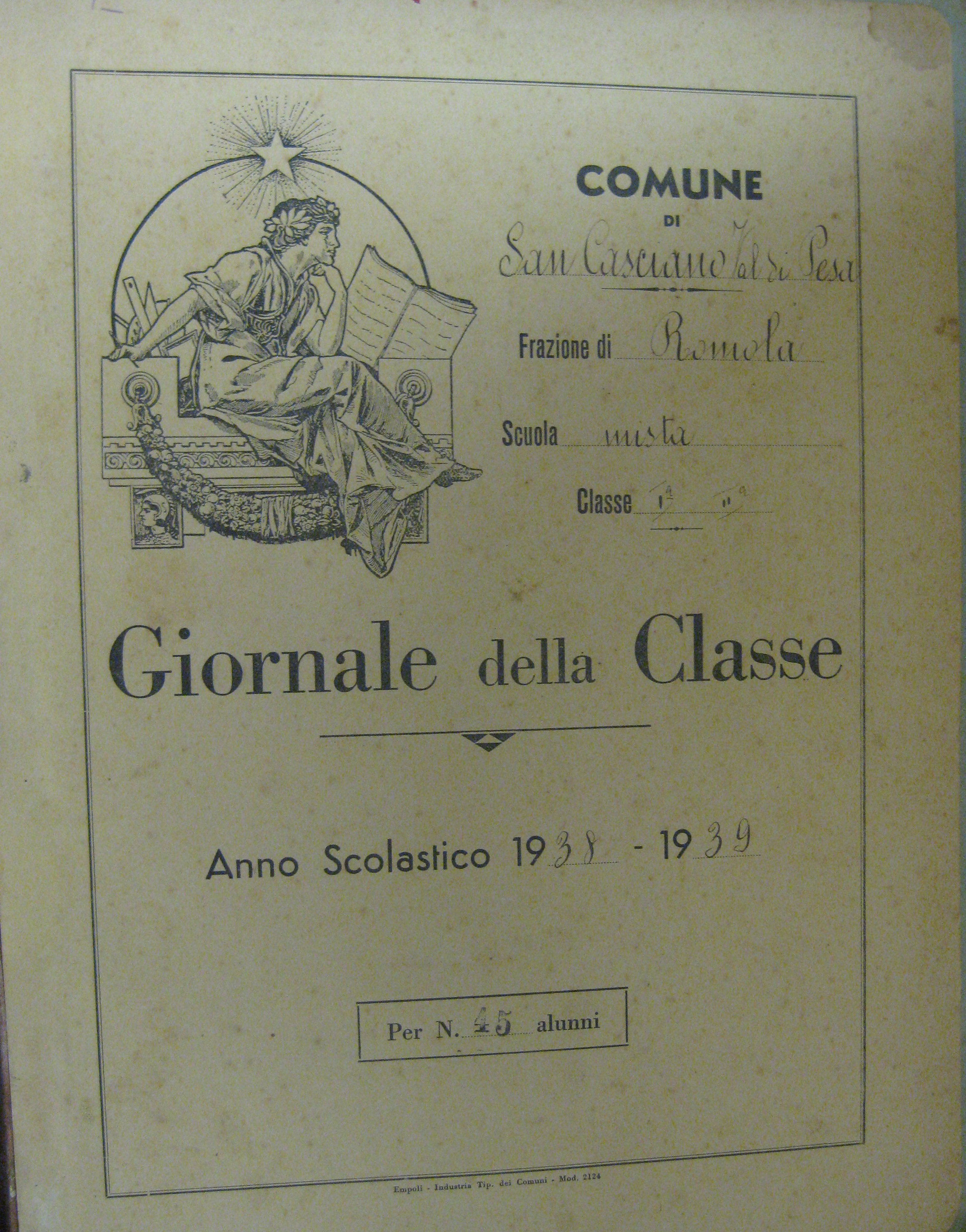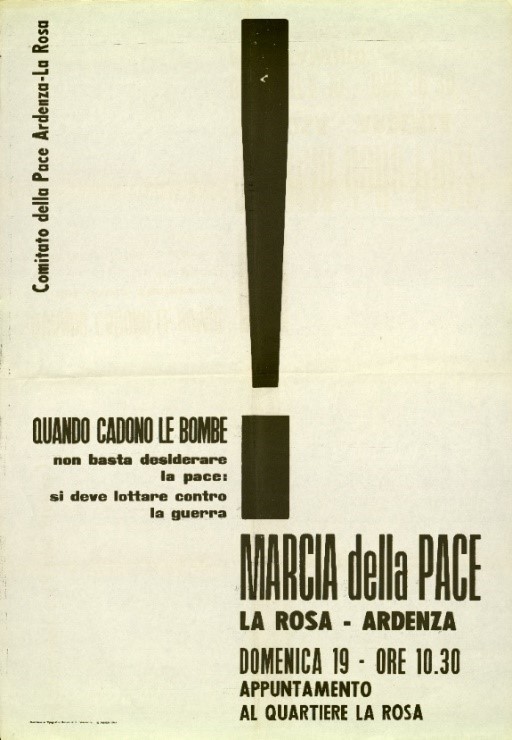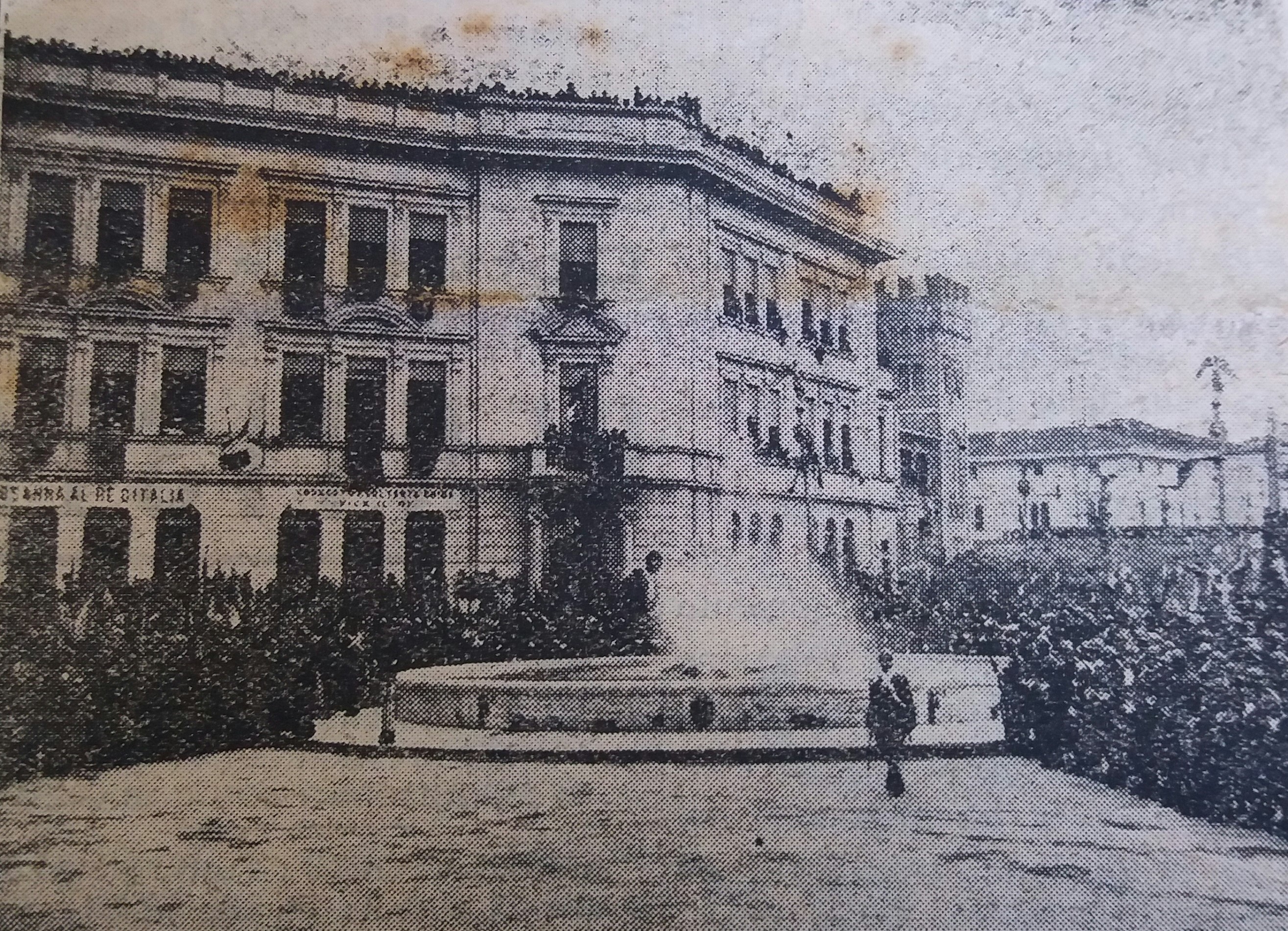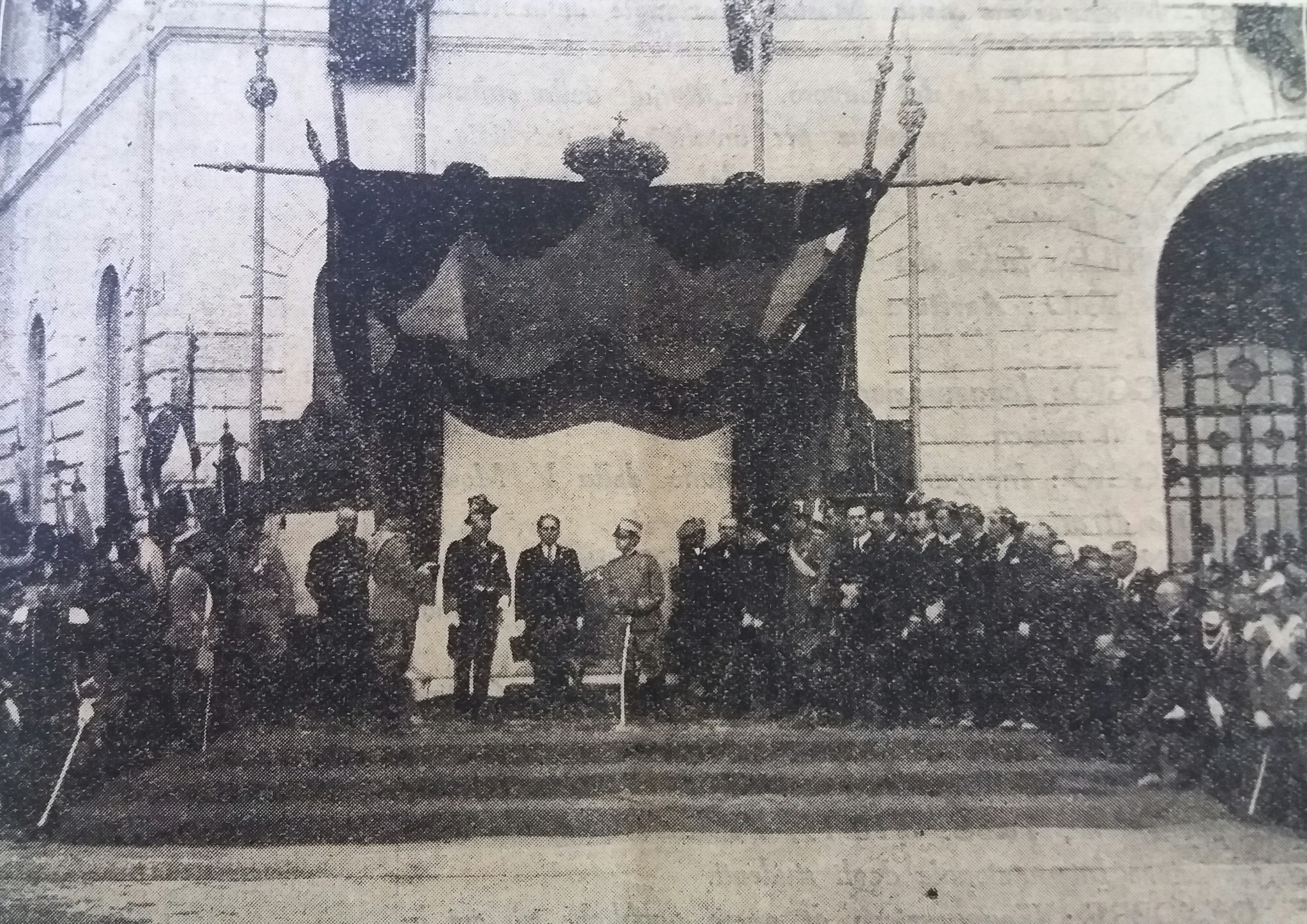I documenti custoditi negli archivi delle scuole sono una fonte per la ricerca storica e la ricostruzione di vicende collettive esposte da un osservatorio particolare. In particolare i Giornali di Classe delle scuole elementari riportano sia notizie quotidiane della vita della scuola e della classe che informazioni su avvenimenti importanti culturali e politici, descritti e commentati dagli insegnanti. La sezione cronaca e osservazioni dell’insegnante sulla vita della scuola è redatta dai singoli docenti spesso con cadenza settimanale, alle volte anche giornaliera. L’insegnante generalmente registra i fatti più importanti, l’adunanza e l’inaugurazione dell’anno scolastico, le disposizioni del dirigente scolastico che a sua volta ricalca le circolari del provveditore agli studi, le visite delle autorità scolastiche, le ricorrenze civili e religiose, le feste scolastiche, gli scrutini e la chiusura dell’anno scolastico. Nella relazione finale dell’insegnante si trovano osservazioni sulla scuola, sull’edificio scolastico e l’aula, l’arredamento e i sussidi didattici, sulla biblioteca di classe e la mutualità scolastica, sulla frequenza degli alunni nei vari mesi scolastici e lo stato dei tesseramenti alle Organizzazioni Giovanili.
La presente ricerca ha preso in esame i Giornali di Classe delle scuole elementari del Comune di San Casciano in Val di Pesa dall’anno scolastico 1929/1930 fino all’anno scolastico 1944/1945. L’analisi fornisce sia alcuni elementi di quotidianità scolastica degli anni della dittatura fascista, utili a comprendere il grado e la modalità di fascistizzazione delle istituzioni scolastiche che a ricostruire il periodo della guerra e i tragici eventi conseguenti al passaggio del fronte tra la Val di Pesa e la Val d’Elsa . Le cronache degli insegnanti a partire dal 1940 diventano difatti una cronaca delle vicende della guerra.
Nelle cronache sono riportate un numero impressionante di giornate commemorative dedicate al regime che si svolgevano nell’orario scolastico a discapito dell’attività didattica. Gran parte delle lezioni poi erano dedicate all’indottrinamento e all’istruzione fascista. Come annota una maestra di Cerbaia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 1928/29, gli insegnanti avevano la nobilissima missione di modellare l’animo del popolo italiano secondo lo stile, il costume, la dottrina e la religione fascista. [Giornale della Classe, III e IV, La Romola, Anno scolastico 1928/29]. La maestra aggiunge che la formazione dei piccoli Balilla, ordinata dal signor Podestà, mi ha tenuta onoratissima per l’opera di propaganda verso le famiglie dei miei alunni, le ore di lezione di oggi sono occupate nel preparare e completare la divisa che sarà indossata stasera dai nostri Balilla, invitati ad una riunione nel capoluogo. [Giornale della Classe, II e IV, Cerbaia, Anno scolastico 1928/29]. Nel novembre del 1927 anche le Piccole Italiane e Giovani Italiane passarono sotto l’Opera Nazionale Balilla, cosi la maestra di Cerbaia: mi sono recata a San Casciano dalla signora segretaria politica del Fascio femminile per intenderci circa la formazione delle Piccole e Giovani Italiane: per le quali alacremente lavoro data l’importanza patriottica di questa nobile istituzione. [Giornale della Classe, II e IV, Cerbaia, Anno scolastico 1928/29]. Le feste e le celebrazioni del Pane e del Fiore e simili, erano tutte occasione di raccolta di fondi e molte furono legate alla particolarità del momento bellico:
…Fino da ieri ho cominciato la vendita dei panini, Pro Oriente, oggi 2° Celebrazione del Pane, dopo aver spiegato agli alunni l’alto significato di questa nobile Festa[…]stamani insieme alla mia Collega ho proseguito la vendita dei panini e abbiamo incassato, in breve tempo la somma di 100 lire…. [Giornale della Classe, II e IV, Cerbaia, Anno scolastico 1928/29]
Il processo di indottrinamento e disciplinamento paramilitare nelle scuole, inteso a formare i futuri soldati, subì un’intensificazione con l’invasione dell’Etiopia nell’ottobre 1935. Le “inique sanzioni” che furono applicate all’Italia conseguentemente all’invasione divennero argomento di lezione anche nelle scuole elementari. La data del 18 novembre venne da allora annotata sulla cronaca come Anniversario delle Sanzioni. L’altra iniziativa di cui si fece carico la scuola fu la raccolta di metalli, carta e stoffe e il dono della fede nuziale (Oro alla Patria) quale contributo degli italiani alla guerra in Africa. Anche la scuola doveva applicare un sistema di rigida economia. Le circolari bandivano l’uso della doppia copia dei documenti e ordinavano la riduzione del consumo di energia elettrica. Il paese si preparava alla guerra anche attraverso la scuola con la consapevolezza che i piccoli italiani forti e coraggiosi, sono i valorosi soldati di domani. [Giornale della Classe, III e IV, La Romola, Anno scolastico 1935/36]. Una circolare del 30 maggio 1935 esortava l’acquisto della radio per le classi delle scuole del Comune. L’8 marzo del 1938 un comunicato del Provveditorato agli Studi di Firenze esprime, a nome del Ministero dell’Educazione Nazionale, «il compiacimento per il continuo incremento della radifonia scolastica» [Cir. 2238, 8 marzo 1938]. Così tra il 1938 e il 1939 anche nelle scuole del Comune di San Casciano si ebbe l’apparecchio radio per «educare fin dalla più tenera infanzia secondo i dettami della dottrina fascista, completare e illustrare le lezioni impartite dagli insegnanti…».
Dall’anno scolastico 1940-41 gli insegnanti avevano il compito di leggere quotidianamente i bollettini di guerra agli alunni ed esaltarne gli eventi favorevoli al Regime. Il maestro della Romola scrive che i suoi alunni non si stancherebbero mai, in particolare i ragazzi di quinta di sentire parlare della guerra. Dopo la lettura del bollettino quante domande!…noi la chiamiamo la “storia viva”, il parlare dei nostri soldati e della guerra. [Giornale della Classe, III e IV, La Romola, Anno scolastico 1940/41]. Il regime attraverso la scuola cercava di mantenere il consenso che stava progressivamente venendo meno con il procedere del conflitto. Gli stessi alunni, nell’inverno del 40-41, sono mobilitati per la guerra:
E’ un momento in cui si lavora intensamente. Anche materialmente si lavora, specialmente le femmine a confezionare maglieria per i soldati. Abbiamo raccolto 70 lire. Dividiamo gli indumenti i due pacchi e li spediamo a due soldati del popolo della Romola che si trovano attualmente in Albania. [Giornale della Classe, III e IV, La Romola, Anno scolastico 1940/41]

Notizie statistiche della scuola elementare mista di Romola (S. Cascano V.P) – Anno scolastico 1938-39
L’anno scolastico 1940-41 termina in anticipo, il 24 maggio. All’inizio del 1942 la situazione in Italia era catastrofica. Iniziarono la penuria di risorse e le requisizioni da parte del regime. Nell’autunno 1942 tra i militari sancascianesi si contavano 70 prigionieri di guerra, 20 feriti, 7 dispersi, 31 morti. Nel biennio scolastico 1942-1943/ 43-44 nelle cronache degli insegnanti, la propaganda di guerra, i riti e le celebrazioni del regime lasciano spazio progressivamente alle preoccupazioni, ai timori suscitati dalla guerra, e al racconto tragico dei bombardamenti. L’orario di lezione venne ridotto, le chiusure delle scuole anticipate e l’ inizio posticipato. L’attività didattica diventava quasi impossibile, numerose sono le annotazioni degli insegnanti sui programmi non conclusi. Nelle classi si aggiungono i bambini sfollati dalle città bombardate:
Questa mattina, accompagnata dalla mamma, si presenta una bimba da Grosseto. E’ sinistrata nel bombardamento dell’aprile scorso: il padre e lo zio periti nel bombardamento, la casa crollata e, tutto, disperso. Ascolto, con emozione, il lugubre racconto di questa terribile tragedia e mi associo al dolore di queste creature… [Giornale della Classe, V, San Casciano; Anno scolastico 1943/44].
Le incursioni aeree impressionano e sconvolgono la quotidianità della val di Pesa già dalla fine del 1942. Con l’anno scolastico 1943-44 la guerra arriva tra i banchi della scuola, tra gennaio e giugno 1944 vi sono 6 incursioni aeree da parte di bombardieri medi e pesanti:
I continui allarmi disturbano l’andamento delle lezioni. Quando gli alunni odono la sirena diventano irrequieti, vogliono le mamme, ed i più piccini tremano e si mettono a piangere. Proprio oggi, un bombardamento molto vicino ha fatto tintinnare paurosamente tutti i vetri. Subito le mamme son corse a prendere i loro piccini. Tutti i giorni è cosi! [Giornale della Classe, II e IV, La Romola, Anno scolastico 1943/44]
Gli effetti dei bombardamenti sul territorio regionale si hanno anche nel Comune di San Casciano:
Oggi poi è stata una giornata nera. Gli apparecchi hanno cominciato a passare alle 10.30 e quando ho visto che si dirigevano verso Firenze ho sentito il cuore farsi piccino per il pensiero di tutti ma soprattutto dei miei. Il bombardamento è stato visibile perché contemporaneamente a quello su Firenze c’è stato quello su Poggibonsi e la terra tremava talmente forte che sembrava dovesse aprissi da un momento all’altro. [Giornale della Classe, I, II e III, Bargino, Anno scolastico 1943/44].
Annota anche la maestra di Mercatale:
I vetri e il pavimento della classe tremavano al boato delle bombe, nella piazza era un gridio, un fuggi fuggi. Tutti correvano senza sapere dove rifugiarsi…[Giornale della Classe III e IV, Mercatale, Anno scolastico 1943/44].
L’episodio del duello aereo nel gennaio 1944 e l’abbattimento di un aereo inglese presso San Pancrazio viene descritto nelle cronache degli insegnanti come il primo episodio di guerra osservato dalla popolazione di questa contrada:
Nelle prime ore di pomeriggio di ieri avvenne un duello aereo nei nostri cieli. Ebbero la peggio alcuni apparecchi tedeschi che precipitarono poco lontano da noi. Uno di esse colpito da una raffica di mitragliatrice lasciò cadere, giù nei nostri campi, il serbatoio della benzina e altri oggetti pesanti, che li per li, nel primo momento, parevano proprio delle bombe.[Giornale della Classe I e II, Mercatale, Anno scolastico 1943/44].
Per misure precauzionali da gennaio l’orario delle lezioni venne ridotto dalle 8,30 alle 11. La situazione è sempre più allarmante. Il 29 aprile fu l’ultimo giorno di lezione. Il 27 luglio gli alleati liberarono San Casciano e l’11 agosto il Cln toscano dette l’ordine di insurrezione generale e assunse il governo del capoluogo fiorentino. Fu l’inizio di una lunga battaglia che ebbe termine il 1 settembre con la liberazione di Firenze. Il 2 agosto venne nominata la Giunta provvisoria a San Casciano. Secondo un indagine del novembre 1944, nel Comune chiantigiano erano 202 le famiglie che avevano la casa distrutta, per un totale di 684 persone. Gli sfollati provenienti dagli altri comuni erano 279 famiglie, per un totale di 1412 persone.

Le rovine di San Casciano dopo il passaggio del fronte (Archivio Associazione “La Porticciola”)
Le scuole, a causa delle distruzioni provocate dal passaggio del Fronte, riapriranno solo tra dicembre e febbraio:
Le scuole al Capoluogo si sono riaperte. Non più gli ampi locali dai grandi finestroni, ma le aule strette e anguste che erano prima quelle addette al giardino di infanzia. Purtroppo il piccolo mondo adolescente viene accolto in queste aule con poca luce meno aria. Ma siamo in tempo di guerra e dobbiamo adattarci. I bambini sono felici di aver ripreso le loro lezioni, le insegnanti pure. Io mi trovo assai bene con una classe seconda che mi è stata affidata dal Signor Direttore. È una classe seconda, composta dagli alunni delle due prime, sono in tutto 33 alunni. Li guardo e purtroppo hanno ancora negli occhi il terrore della guerra che passando dal paese e dalle ridenti campagne ha distrutto le loro case, sentono ancora il rombo del cannone e lo scoppio della mina e mi guardano come istupiditi. No, cari piccoli passeremo insieme, quest’anno e nel lavoro e nell’amore reciproco dimenticheremo gli spaventi passati. [Giornale della Classe I e II, Bargino, Anno scolastico 1944/45].
Nella relazione finale di una maestra della scuola di San Casciano si raccontano le conseguenze del bombardamento del 26 luglio e l’anno difficile appena trascorso:
Causa il tremendo bombardamento avvenuto su questo povero Capoluogo, le scuole ebbero un sinistro tremendo. Scoperchiate, diroccate, non erano più in grado di contenere un alunno. Furono accomodati alla meglio i locali che servivano per i bambini del Giardino infantile ed in esse, alternativamente, gli insegnanti hanno svolto la loro attività. Benché i locali fossero ristretti, bui e privi di luce (mancavano i vetri e furono sostituiti con carta cerata) pure gli alunni hanno frequentato regolarmente la scuola.[Giornale della Classe II, San Casciano, Anno scolastico 1944/45].
Euforia all’indomani della resa della Germania viene espressa dagli insegnati insieme alla consapevolezza degli anni ancora difficili che il paese si troverà ad affrontare :
Grazie, grazie, grazie! Grande entusiasmo, il conflitto mondiale che da quasi sei anni imprigiona i popoli dell’Europa ha avuto termine. La Germania vinta ha deposto le armi e chiede l’armistizio incondizionato agli Alleati e alla Russia. Finisce un momento storico! Ne incomincia un altro. Finita la distruzione, incomincia un periodo di ricostruzione… [Giornale della Classe I e II, San Casciano, Anno scolastico 1944/45].
* Sara Gremoli è laureata in Storia contemporanea presso l’università di Firenze e presidente dell’associazione culturale Sgabuzzini Storici, con sede a San Casciano in val di Pesa. L’associazione si occupa di promozione culturale e organizzazione di eventi. In particolare promuove la valorizzazione del patrimonio documentale e la diffusione della memoria storico-culturale del Chianti attraverso l’organizzazione di conferenze, mostre, letture e spettacoli teatrali in collaborazione con le associazioni del territorio.