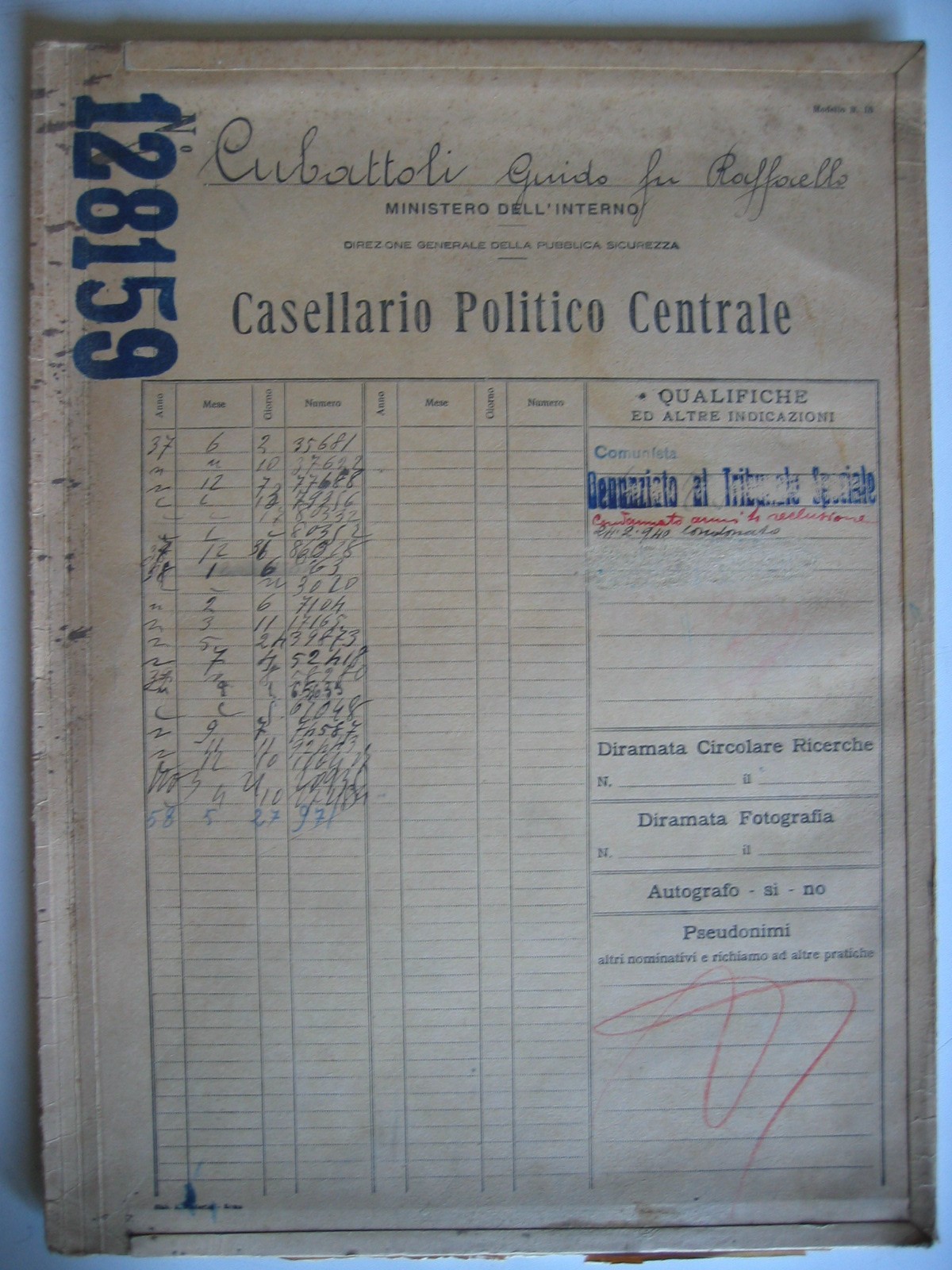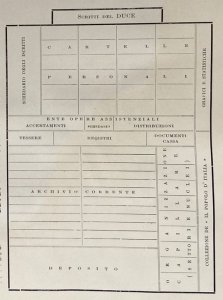Quando le ordinanze di sfollamento colpirono la Versilia, nell’estate del 1944, le condizioni di vita della popolazione civile subirono un brusco peggioramento.
Fin dall’autunno del ’43, le autorità della RSI, desiderose di ricostituire un forte esercito nazionale, avevano avviato coscrizioni sempre più «totalitarie»: questa minaccia, sommata a quella imprevedibile dei rastrellamenti nazisti, consigliava ai maschi in età di leva di rimanere il più possibile nascosti, senza dare nell’occhio. Così, mentre per gli uomini le possibilità di movimento si restringevano ogni giorno di più, le donne, oltre a svolgere gli incarichi loro affidati dalla “tradizione”, dovettero accollarsi tutta una serie di incombenze nuove e gravose, solitamente “di competenza” maschile, come il rapporto con le autorità, il procacciamento del cibo e la difesa della famiglia in situazioni di pericolo.
Nonostante le ordinanze nazifasciste, che prevedevano l’evacuazione delle popolazioni civili verso l’Emilia, i versiliesi erano ben determinati a non abbandonare le proprie terre, per ragioni sia pratiche che affettive: correndo i rischi più gravi, cercarono rifugio nei recessi più remoti delle Apuane, presso amici, parenti, più spesso in alloggi di fortuna.
Nel corso dell’estate del ’44, con l’economia paralizzata e gli esercizi commerciali chiusi, abolite anche le già scarse razioni delle tessere annonarie di Mussolini, il problema alimentare si fece ogni giorno più pressante, fino a trasformarsi nel principale incubo degli sfollati. Ancora una volta, sfidando i gendarmi tedeschi e gli aerei alleati, spesso percorrendo a piedi distanze impensabili – giunsero perfino in Garfagnana e nel Parmense -, furono le donne ad effettuare frequenti ritorni alle proprietà abbandonate, tentando di reperire quel poco di frutta o verdura per i figli e i mariti lasciati in montagna, sempre che la fame dei soldati nazisti, dei partigiani, o, più di frequente, di altri sfollati nelle medesime condizioni, avesse risparmiato qualcosa.
Così per esempio fu per la famiglia di Mariella Barsottini, che nel 1944 aveva sette anni. Assieme ai genitori e al fratello più grande, Mario, abitava nel paesino di Strettoia, nel comune di Pietrasanta (Lu), un borgo agricolo posto proprio a ridosso delle alture dominanti la piana versiliese, in un’area di grande rilevanza strategica per i piani di fortificazione militare dell’Orgnizzazione Todt. Quando furono raggiunti dall’ordine di evacuazione, i Barsottini scelsero di dirigersi verso sud, per «andare incontro agli americani». Dopo una breve sosta nel paese di Valdicastello (Pietrasanta, Lu), in quei giorni vero e proprio crocevia per tutti gli sfollati versiliesi, la famiglia decise di seguire il consiglio di diversi compaesani e di puntare su Marina di Pisa (Pi), considerata una cittadina sufficientemente lontana dai pericoli della Linea Gotica. Nelle settimane successive, nonostante la grande distanza dal paese d’origine, la madre di Mariella, Rina, donna coraggiosa e intraprendente, pur di riuscire a recuperare qualcosa da mangiare per figli e marito, non esitò a tornare periodicamente ai propri terreni, sfidando i posti di blocco e correndo i mille pericoli del passaggio del fronte.
Ecco come Mariella rievoca oggi il ruolo delle donne nei duri mesi dello sfollamento:
Una cosa bella che facevano le donne, perché per gli uomini era troppo pericoloso, era quella di cercar di ritornare a Strettoia per prendere qualcosa da mangiare, perché là avevano lasciato tante cose, tutto! E allora, c’era chi cercava di riprendere la patata, chi recuperava il vino, l’olio, però, sempre col rischio di essere ammazzati. Anche la mia mamma lo fece, da Marina di Pisa. Due volte.
 Nei lunghi mesi dello sfollamento, poi, particolarmente complesso si rivelò il procacciamento del sale, genere indispensabile alla dieta, divenuto introvabile sul mercato già dalla primavera del ’44: agli sfollati versiliesi, non rimase altra scelta che ricavarlo dall’acqua di mare. In vista dell’avanzata alleata, tuttavia, l’Organizzazione Todt aveva provveduto a minare l’intera fascia costiera versiliese, lasciando sgombero dagli ordigni soltanto un unico, stretto corridoio di spiaggia presso la foce del fiume Versilia, vicino alle fortificazioni del Cinquale. Data la rilevanza strategica dell’area, il posto pullulava di soldati tedeschi: nessun uomo si sarebbe mai sognato di andarci. Nei mesi dello sfollamento, infatti, proprio in questo punto si snodava ogni giorno una lunga coda di donne composte e silenziose, in attesa del proprio turno per poter raccogliere in una secchia qualche litro d’acqua di mare. Una volta portatala ai monti, se fossero riuscite a passare indenni gli sbarramenti germanici, l’avrebbero fatta bollire o evaporare in un lattone, ricavandone, forse, un preziosissimo pugno di sale grezzo.
Nei lunghi mesi dello sfollamento, poi, particolarmente complesso si rivelò il procacciamento del sale, genere indispensabile alla dieta, divenuto introvabile sul mercato già dalla primavera del ’44: agli sfollati versiliesi, non rimase altra scelta che ricavarlo dall’acqua di mare. In vista dell’avanzata alleata, tuttavia, l’Organizzazione Todt aveva provveduto a minare l’intera fascia costiera versiliese, lasciando sgombero dagli ordigni soltanto un unico, stretto corridoio di spiaggia presso la foce del fiume Versilia, vicino alle fortificazioni del Cinquale. Data la rilevanza strategica dell’area, il posto pullulava di soldati tedeschi: nessun uomo si sarebbe mai sognato di andarci. Nei mesi dello sfollamento, infatti, proprio in questo punto si snodava ogni giorno una lunga coda di donne composte e silenziose, in attesa del proprio turno per poter raccogliere in una secchia qualche litro d’acqua di mare. Una volta portatala ai monti, se fossero riuscite a passare indenni gli sbarramenti germanici, l’avrebbero fatta bollire o evaporare in un lattone, ricavandone, forse, un preziosissimo pugno di sale grezzo.
Le donne dovettero infine affrontare il difficile compito della protezione dei familiari in caso di rastrellamenti nazisti. Sui villaggi della montagna versiliese, le SS piombavano all’improvviso, rivoltando ogni centimetro degli alloggi, in cerca di uomini e ragazzi da portar via. In un clima di puro terrore, spesso con figli e mariti nascosti in soffitta o appena sotto le assi del pavimento, ancora una volta stava alle donne riuscire a dissuadere i soldati dal compiere ricerche più approfondite, ricorrendo a tutti i diversivi e le doti mimiche del caso, pur di riuscire a salvare le vite dei propri cari. Naturalmente, gli sforzi potevano benissimo risultare vani, e costare anche la vita.
Maria Antonia Quadrelli, nel 1944, aveva tredici anni. Quando giunse l’ordine di sfollamento, dovette abbandonare la sua abitazione delle Prade (Seravezza, Lu), e sfollare, assieme alla madre, alla zia e ai suoi cinque fratelli, nel villaggio montano di San Carlo Po, all’epoca nel comune di Apuania. Ancora oggi, l’anziana signora ricorda bene le drammatiche incursioni notturne delle SS, che penetravano con la forza nelle case in cerca di uomini da rastrellare (la sua vivida testimonianza è consultabile fra i “Materiali collegati”).
A buon diritto, dunque, è lecito affermare che le vere protagoniste dello sfollamento in Versilia furono le donne, che si rivelarono infatti scaltre e coraggiose, ben determinate ad “agire nel mondo” per difendere la vita e la sopravvivenza delle proprie famiglie e delle proprie comunità.
Federico Bertozzi, laureato in storia contemporanea presso l’Università di Pisa, si occupa di storia della seconda guerra mondiale, con particolare attenzione alle esperienze dei civili in guerra e alla raccolta delle loro memorie. Recentemente ha pubblicato per Pezzini editore, “Attaccarono i fogli: si doveva sfollà!” – Indagine storico-antropologica sull’esperienza dello sfollamento in Versilia nella Seconda Guerra Mondiale.
Articolo pubblicato nell’agosto 2014.